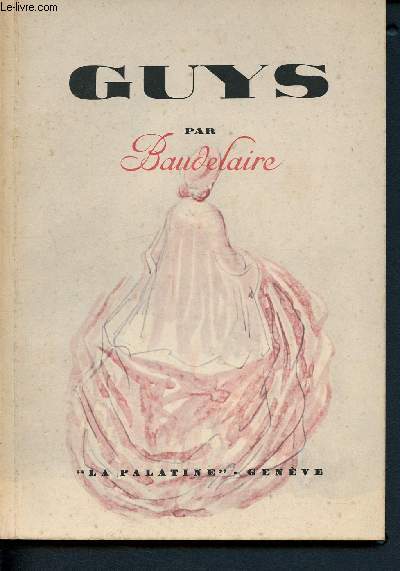RETE NERA
(Non esiste umiliazione peggiore di quella inflitta dal denaro)
SECONDA PARTE

**
Per chi apprezza il volo dei gabbiani e vede figure dentro la ruggine di un tombino, fingere interesse per un personaggio famoso, una statua o un episodio storico, sempre gli stessi, è un tormento. Guido un gruppo di turisti che ho appena raccolto sotto i portici di Piazza ***.
Come una specie di Caronte li raduno, faccio l’appello, li conto, poi spiego il programma. Ho due ore per farli girare. Indico e parlo, a volte con l’aiuto del microfono da cui esce una voce che riconosco a stento. Gracchio come un vecchio transistor, strido.
Il mio gruppo sarà liberato nell’ora di pranzo e recuperato verso le 3, poi smistato verso il mezzo che li ha trasportati dove farò un nuovo appello, perché non è raro che qualcuno si perda e ritardi.
Questo è il pacchetto N. 1: si parte da Piazza ***, si gira intorno a Palazzo ***, si entra nel cortile maggiore del palazzo, si imbuca Via ***, si arriva in Piazza ***, si visita la Cattedrale di ***, si prosegue per Via ***, si devia verso Palazzo S. ***, e il giro si conclude in Piazza ***.
Guardo il gruppo che mi aspetta sotto i portici di Piazza *** e mi avvicino. Loro sorridono, spesso ridono, ridono molto e non capisco quasi mai perché. Faccio del mio meglio per essere professionale: affabile, gentile, paziente… fingo anche interesse per l’uno o per l’altro, ascolto qualche domanda, cerco di ricordarmi qualche faccia, un vestito, un paio di scarpe o un’andatura strana. Il gruppo non si dispone mai in colonna, mi segue come un cerchio in movimento e a turno qualcuno spezza il cerchio, guadagna qualche metro su di me o sugli altri, come fosse una specie di gara. Se il gruppo si sparpaglia li richiamo, grido nel microfono con sgradevoli effetti di rimbombo.
La voce rimbalza di facciata in facciata, viaggia per centinaia di metri e poi si spegne, ma non si sa mai né quando né dove.
Ho regolato male il piccolo amplificatore che adesso esplode in una tremenda cacofonia: sparpaglia i piccioni e paralizza i miei turisti per un attimo. Poi ridono, ridono molto, tossiscono e mi seguono.
*
Non vorrei portarli in Piazza ***, l’ho vista migliaia di volte e ne ho parlato tanto da farmi venire la nausea. Allora, qualche volta, invento, sposto una data, inserisco un oggetto, un colore, indico uno spazio che non esiste più come se esistesse ancora. Lo faccio in fretta, fra una notizia e l’altra, so che non se ne accorgono i poveri turisti troppo presi, ma da che cosa? Di sicuro pensano a quello che mangeranno, poco a quello che vedono, molto alle cartoline, ai ciondoli, alla paccottiglia di cui riempiono gli zaini, afferrano qualche parola, una data, un nome, guardano una grande vasca, un colonnato, guardano il mio dito, non quello che indica. E ridono, ridono molto. Uno mi chiede quando andremo a vedere i pesci. Ma non andremo a vedere i pesci, perché il pacchetto N. 1, il loro, non li comprende. Così consiglio di comprare le cartoline con i pesci che non vedranno, con una sfera di plastica sporca che non vedranno, col tramonto sul porto che non vedranno.
*
Qualche volta, per non pensare al giro che ho fatto mille volte, per non guardare le chiese e le piazze viste mille volte, guardo i miei turisti, e mi chiedo che cosa stanno guardando, a cosa pensano, che cosa provano quando il vento sposta le vernici spray, le narici pizzicano e la pelle prude come quando si entra in una carrozzeria e la gola diventa acida respirando smalti e solventi. O quando l’aria trasporta il grasso del kebab, la famosa trottola di carne, e ristagna odore di bollito. Oppure si saranno accorti, mi chiedo, delle saracinesche sotto i portici, quattro, alte ben più di tre metri, con la cornice di marmo, una mezza luna a vetri, imponenti, chiuse da anni, corrose e sbriciolate dalla ruggine?
Siamo di fonte alla chiesa di S. ***, ingabbiata da ponteggi che formano una seconda facciata, uno scheletro lieve e profondo, nuovi piani orizzontali e verticali, nuove graticole.
I leoni non si possono più cavalcare ma qualche bambino si è infilato fra i tubi, ha raggiunto la groppa, chiama qualcuno perché lo fotografi, e il rodeo inizia.
*
I miei turisti non mi sentono. Non mi sentono perché sono tutti seduti a pochi metri da getti d’acqua, quei sifoni chiassosi disposti a decine intorno alla vasca di Piazza C.
*
Sono pennacchi liquidi, spruzzi le cui gocce volano a decine di metri quando il vento soffia; e quando soffia tramontana le gocce sono gelide.
“Guardate, grido nel microfono, la statua equestre davanti al Teatro ***, l’angelo col braccio spezzato, la griglia accanto alla Chiesa del ***a cui sono appese bambole e immagini, come in un rito voodoo, ascoltate la lettura del fine dicitore, sempre uguale, che i versi siano di *** o di ***, il lamento del mendicante, lo scroscio dei sifoni che vi assorda.”
Uno dei miei turisti si fotografa da ogni angolazione, ha le scarpe blu cobalto, uno zaino floscio, un sorriso idiota. Non ha sentito niente.
Passa un uomo calvo simile a una lumaca senza guscio, ingobbito.
*
Possiamo guidarli alzando un’asta con la bandierina o un fiocco, un ombrello, una racchetta numerata. Per raccoglierli, basta un fischio, un gesto perentorio dell’asta e il corteo che stava per sbandare si ricompone subito.
Adesso siamo in Piazza ***. Quella è la chiesa di S. P. in *** che fu quasi distrutta dall’aviazione alleata, come la Loggia di ***. Una foto presa dall’alto mostra il suo stato subito dopo i bombardamenti: macerie, fumo, travi annerite, pietre, e vetri esplosi. Come una specie di perno monco, tuttavia ancora dignitosa, quasi al centro, la statua del Conte di *** s’innalza sui detriti.
*
Ogni tanto incontro altre guide, certe le conosco, altre no. Sono molte, e di anno in anno il numero aumenta. Facciamo tutte gli stessi giri, diciamo le stesse cose, facciamo il compito per le agenzie così come lo impongono i diversi pacchetti. Siamo tutti professionisti, professionali, educati, attenti, rispettosi, tolleranti, tutti – a denti stretti. A denti stretti teniamo in gola, tutti, quello che vorremmo dire, quello che pensiamo su turismo e turisti, sulla città, sui padroni della città per i quali non siamo in pochi a lavorare. Ad esempio vorremmo dire che la bolla di plastica è sconcia, fa urlare uccelli tropicali, e che sbatti sempre il mostro in prima pagina su cartelloni giganteschi è disgustoso, come le sequenze di gabbie di vetro, sedie e tavolini neri, tutti uguali, come le panchine disposte a corridoio, l’orizzonte a ponente senza aria e senza luce, le innumerevoli ringhiere, cancellate, transenne, sbarramenti, delimitazioni, reti, divieti, restrizioni. E che spesso l’aria del porto puzza di smog. Il porto antico… e le sue statue o steli, una dedicata a ***, l’altra a ***, una sotto vetro, una scomparsa. Come le panchine della darsena: schiodate, spostate, usate come dormitorio o circolo, panchine circolari disposte a cerchio, appropriazione di uno spazio pubblico non difeso, e alla fine rimosso.
*
Il gruppo che raccoglierò fra pochi minuti, fa parte del Pacchetto N. 2 che è
quasi uguale al Pacchetto N. 1 ma concede, a pagamento, un’ora in più. Il giro è quello del Pacchetto N. 1, l’ora in più sarà dedicata agli acquisti: lascerò che il gruppo si sguinzagli e si soddisfi comprando le stesse cose che troverebbe in decine e decine di altre città del mondo. Ma comprarle qui deve avere un altro gusto, un sapore di qualcosa che mi sfugge. Forse traggono calma, sicurezza, e si sentono parte di un grande gruppo sapendo di comprare quello che migliaia di altri turisti comprano in tutte le parti del mondo.
Oggi li porterò a vedere la pietra più scura del lastricato di Piazza ***, spiegherò perché è più scura, racconterò che sotto quelle pietre scorrono due torrenti, perché la Piazza ha il nome che ha, farò notare la chiusura di tutti i piani terra, la cancellazione delle finte architetture, la chiusura con vetrate della Loggia di ***, gli attuali banchi sproporzionati allo spazio, invadenti. L’effetto di uno spazio dilatato non esiste più. Ora la piazza è compressa, intasata di oggetti, carrelli, voci, ponteggi, sbocco di quattro strade principali e due stretti vicoli, è un piccolo bacino che riceve troppa acqua, l’ultima tacca di livello resta quasi sempre sommersa a conferma di una “vocazione” a straripare, riempire, tamponare, accumulare.
Sull’angolo fra Piazza *** e Via degli *** con un berretto di lana rossa calcato quasi sugli occhi, un uomo corpulento, seduto sopra uno sgabello piccolo, comprime e dilata la sua grande fisarmonica, rossa come il berretto. Suona un valzer ossessivo, si appoggia a una saracinesca chiusa da dieci anni, a un cartello stradale imbrattato di scritte, batte il tempo con una grande scarpa a punta sformata. Da venticinque anni suona in diverse zone della città. Suona anche il violino, amplificato come la sua fisarmonica che rilascia un suono remoto e stridulo, come un addio interminabile pronunciato da una voce roca.
Passa un carrello velocissimo, s’incrocia con altri mezzi, scansa i passanti, sfiora una donna accovacciata contro una saracinesca chiusa da un paio d’anni: la vedo tutti i giorni; dipinge acquarelli su cartoni recuperati, è sporca, a volte ubriaca, si raduna intorno qualche borsa e l’occorrente per dipingere. I soggetti sono banali, ma una specie di vortice, un marrone trasparente e insieme fangoso, una prospettiva insolita, riscattano il luogo comune. Posati sul selciato, sembrano assorbiti dalla pietra, eppure una luce li stacca, li solleva: è un chiarore oscuro, una tempesta sul mare, tempesta lontana.
*
Quella forma che vedete sott’acqua, posata sul fondo, è una mano o meglio un guanto giallo pieno d’acqua; l’acqua lo ha riempito e gli ha dato forma e stabilità. Poggia come una piccola statua ben sicura sopra la sua base.
Sotto il pontile c’è una specie di manubrio rosso legato a una corda, forse il manubrio di una bicicletta per bambini che ondeggia monotono, lento, fra alghe, spazzatura, piccoli, affollatissimi branchi di cefali.
Poco più avanti, in fondo a una breve scala che scende nell’acqua, c’è un anello a cui sono legate corde, catene. Vedrete spesso questi frammenti di ormeggi, lamiere smangiate, a volte barche capovolte da decenni ancora trattenute alla banchina da una corda.
*
Ma adesso guardiamo lo spazio dove sorgeva il gigantesco cavallo di cartapesta. Era dietro queste sbarre, dentro questa chiesa senza tetto: era un pezzo di scenografia, ma nessuno ricorda di quale spettacolo. Al posto del cavallo oggi c’è un gruppo di ragazze che salta. Verso l’abside, vediamo un daino blu, di cartapesta, alto circa 8 metri. Una donna grida ordini, una lamiera stride, un uomo barbuto tende un cavo nero.
Qui sorgeva una coltivazione idroponica, una specie di serra dentro una piccola rimessa di metallo chiusa da vetri. Una solida gabbia blu, una specie di container.
Sotto i cornicioni vediamo l’affresco – quel che rimane dell’affresco – di un volto: né uomo, né donna; né giovane né vecchio. Resta un occhio truccato, femminile, una cravatta maschile, la bocca crollata nel suo stesso rosso.
Davanti al bastione, nel secolo ****, fu eretta una statua alta venti metri a imitazione di vari organismi allora viventi, soprattutto acquatici, con qualche innesto di creature di terra. Aveva una mano gigantesca, una base fatta con tubi di acciaio a imitazione dello scheletro di un pesce. Era cava, in certe parti molto profonda.
Ci spostiamo in Piazza ***, la parte più antica della città. Del complesso di San *** vedremo la scalinata, i calchi di organismi acquatici stampati sulle pietre, e noteremo il dislivello, vero salto nel vuoto, una volta collegato da un sistema di saliscendi o calapranzi. Il complesso ospitava attività educative, laboratori, giardini pensili, cavità-dormitorio, raccolte di voci e di gesti. Oggi è rimasto poco o niente. Il poco è quel gesto che vedete inciso nelle pietre, un gesto senza variazioni, forse braccia alzate, sempre lo stesso gesto, come lo stampo di un uomo che corre spaventato.
*
L’ultimo crocefisso ha girato l’angolo sventagliando orpelli di filigrana; tre lo hanno preceduto, davanti al baldacchino che sorregge una Madonna; stanno risalendo Via S. ***, e sono prediche dentro un microfono pieno di interferenze, non diverso dal mio, e non diversa la solita litania, qui turistico-religiosa. I miei turisti scattano valanghe di fotografie, soprattutto autoscatti col crocefisso, il portatore, la Madonna; qualcuno manda un audiovisivo e innesta il vivavoce che replica il rumore della celebrazione come trasmesso da una radio potente e guasta.
*
Devo osservare il mio gruppo che si è mischiato al corteo per non perderli di vista. Allungo il passo e affianco la processione e alzo e agito il mio ombrello bianco in cima al quale ho annodato un fiocco rosso sfarzoso. So dove sosterà la processione, è uno dei luoghi più consumati dalle visite, dai percorsi turistici, dal passaggio, dallo scarico merci, il luogo dove l’aria – sabato e domenica – è benedetta dalle bombolette spray.
*
La pittrice dei vertiginosi paesaggi era accovacciata, raggrinzita contro un portone. Pennelli e cartoni spariti. Sigaretta e tavernello. Di fronte ha una bancarella che vende vera pelle. Di fronte alla bancarella sta rannicchiata in un sudicio piumino, tossisce, guarda dietro gli occhiali, prende una scatola di colori, un pezzo di cartone e inizia a dipingere sempre il solito soggetto ma ogni volta più traballante e ondulato.
È grigia di pelle e di vestiti come il selciato.
Oggi non faccio la guida, non bercio dentro il microfono, osservo e compongo dentro di me e nessuno mi costringe a dire che cosa vedo, che cosa sento, che cosa non vorrei vedere e sentire; oggi non devo alzare la paletta, richiamare all’ordine, sforzarmi di sorridere, elencare date, nomi, episodi. Posso camminare da solo.
*
I capelli di uno sembrano corde tessute da un ragno enorme. Sulle Marittime c’è ancora neve. Molte pietre semoventi, buchi, segnali verniciati, transenne. In Piazza *** hanno tolto l’orologio. C’è ombra, c’è quasi sempre ombra.
*
Dipinge anche fiori. Oggi ho visto tre calle su fondo verde-grigio, unite come tre sorelle che si abbracciano nel giorno che precede le nozze, i gambi fluidi e densi.
In tutti gli acquarelli c’è un mare in tempesta, un cielo livido, una grande pozzanghera che avvolge anche i fiori.
*
Dice sì chinando e alzando la testa mille volte, sputa e non parla con le parole, è sempre accovacciata sui cartoni, sui colori; fuma e ringrazia per l’elemosina chinando la testa di lato. Sembra che ascolti. La gente passa. Un’auto, un carrello, un gruppo. Bagna il pennello dentro una bottiglia di plastica tagliata, lo asciuga in uno straccio, piega le alette di un cartone, confezione di chissà che cosa, e dipinge. Non ha un’aria febbrile, i gesti sono misurati, nessun atteggiamento è ostentato; in realtà non ha un atteggiamento, neppure l’aria di chi si raccoglie, pensa e dipinge.
*
Oggi porto in giro venti turisti sorridenti: hanno il cappello arancione con visiera e una grembiulina blu di plastica. Li raccolgo in Piazza *** dove sono impegnati a fotografarsi, a filmarsi, a mandare i video in giro per il mondo: un altro giro. Grido nel microfono e alzo la bandierina. Esplode un hurrà. Non li ho mai visti. So da dove vengono, ho l’elenco dei nomi, parlo la loro lingua. Ridono. Mi seguono.
“Oggi visiteremo archi tamponati, strisce di cielo, conchiglie impastate nella pietra e onde di marmo. Indicherò dove cadde pugnalato il compositore ***, uno che vende fossili falsi, la straordinaria gabbia di ponteggi, il dedalo di stradine: vero habitat per Minotauri.
*
Per anni ho cercato il Pavone. “Non devi cercarlo dentro palazzi o chiese, è fuori,” disse uno. Non è nei mosaici del giardino di Palazzo ***, e non è lo struzzo o il re Cigno. Forse è una piccola formella di un sovrapporta in Piazza ***, il portone di Palazzo *** sovrastato da statue gemelle, restaurato di recente, bianchissimo. Sotto un braccio monco sbuca una cornucopia. Una foglia è simile alla coda dispiegata di un pavone. Quell’ampio cortile sterrato, sporco, quella bestia di marmo consumata, stanno davanti alla chiesa dei ***, ben riverniciata, di un giallo caldo. Quattro vicoli sorvegliati da edicole votive, madonne e angeli sotto vetro, piccolissime teste sbriciolate, catenelle, trigrammi.
*
Il Covid ha bloccato una nave da crociera al largo; nessun porto, per adesso, vuole ospitarla. Equipaggio e passeggeri: tutti contagiati. Si erano imbarcati sani. Così dice il bollettino. Mare calmo, niente vento, bonaccia, cielo terso, notti stellate. La nave- condominio galleggia nel buio come un albero di natale. Luminarie. Ogni passeggero è isolato in quarantena nella sua cabina, così riferisce il bollettino.
Ricorda la medievale Nave dei Folli. Ma non è esatto; è la Nave degli Imbecilli, quella del Pacchetto N. 3. Ma non arriveranno. Tutte le città portuali li tengono lontani. Così recita l’ultimo bollettino. Faranno la quarantena a bordo ma al largo. Un intero piccolo paese galleggiante e contagiato.
*
La nave contagiata approderà nel porto della città di C., così informa l’ultimo bollettino. Passeggeri ed equipaggio staranno in quarantena al terminal traghetti, così dicono i giornali. Oggi è una bella giornata, identica a quella di ieri, mare piatto, cielo limpido.
Domani sarà come oggi, informa il meteo. Aria tiepida, temperatura superiore alla media stagionale. Il Pacchetto N. 3 isolato in quarantena, così riferisce la stampa locale. Nessun timore. Qualcuno, dopo attenta visita medica, è decollato per tornare a casa. Gli altri, secondo indiscrezioni, organizzano feste a bordo.
*
Oggi mi sono licenziato. Adesso posso scrivere o stare zitto, non quando voglio, ma quando posso. Quando ci si sbarazza di un demone, ne arriva un altro, più forte, più tiranno.
*
I turisti del Pacchetto N. 3 restano a bordo festeggiando. Sbarcheranno solo finita la quarantena. Saranno ben accolti dalla città di C. che ha una lunga tradizione di ospitalità, lazzaretti, quarantene, cimiteri monumentali, corone di alloro, statue, lapidi, targhe, commemorazioni funebri, epidemie, regole anti epidemie non rispettate in passato come oggi.
*
Congedarsi. Senza inchini.
*
Mi colpiscono lo scudo di marmo smerigliato, il capitello e il palazzo su cui sembra calato un colpo d’ascia.
Lo sfregio all’insegna religiosa, all’agnello di turno.
*
Quanta aria impigliata nei ponteggi.
*
Riescono a sedersi anche alla base dei ponteggi e in mezzo ai ponteggi e in numero rilevante formano sui gradini della chiesa di S. *** altri gradini di carne.
*
In Piazza *** uno rimbalza da un piede all’altro restando sempre nello stesso punto, come una molla avvitata al selciato.
*
Il sole fa brillare il collo di un piccione. Un collare viola, come una collana.
*
Anni fa c’era Ulisse appostato in Via ***; sul corpo nudo aveva solo una coperta. Gran barba bianca, dietro a un palo, non molestava nessuno: guardava, stava fermo per ore, sorrideva sbucando dal suo sacco di lana.
*
Città di fantasmi e scheletri, di figure lunghe, scarne e nere che tagliano l’aria con una veloce falcata, di donne avvolte in una veste da cui spuntano gli occhi, un manto nero; si fanno i dispetti, hanno orbite incavate e una pelle scura e insieme livida; dietro l’angolo, girati di schiena, rivolti a una grande loggia vuota e polverosa, con i vetri frantumati, due trattano con parole violente non si sa quale merce; è la città del fiume che trabocca e scardina i tombini e allaga sottopassi e cantine; secchi, scope e fango. Con l’occhio vitreo e sporgente, la pelle come bruciata, fissa un’altra, si fa le sue ragioni, la inchioda alla pietra, e uno allarga le braccia, ruota in cerchio come un aeroplano e sembra felice; è la città dei reperti, animali e umani, delle corone d’oro, foglie d’oro ricamate come un merletto, nastri di metallo dorato, e sotto un fosso, canale senz’acqua, sotto Palazzo S. ***, alti monconi di colonne, un dislivello improvviso, tre gradini ripidi, cemento e spazzatura e tre passeri hanno trovato briciole e uno prende il volo, si affila il becco sul braccio in ferro di una lampada, e la polizia importuna, sono in quattro, e c’è un cancello che non serve a nulla, un bell’oggetto in ferro battuto; nel vicolo stretto e sorvegliato da una statua oblunga incastrata nel muro, sacchi di spazzatura abbandonati, più avanti Palazzo De ***, atrio neoclassico, fontana, testa di leone, fiammate artificiali; con la faccia affilata, annusando l’aria aperta, come uscisse dopo mesi da uno scantinato, s’ingobbisce, sta fermo sulla soglia e poi scatta, fa una mossa come in cerca di una preda, offre un caffè, ride.
Adesso sentirete sonagli come il suono di piccole ossa appese a fili e spostate dal vento, poi esercizi al piano: scale, trilli, acciaccature. Qui, in questa piazzetta, Piazzetta ***, esercizi di canto e non lontano, l’enorme, sempiterna fisarmonica rossa che fiata, soffia, si dilata a ventaglio e si ritrae a fessura.
*
Oggi la polvere di un cantiere si è depositata a ondate regolari, una risacca calibrata, un ventaglio di tracce quasi bianche a distanze prefissate – come un progetto. Sono semicerchi sempre più larghi, partono dai bordi di uno scavo, s’irradiano per decine di metri, finché l’ultima grande sventagliata deve fermarsi davanti alla facciata di Palazzo ***. La facciata di Palazzo *** è piena di angeli enormi scolpiti male: facce gonfie, prospettive incerte, corpi tozzi che sembrano incollati per un lembo di carne e sul punto di franare. Nella Via di ***, di fronte al portone chiodato, altissimo, di Palazzo ***, un rinomato negozio ha in vetrina animali di pelle: un ippopotamo, un cinghiale. Procedendo, vediamo qui a sinistra una macelleria con i vetri scuri, le luci basse, una specie di circolo per iniziati alla bistecca; dentro, uno strano silenzio intimorisce, come il portone di Palazzo *** che ha sporgenze di ferro che trafiggono l’aria.
In cima sbuchiamo in Piazza S. ***. Una sentinella, con la punta della baionetta, incide nel marmo un gioco intricato. Sopra una saracinesca potete vedere un fenicottero rosa dipinto accanto a un teschio, accanto a un tavolino, accanto a grumi di ruggine, accanto a un vetro sfondato.
*
Tolta l’imbragatura, ponteggi e reti, ecco il Barchile restaurato. Sembra un marmo funebre, una lapide. Bianchissimo, non ha più venature né colori: quei gialli spenti e morbidi, un verde-grigio e un bianco caldo, opaco. Dopo mesi è riemerso sfacciato da un bagno di candeggina e stona con lo spazio intorno. Sembra marmo sintetico.
*
Accarezzava il suo cane mentre su entrambi scendeva una specie di cipria grigia. Erano in fondo a Via del ***, via larga, tranquilla, fiancheggiata dalla Chiesa di S.***. Una specie di confine con Piazza ***, piazza frastornante.
Era seduto, era solo, di una solitudine definitiva.
Lo vedevo da una certa distanza, forse 30 metri, ma la distanza era alterata: tutto sembrava più profondo, largo e velato. E silenzioso. Come il suo cane. E neppure lui parlava. Dietro aveva un cancello, una porta di mattoni ad arco. Il cane era un levriero, forse, di un colore violetto smorto. Si muovevano poco. I due non erano in posa, e poteva sembrare. Però erano quasi bloccati, molto lenti. E distanti. Non più piccoli né più grandi: arretravano centimetro dopo centimetro, come su una pedana mobile. E c’era sempre quella nube bianca, quel viola del cane, opaco, che sembrava stendersi, come una pelle conciata, su tutto.
*
Un suggerimento ai turisti: non perdete Via dei ***, se avete lo stomaco forte. Prima di percorrerla, gustate l’ottimo pesto spalmato sulla focaccia che si vende all’angolo con Via San ***, sotto una delle edicole più belle della città. Dopo la degustazione ecco la degradazione, basta fare tre metri e vediamo una grande loggia “protetta” da vetri spessi. In un punto è stata presa a martellate. Sembra un enorme parabrezza spaccato ma che non è volato in schegge. Come un vetro antiproiettile. Contro gli assalti di pennarelli e spray non c’è nessuna protezione. L’interno della loggia è sporco, polveroso, abbandonato da anni.
Via dei *** è un orinatoio a cielo aperto con bottiglie di birra, selciato sconnesso, merda, gradini luridi. Oltre a quelle della loggia, molte altre vetrine, ma dentro non troverete nessuna esposizione. Sono vuote, senza saracinesca, da anni esibiscono il niente sporco. Anche il vecchio parrucchiere ha chiuso, e una cartoleria storica ha chiuso. Ma c’è una bagascia – quasi un’istituzione – con un nastro rosso fra i capelli neri, un’acconciatura che ricorda Minnie, scarpe lucidissime col tacco squadrato. È quasi sempre aperta. Staziona sull’angolo, come le vergini, ne ha una sopra la testa, quella senza statua, e al posto della madonna c’è un ritaglio a forma di aeroplano. Si appoggia a un muro annerito, accoglie i clienti nel palazzo di Vico *** dov’è nata Santa *** – così ricorda una targa posta accanto al magnifico portale.
Via dei *** si biforca: a sinistra sbuca in Via ***, a destra sale in Vico ***. Qui abbiamo una trattoria storica, La ***, e a fianco un punto di raccolta rifiuti. Il via vai dei mezzi per la raccolta dei rifiuti, la disinfezione del selciato, la consegna della spazzatura è molto frequente. Vico *** inizia stretto con ristagno di odori non del tutto piacevoli.
*
Sui vetri frantumati della grande loggia possiamo leggere diverse scritte del primo ventennio del XXI secolo: La peste suina è l’uomo. Il virus è l’uomo. ACAB. Non vi sfugga un adesivo che raffigura un cinghiale, un cuscino rosso incastrato fra palo e muro, la cupa penombra, i rigagnoli scuri, una rosa di plastica impolverata, qualsiasi superficie a portata di pennarello e spray imbrattata. Un’intricatissima rete di scritte, simboli, figure, macchie, numeri.
*
Dalle lettere di un viaggiatore francese del XX secolo:
Caro ***,
oggi sono arrivato nella città di C. Il porto sembra piccolo e insieme enorme. L’insenatura o golfo naturale dove sono sbarcato, è un incrocio vertiginoso di bacini, moli – alcuni enormi – gru, imbarcazioni – per lo più una simile all’altra – passerelle, chiatte, costruzioni di ogni genere formano una rete inestricabile dove anche le imbarcazioni stanno, per così dire, gomito a gomito. L’aria è limpida, tiepida al sole, fredda e umida dentro le viuzze o vicoli. La città, dopo qualche giro, sembra una copia del porto: convulsa di spazio – assenza di spazio – contratta, rumorosa.
Dal mare, lo spettacolo di un imponente agglomerato di edifici che precipita in acqua lascia senza fiato. Le case si arrampicano sui monti; sui crinali si arroccano paesi, fortificazioni, una lunga, sottile muraglia, santuari, chiese, strane torri – e dopo il cielo.
Il porto copre la costa, nel senso della lunghezza, per molti chilometri: verso levante e verso ponente il mare quasi non si vede.
Qui si cammina su belle pietre sconnesse, fra palazzi altissimi appoggiati uno sull’altro, avvitati uno dentro l’altro. La materia più diffusa è il marmo; sovrabbondante nei palazzi e nelle chiese. Poi l’ardesia. La città sembra talvolta una fotografia in bianco e nero: ci sono chiese e palazzi a strisce bianche e scure, colonne bianche affiancano colonne nere. Tuttavia non è una città grigia: trionfano i trompe l’oeil dai colori accesi. Le figure di palazzo San *** squillano la fanfara del giallo, per esempio. E gli interni sono una foresta di grottesche, sfondi blu cobalto, fiori, piante, animali dai colori saturi, come diapositive polarizzate e intorno – scale, colonne, balaustre, gradini, capitelli, pavimenti, statue – il marmo onnipresente, smagliante oppure opaco o policromo, come nei bellissimi intarsi della cattedrale.
Se verrai nella città di C. non mancare la visita alla cattedrale e osserva le cappelle laterali: soprattutto gli altari – non per i dipinti ma per i marmi.
Caro ***,
a palazzo *** ho potuto vedere un piccolo busto di Balzac, ben conservato, di autore ignoto, poggiato sulla lunghissima mensola dorata di uno specchio enorme con la cornice piena di stucchi, volute, putti dalle guance gonfie, tutta una decorazione tronfia, insopportabile. Il povero piccolo busto deve temere questo pesantissimo sfarzo; anche il vetro spesso, brunito in alcuni punti, sembra sfondare la cornice, per quanto poderosa sia, e scricchiolare. Il busto è pregevole ma come smarrito, già sconfitto dal rapporto di scala e peso.
*
Avete a disposizione un’autentica città- mostro, The Big Freak, un grande luna park con la donna barbuta, il cane a due teste, i siamesi, l’uomo sigaro: è la città sognata da Tod Browning, ed è la città dove tutti e tutto sono rappresentati, mischiati, agglutinati: vestiti, lingue, etnie, cibo, festival, artisti e giocolieri, mendicanti, colori, unione dei colori, stati uniti del colore, la vera città multietnica, multistrato – dallo splendore alla miseria scendendo pochi piani, dallo sfarzo alla mendicità giusto dietro l’angolo. Qui vedrete il pit bull dalla testa gigantesca appostato davanti alla storica gelateria, la demente votata al cattolicesimo bofonchiare in via dei ***, la ragazza col pappagallo sulla spalla, gli animali fatti di cuoio – cinghiali, carlini, maiali – a 400 e 700 euro, foulard a 800 euro. Tutta la città vecchia è un baraccone. Una si porta a spasso 8 cani, ne incontra un’altra con due, e i cani si azzuffano e loro ridono tra una foresta di gambe e zampe, scarpe colorate, polpacci tatuati, capigliature viola o verdi, ascensori panoramici, sbarre enormi puntate verso il cielo.
*
La ruota panoramica. La sfera biologica. L’alluce della statua. Il sandalo. Il piede di un camminatore. Un giorno un cane alzò la gamba sopra il sandalo… Le mura idrodinamiche. Una fila di palme oggi oscilla, i tronchi sottili sono scossi. Il vento forte stacca i cappelli e abbatte, i gabbiani sono superbi, eccitati. Il Mercurio giallo è screpolato, dalla cornucopia escono fogli di intonaco, l’aria ha il sapore del kebab e del fritto. Scende una squadra da via San *** sotto striscioni che schioccano.
*
In via San ***, tutte le domeniche, per molti mesi, si è potuto vedere un ragazzo fare la spola da un bidone all’altro: frugava, rovesciava, raccoglieva i gratta e vinci usati, li guardava uno per uno, li smistava, li metteva da parte, poi li buttava e passava al bidone successivo. Faceva un percorso a zig zag fra i due lati della via, era come in trance, alto, pallido, biondo, molto giovane, instancabile nella ricerca del biglietto vincente gettato via per caso.
*
Per anni il suk abusivo ha invaso il porto antico, forse qualcuno ricorda le corse, le fughe coi borsoni, enormi fagotti fatti coi lenzuoli con i quali era difficile correre e che cascavano a terra, il grande nodo si scioglieva spargendo mercanzie di ogni tipo: vestiti, scarpe, bigiotteria, chincaglieria, libri, tappeti, orologi, ogni tipo di oggetto, giacche, giubbotti, scarpe sottratte agli staccapanni presi d’assalto, rovesciati, dove s’infilavano a testa in giù e rischiavano di soffocare e da cui emergevano con autentici tesori per pezzenti. E questo è durato anni. Erano centinaia, un formicaio che si disperdeva inseguito dalla polizia, poi s’infilava all’interno, mentre qualche moto schiacciava per disprezzo la merce in attesa degli spazzini.
*
Vendevano anche marchi falsi e li vendevano bene: borse, scarpe, portafogli… erano tollerati con qualche intervento della polizia che per un’ora li allontanava, non requisiva la merce, e la gente del suk si appostava e osservava a poche decine di metri e poi ritornava a stendere i lenzuoli su cui esponeva la merce con un bel senso della composizione.
*
Poi si sono spostati verso Via S. *** sopra la metropolitana, in una strada non di passaggio, un largo corridoio senza uscita.
*
Passa un furgoncino della spazzatura, sobbalza e spruzza un turista di acqua e disinfettante. Sulla coscia appare una chiazza di umido. Il turista storce il naso, fissa la chiazza, avvicina un dito con estrema cautela, sfiora i pantaloni, bofonchia qualcosa. Parla con altri turisti, un occhio incollato alla gamba e storce di nuovo il naso.
*
La famiglia più potente della città di C., i ***, di cui vedete le magnifiche dimore, ebbe il suo rappresentate più famoso in ***.
Di recente, in una biblioteca di ***, è stato scoperto un documento singolare, straordinario, attribuito a ***, che riporta un sogno del grande navigatore. È redatto in una lingua mista di ligure e latino.
Il più potente dei ***, nell’anno ***, nel mese di ***, fece questo sogno: «Vedo una galea dentro una bottiglia. La galea è una riproduzione esatta della mia, completa di equipaggio: 350 uomini come miniature, e tutti in movimento frenetico alle vele o ai remi per affrontare un cambiamento improvviso di vento, nuvole scure e pesanti che minacciano tempesta. Sento il mare che si alza, urla e sbatte onde lunghe contro lo scafo. Adesso anch’io mi ritrovo a bordo, sono dentro il vetro, e vedo che la bottiglia ha una venatura piccola sul fondo. A un certo punto, uno dei gentiluomini entra nella mia carrozza e dice: Capitano, l’equipaggio m’informa che i viveri sono finiti da tre giorni e anche l’acqua scarseggia. Hanno aspettato a dirmelo perché temevano di importunarvi. Capitano, l’equipaggio vi ama e vi teme, voi lo sapete, sopporterebbe qualsiasi cosa per voi. Ma rosicchiano il legno di nascosto, succhiano il cordame e masticano la tela. Sospetto che il cibo manchi da molto più di tre giorni. Poi sento un rumore come un corpo caduto in mare.
Mi ritrovo sdraiato nel mio letto, circondato dal capitano delle fanterie, dai gentiluomini e dall’alfiere: tutti silenziosi e raccolti; chino sul mio volto, il cerusico- barbiere mi scruta e scuote la testa. Mi sento invecchiare in fretta: le membra fiacche, la pelle appassita, gli occhi umidi ma senza pianto. Ora il cerusico mi volta le spalle e la sua schiena sembra lo scafo di una nave nemica da cui spuntano cannoni orientati verso il mio letto. Dentro la mia armatura, penso, il mio corpo invecchia più in fretta. Perché mi hanno lasciato l’armatura? Questo involucro mi trascinerà sul fondo, non sarà più una protezione ma la causa della mia morte e il custode effimero del mio cadavere fino alla ruggine, ai buchi, allo sfascio. Temo una congiura e non posso parlarne, l’acqua ha raggiunto l’ultima tacca di livello incisa nel legno del mio letto e la parte viva è quasi sommersa. Fra poco le onde copriranno il ponte, l’acqua inzupperà le lenzuola, entrerà nella mia armatura. Sento l’equipaggio masticare il legno della porta, le nuvole sono sempre più scure, il mare sovrasta la murata; i cannoni nascosti dentro la schiena del cerusico hanno già sparato, e la mia cabina è piena di fumo, urli e schegge. “Avete vissuto molto a lungo – sento dire – siete carico di onori, di enormi ricchezze; avete fatto la Storia. Non avete più nemici. Perché resistete ancora? Abbandonatevi all’acqua”.
**







**
Il portone ruota sui cardini: ha un rumore che ho sentito così tante volte da poterlo imitare con una certa verosimiglianza. La vernice verde si stacca, l’umidità incurva il legno, mangia e sbriciola il telaio di ardesia. Le scale sono irregolari, strette, un gradino diverso dall’altro per altezza e lunghezza, con diverse pendenze da ballatoio a ballatoio. Sono sbreccati, i gradini. L’intonaco cade a pezzi o sfarina. La ringhiera di legno è talmente attaccata alla parete che non si riesce ad appoggiare la mano e così si sfrega il muro, si striscia, portando via macchie di bianco. Oggi davanti al portoncino c’era un gruppo di turisti pigiati fra un muro e l’altro: guardavano l’edicola votiva sopra il portoncino, un’edicola col santo dei maiali in ceramica, una povera edicola grezza decorata da un fiore finto. Sembravano ammirati.
*
Una sera, in Via S. ***, organizzarono le corse dei cani. In quel periodo abitavo lì, sopra Via S***, fra Piazza *** e Via S.***, non lontano da Via dei ***.
Quella sera, sotto il mio palazzo, sentivo abbaiare più del solito ma in un modo diverso: i cani sembravano molto eccitati, eccitati e trattenuti; ma non capivo da che cosa. Dal fondo del forte brusio di tutte le sere si staccava qualche voce: “Fra poco… non ancora… metti il tuo sulla linea… tienilo per la coda e lascia che si tenda come una corda…” I latrati raddoppiavano. Non vedevo ma sentivo. Da quel lato non avevo finestre. “Darò il segnale con un colpo di gong,” disse un’altra voce.
E il gong diede il segnale e i cani partirono. Quanti potevano essere? Dal furioso abbaiare e dalla risonanza tipica dei vicoli, sembrava il serraglio di un canile scappato tutto insieme, sguinzagliato, affamato, come andasse a caccia. La gara era accompagnata dal suono dei tamburi, tipico di tutte le sere fino a notte fonda. Sentivo ridere e urlare. C’erano state scommesse e qualcuno doveva incassare le puntate perché un’altra voce diceva: “Dateli a me, li raccolgo io.”
Non durò a lungo. Una mezz’ora. Dopo cominciò a piovere e ci fu silenzio, ma non per molto. Rifugiati sotto i portoni o sulla porta dei locali, ululavano e guaivano, ma non erano i cani. Gli ululati si trasmettevano da un portone all’altro, da un punto all’altro, con domande e risposte, come un responsorio fra lupi, ma sembrava organizzato, era un codice, segnalava qualcosa. Sul fondo, verso l’alto, i tamburi continuavano, sembrava una processione diretta verso i monti.
*
Sentite questo boato sordo, continuo, questo clamore soffocato, questo vociare che non ha punti di fuga e s’impiglia e rimbalza contro i palazzi e i ponteggi e gli altissimi portoni e rimbomba come se fossimo dentro un labirinto di caverne: l’orecchio di Dionigi diventato città.
*
Bisogna demolire un mito, un’immagine che non corrisponde al vero. Nella città di C. il verde c’è, basta cercarlo in mezzo alle auto, fra un magazzino e l’altro, fra un cubo di vetro e di metallo e l’altro o dentro un cubo di metallo. Guardate quel posteggio, coperto da una cupola di platani, o le piante aromatiche dentro una gabbia di vetro e metallo. E tutti quei denti di leone? E i capperi? E le graziose composizioni di petali a forma di cuore, un po’ marce, a volte composizioni con le carote, offerta e putrefazione, Flora, cornucopie, abbondanza?
*
Qui, alla fine di Via di ***, entriamo sotto un arco la cui volta è quasi nera, sbucciata, come la pelle della pietra quando è aggredita a lungo dalla fiamma. Al centro della volta una lampada dal vetro opaco, accesa anche di giorno, sporca.
Ora siamo in Piazza delle ***, una chiesa gialla e un accenno di quiete, rampicanti intrecciati a lunghe sbarre, piante grasse, girandole colorate e un cane coi testicoli grandi quanto la testa, a pelo corto e grigio, si è sdraiato al sole; a destra vediamo una via larga, scura, con linee convergenti come un cuneo piantato dentro un’altra strada, Via del ***, dove il colore dominante è il rosa, il rosa del grasso e il rosso della carne e poi il nero, il nero delle facce e dei corpi – l’ombra cupa spegne tutti i colori della frutta. Quel palazzo laggiù, nella mansarda, diventò una piccionaia: vista magnifica sul porto, centinaia di ali, migliaia di escrementi accumulati. Quel locale serve una magnifica specialità messicana – accanto vediamo una serie di portoncini, i famosi bassi, e rami di alloro infilati nei tombini. Un po’ più avanti, nel 1***, un corpo già a terra fu imbottito di calci, tanti che lo si pensava morto. Invece il corpo si alzò, era agile, corse via, imboccò l’arco sotto il quale siamo appena passati. Era una scia nera, velocissima, sparì in un batter d’occhio.
Qui, dietro quel portoncino azzurro, s’indovinava il futuro, si leggeva la mano, si facevano le carte, si guardava il mutamento dentro le viscere dei piccioni. A quell’incrocio, oggi con semaforo, la notte era animata da colpi di tosse cronica, richiami rauchi, lamentele interminabili di clienti insoddisfatti.
Di giorno le case si riempivano di smog: uno strato di fuliggine ricopriva le mensole, gli scaffali, risaliva al soffitto, anneriva affreschi, stucchi, dorature.
*
In pochi metri il passaggio a un caldo eccessivo richiede accorgimenti, preparazione.
Si arriva dopo ore di vagabondaggi all’ombra fra pietre umide e l’abbigliamento è poco adatto al sole delle 14.30, sole a cui si sottraggono anche i piccioni che frullano tra mensole e imposte, dentro edicole vuote, negli innumerevoli buchi, spaccature, archi dove fuggire la calura. Spuntano solo le teste, a volte, a volte stanno in bilico, compressi sopra una sporgenza quasi invisibile, grigia come loro. Lì dove adesso c’è un negozio di *** sorgeva una birreria famosa. Erano i primi anni del ***, e un ingegnere svizzero, geniale imprenditore, a cui rubavano i brevetti, aveva inventato un modo per pastorizzare la birra e tenerla ghiacciata. La sete gli aveva fatto nascere l’idea, la voglia di una birra fredda d’estate. Il successo del locale della città di C. non fu un fenomeno isolato: il geniale imprenditore aprì lo stesso tipo di locale in quasi tutte le grandi città italiane; dopo partì per Londra lasciando lo sfruttamento dell’idea e i considerevoli guadagni ad altri. Morì povero. Se oggi potete bere una buona birra ghiacciata lo dovete a lui, ricordatelo, alzate il boccale, e brindate al suo nome!
*
V’incanta e vi sorprende quella nicchia azzurra con la piccola lanterna storta, qui, in un vicolo che ha un nome aromatico, fragrante, dove il mattone, con una lunga e larga striscia, sostituisce la pietra? Vi attira quel vuoto, col fondo blu cielo, il falso capitello di plastica, o il vicolo chiuso dove ronzano i cassoni e sgocciola la condensa? Siamo a pochi metri dal rumore scomparso dell’acqua, non del mare. Siamo a pochi metri da una piazza rumorosa, trafficata, eppure qui, in questo angolo, sotto questa edicola priva di statua, è come essere nascosti, protetti. Il rumore diventa sommesso, come l’acqua sotterranea su cui camminiamo.
*
Con i vostri navigatori elettronici, perché chiedere una guida, indicazioni, dov’è questa piazza, o quella strada, quell’incrocio, quella svolta, quei truogoli, quella scalinata, il porto, la salita delle ***, la famosa barberia? Sinistra, destra, avanti ancora per 15 metri, girate su voi stessi, tornate all’altezza di Via ***, svoltate in Piazzetta ***, proseguite in cerchio, scandisce la voce elettronica. Fissate la mappa, guardatevi intorno, non chiedete a nessuno, fate da soli, ascoltate la guida elettronica, seguite i consigli, fermatevi dove vi dirà che dovete fermarvi, ascoltate quel che vi dirà dovete ascoltare, guardate il palazzo che dovete guardare, girate intorno alla statua di ***, annusate l’odore di zolfo, guardatevi la mano, fate squillare il telefono, tirate la campana della giostra, suonate i tamburi, mangiate focaccia, farinata, fritto, torte, focaccia col pesto.
*
I cormorani sono andati via, sono arrivate le rondini; i pappagalli non scendono mai al porto, il gallo segnavento è immobile sulla torretta del castello ***. Le statue hanno le natiche flosce, i piedi deformi, le serre sprofondano, il rio ***, che sfocia alla darsena, ha sottratto terra. È il tempo di raccogliere le fave, l’aglio rosso, gli asparagi selvatici, è il tempo di arrivare al cancello prima che chiuda. Grifoni. Scudi. Foglie di ferro battuto arrugginite, imitazioni, marciapiedi affollati, tovaglie bianchissime sotto luride arcate.
*
Entrando nella chiesa della ***, appena inizia la navata sinistra, c’è una lapide in marmo dov’è inciso con discrezione un fiore dai petali ampi e ondulati, forse una rosa. Qui, camminare accanto a chi è spento da secoli, è un gesto gentile, lieve. Non c’è niente di monumentale, sfacciato, chiassoso: il morto non opprime il vivo e viceversa.
Dentro la stessa chiesa, in fondo alla navata destra, un crocefisso del secolo **** in legno scolpito e dipinto, aguzzo e sinuoso, scuro nel volto e nel corpo – lunghe le dita dei piedi e delle mani. Crocefisso non è esatto. Il corpo è inchiodato a un palo a T com’era abituale a quei tempi. Il torso inarcato ricorda una piccola botte.
Un piccolo santo in volo, inciso nel legno, il corpo perfettamente orizzontale, trasporta sulla schiena la croce e la trattiene con la sinistra, mentre la destra sostiene per il nodo una sacca sospesa nell’aria. Il santo è girato verso di voi, ha il volto lieto.
Tutti gli altari sono accesi da marmi policromi: intarsi, balaustre, riquadri, marmi verdi con venature fittissime come ragnatele, simboli in marmo giallo, rosso, un artigianato ben superiore a tutte le enormi tele: banali, manierate, cupe.
*
Osservate bene quella giovane coppia che indossa un completo identico a un pigiama, stirato perfettamente, lucidissimo, giacca a doppio petto, capelli impomatati, scarpe-pantofole di un blu acceso, andatura dinoccolata. Poi ecco un mussulmano con veste sintetica e scarpe Adidas: sfila sullo sfondo del ferro dipinto, dei piloni e delle palme. Appostato all’angolo di Via S. *** un enorme fagotto di stracci querulo tende la mano e fa gli auguri, poi due ciotole piazzate sulla strada davanti a una lavanderia; ci sono anche il cane e il padrone, un ragazzetto che bivacca con zaini, le due ciotole dette, e scarpe rosa-oro da ginnastica. Da solo – e col cane – forma un piccolo accampamento. Qui conviene accelerare. E sbuchiamo come palline da flipper in piazza *** dove il Barchile, candeggiato dal recente restauro, svetta e attorciglia la coda fra le natiche, vasca e rubinetti sempre senz’acqua.
Il lastricato puzza, non c’è porta, porticina, sportello o muro senza scritte sovrascritte, il trittico con la Madonna al centro, più sospeso che incastrato alla parete di un palazzo di Via ***, è noto perché un tubo di scarico della grondaia ne attraversa la parte destra. È la famosa Madonna della Grondaia. La Sovrintendenza vigila.
Più tardi vedremo altre madonne: una avrà l’indice sbriciolato, sarà custodita sotto vetro dentro una nicchia, a circa tre metri di altezza, dal basso tutta la figura sembrerà avvitata come un cavatappi di marmo, un cono con la testolina vacillante, eppure quell’indice monco sarà in grado di puntare più di un indice intero.
Sotto, leggeremo la targa con la data del restauro, l’ente benefico e altro. Nessuna indicazione sull’autore. La Sovrintendenza vigila.
*
A volte, mentre accompagnavo un gruppo di turisti, di colpo mi prendeva la voglia di sdraiarmi per terra, di rannicchiarmi e di non muovere più un muscolo. Era come se la mia struttura, costruita con migliaia e migliaia di stuzzicadenti, un telaio formato negli anni con pazienza infinita, un miracolo di incastri e laccetti, di angoli e piramidi, incroci, poliedri, sostegni al limite del niente, si rivelasse di colpo fragilissima. Naturalmente, durante queste crisi, dovevo fingere, sorridere, stringere i denti, appoggiarmi a qualcosa, un oggetto o un pensiero per raccogliere il mio scheletro di stuzzicadenti e portarlo avanti.
Passava, la crisi; mi aiutavo con un calmante preso di nascosto e non dicevo niente e proseguivo, ma tastavo il terreno su cui posavo i piedi come dovessi evitare un campo minato. Non se ne accorgeva nessuno perché riprendevo a parlare, gesticolare, ridere come sempre. Ero di nuovo brillante, come sempre.
*
Oggi faremo un giro particolare. L’ho chiamato: Metro per metro. Impiegheremo tutto il tempo che avete comprato col vostro pacchetto, il Pacchetto N. 2: non perderete neppure un minuto. Ma lo spostamento nello spazio potrà essere breve, anche molto breve. Questo percorso serve per notare ciò che in un tour abituale passerebbe inosservato.
Darò poche spiegazioni e a volte nessuna, mi limiterò a una sequenza di accenni quasi impersonali, vi lascerò liberi di immaginare, pensare, sentire. Se vedremo luoghi famosi sarà solo per caso. Il giro Metro per metro favorisce l’osservazione, l’ascolto di ciò che passa inosservato: un dettaglio, una traccia, un oggetto, un rumore, o anche un insieme che l’obbligo cronometrico porta a trascurare.
Quel che vi colpirà sarà del tutto soggettivo, forse legato ai vostri ricordi, attese, analogie; potrà sorprendervi perché poco piacevole o per una bellezza nascosta.
Dunque partiamo. Partiamo dalla Villa di C. Oggi la fontana è senza acqua, calcinata, gibbosa come il suolo lunare. Dal Belvedere *** non si può vedere quel che il cartello indica: la giornata è molto umida, la foschia impenetrabile. Il busto di una celebrità locale, ammiraglio, politico e cronista, girato verso la foschia, ha un orecchio colorato di viola. Lo decorano altre scritte a pennarello o spray, uno degli innumerevoli esempi dell’arte principale del nostro tempo. La Sovrintendenza vigila. Quegli alberi altissimi e massicci sono plurisecolari. La pozza che vedete sotto gli alberi ha l’acqua stagnante, uno strato di muschio da cui sbuca la testa gialla e nera, lucida come cuoio, di una testuggine. Abbiamo fatto pochi metri mentre le nuvole si spostavano lentamente cambiando il tipo di ombra, i rilievi delle cose, le tonalità. Quel che prima aveva una forma soffice ora è più scabro; quel pezzo di vetro manda un bagliore; questa pozza o stagno ha macchie di luce su fondo verde cupo.
Ora spostiamoci di qualche metro e di un livello. Quel gruppo di uomini sembra discutere con un muro; quel merlo vi fissa con un verme nel becco; una colonna su cui poggiava il busto di un’altra celebrità cittadina è abbattuto; numerosi passaggi sono sbarrati per lavori in corso; la foschia è più fitta, quei grandi teli di plastica sono immobili; in cima al pennone, in cima alla collina, una brezza lieve muove la bandiera della città di C.
*
“A questi frammenti avete aggiunto altri frammenti, a questi strati altri strati. Non è uno scioglilingua. A quel rampicante, già fitto, avete intrecciato altri rampicanti, su quella parete annerita di scritte avete scritto ancora e ancora. Ma anche le lettere, i graffiti hanno un peso. Anche il verde che attacca una parete la incrina e la curva. E l’inizio delle radici, tanto sono lunghe, intrecciate, innestate dentro, alla base e sotto la parete, non lo trovate più. Così l’asfalto si solleva e si spacca premuto da una schiena di legno inarcata. Così, anche col tronco tagliato, rinascono e sollevano auto in sosta. Più avanti vediamo una nuvola di fumo grigio, auto in colonna, sentiamo odore di bitume riscaldato, vediamo caschi arancioni, palette, cani strattonati, grumi neri attaccati alle ringhiere… Un manto stradale tutto nuovo sopra il vecchio, venti metri di creuza spaccati, odore di fango… All’ultimo piano di quel palazzo decorato da formelle, ciascuna formella con un granchio, tutte uguali, suonano il violino, maestra e allievo”.
*
“Voi che vi fotografate così spesso, ignorate una paura e una teoria non del tutto scomparse. L’anima è costituita da strati luminosi e insieme protetta come un involucro, un bozzolo invisibile di luce. Ogni scatto sottrae uno strato, e che sia elettronico o chimico, il furto avviene ugualmente. L’immagine si trasferisce, voi siete privati di uno strato dopo l’altro, il nucleo della vostra anima è sempre più intaccato.
Vedo che ridete. Sì, è una cosa buffa, assurda, una superstizione. Come sapete molte tribù, in passato, temevano che la fotografia rubasse l’anima. Anche un grande scrittore come Balzac condivideva la stessa paura. Questo passaggio silenzioso di un viso, il suo trasloco immateriale sui cristalli dell’emulsione (oggi sui sensori) gli ricordava certe forme di vampirismo metafisico: la foto non ha bisogno di succhiarvi il collo, vi toglie il sangue a distanza.
Allora alla fine del giro, provate a pesarvi. O semplicemente, cercate di capire se la vostra stanchezza è naturale: un lieve affaticamento dovuto al viaggio, alla sistemazione, al giro. Contate le foto che vi siete fatti o che vi hanno fatto. Quante saranno? Paragonate il vostro viso a quello fotografato, osservate l’incarnato, la pelle, certe pieghe. È solo un gioco.”
*
Quel che conta in questo sogno è lo sfondo e non il primo piano e neppure i piani intermedi – pochi, d’altronde.
Lo sfondo cambia. Adesso è la parete di una villa, Villa ***, in stile neogotico, con una fontana raffigurante un fauno: il fauno, alto circa due metri, divarica le mandibole di un mostro marino dal corpo di testuggine, è privo di un avambraccio, ha i capezzoli verniciati di rosso, come gli occhi e il labbro inferiore. Sul muro un fitto intreccio di rampicanti da cui pendono centinaia di capsule verdi a forma di pera, e dalle capsule, a un ritmo vertiginoso, si aprono fiori simili a satelliti azzurri. Questo sbocciare è senza tregua, un lampeggiamento e un palpitare silenzioso. Qualcuno svolge un rotolo di tappezzeria con motivi floreali e cerca d’innestarlo nel muro. “Vorrei un cambiamento nei grigi e nei rossi – dice – e anche animali esotici. Nessuna figura umana e nessuna prospettiva.” E lo scenario cambia, ogni traccia di vegetazione è scomparsa. La parete è carbonizzata, il fauno è crollato in mezzo ai suoi pezzi: zoccoli, torso, testuggine, mandibole. Non c’è fumo. Il disastro sembra accaduto molti anni prima, si vedono cartelli che vietano l’accesso, ma l’accesso a che cosa?
Fra il primo piano e lo sfondo – qualche decina di metri – si srotola un cartiglio di carta di riso. Sul cartiglio sono impressi stampi di figure alate. Il cartiglio è agitato dal vento. Chi lo impugna alle due estremità segue e asseconda le correnti. Gli stampi prendono il volo. Il cartiglio è vuoto. Lo sfondo è rosso. Una fila di palme come viste dall’alto. I tronchi sottili sono curvi e i rami strisciano quasi fino a terra. Lo sfondo è rosso cupo. Si sente un battito di ali.
*
Andate avanti e indietro, salite rampe, infilate scale, ascensori, scorciatoie, passate decine di livelli, percorrete passerelle sospese fra un palazzo e l’altro, scendete scalinate interminabili, larghe o strettissime. Ora vi stupisce una facciata da cui sporgono, e sembrano sul punto di spiccare il volo, demoni gialli alati e beffardi; notate la sproporzione grottesca della lingua e tutto è sospeso sopra il marciapiede, comicamente minaccioso. Dietro quelle sbarre, alla fine di Via*** una statua color cenere è messa al vertice di un giardino triangolare, sembra in attesa, fasciata con merletti di marmo come bende, figura femminile, la testa avvolta da una cuffia, lo sguardo verso terra. Nessuna targa, nessuna indicazione.
*
In Piazza delle *** un cassone di legno pieno di mele rosse, decine di chili, sistemate fra due bordi di margherite. In poco tempo marciranno, il caldo umido accelera la decomposizione.
In Galleria ***, al centro, una specie di altare: quintali di fiori e mele rosse disposti su diversi livelli, forse a piramide, poggiano su marmi freddi e scuri; dalle vetrate una luce sporca avvolge la sfarzosa composizione artificiale simile a un carro carnevalesco.
*
In Corso *** abbiamo incontrato una processione di auto, persone, cani, voci. Le persone avanzavano lente e silenziose, le auto erano quasi ferme, i cani al passo, le voci elettroniche veloci e ininterrotte fornivano mappe, impartivano ordini, direzioni. Dove andavano? Che cosa facevano? Tutti erano sbilanciati nell’andatura, ma tutti dallo stesso lato, perciò l’inclinazione si notava in rapporto alle ringhiere, all’orizzonte, a certi edifici, a certe linee; non tutte, essendo questa una città storta, sbilenca, allungata e piatta, dagli archi irregolari, dalle colonne zoppe, dagli improvvisi sfondamenti prospettici in ogni direzione.
Tutti procedevano inclinati, compatti ma come fosse un’andatura abituale. Una chiesa costruita a scatole cinesi, incuneata, gialla, apriva i tre alti portali sotto il primo porticato; aperti, si vedeva all’interno un altro porticato in minore da cui uscivano soffi d’aria, soffi di resina bruciata, sbuffi di fumo, aghi di pino bruciati. I negozi erano tutti chiusi tranne una Lottomatica che esibiva cartelli con le cifre su cui puntare, le cifre erano legate all’aria, alla saliva, al fuoco, a certi santi. Sui muretti che fiancheggiano il corso, c’erano pezzi di pane, libri e fiori artificiali legati ai pali, come due enormi papaveri e un uccellino meccanico dentro una gabbia cantava senza requie, stridulo, alzando e abbassando la testa a scatti regolari.
Ci siamo chiesti se pane e libri fossero un’offerta. Intanto la processione, sempre con quella bizzarra andatura diagonale, era arrivata in cima a Corso ***; o meglio, la testa della processione guidata da nessuno; il corpo e la coda si allungavano verso il basso per centinaia di metri: scomparivano ai tornanti, ricomparivano ai rettilinei.
*
Da lontano la città di C. sembra una sola gigantesca costruzione, un blocco fermo davanti al mare. Sui monti le case risalgono i crinali fin dove è possibile. Dall’alto è difficile immaginare che alla base di palazzi così belli ci sia una rete convulsa di vicoli infetti.
*
Forte ***, anno dopo anno, sprofonda nel suo fossato dove crescono erbacce, arbusti spinosi, bellissime rose selvatiche, il tutto intrecciato in una macchia da cui svettano un fico e un nespolo carico di frutti. Sotto il sole di piena estate nespole e fichi si asciugano sui rami e sono pasto per gli uccelli. Il caldo esalta l’odore del mentastro, altissime piante di alloro rimpiazzano le foglie secche con quelle verdi, ciclicamente, rapidamente.
*
Facce segmentate unite da strisce di cuoio o cerniere di ferro; come ripartite a battenti: facce a soffietto o paraventi.
*
In Vico degli ***, sopra una porticina verde sempre socchiusa, c’è un’edicola votiva, quasi una miniatura: piccolissima cancellata a due ante legate da una piccolissima catena e bloccate da un lucchetto minuscolo, molto ben lucidato. Le sbarre sono tanto sottili quanto fitte. Dalla porticina socchiusa esce una specie di lamento e sul fondo si sente una radio, un transistor mal sintonizzato.
*
Ogni figura accovacciata sembra pronta al balzo o ad afflosciarsi sul lastricato sporco. Quelli in piedi, appoggiati alle porte, sempre di profilo, come ritagliati, stanno rigidi con lievi spostamenti del collo.
Miracoli di equilibrio: seduti su strette mensole alte pochi centimetri da terra. Sulle mensole è disposto un piccolo mondo privato di oggetti miserabili e oggi ho visto un pettine frantumato, un fermaglio, una ciocca di capelli, scarti di un corredo per l’ultimo viaggio, oppure studenti mentre copiano su grandi album una chiesa, una prospettiva, accovacciati accanto agli sfiati, all’altezza dei cani, ai rigagnoli di urina.
C’è la coda per mangiare il pesto, strana coda sparpagliata e barcollante, ma sempre a ridosso delle vetrine, agitata, vicina ai lanci quotidiani di secchiate spumeggianti di ammoniaca. La gente mangia con la faccia rivolta contro il muro, a pochi centimetri dal muro, su panchette strettissime e inclinate. Ridono. Il cielo è blu, blu profondo, l’intonaco è giallo.
11 maggio ****, temperatura al di sopra della media stagionale, i gradini di Palazzo *** sono sorvegliati, il vestibolo splende nella sua ombra morbida, nelle sue molteplici cavità, volte, scaloni, colonne, altri vestiboli di marmo, corridoi, passaggi, cortili interni, un gran silenzio, il ronzio dell’ascensore, pochi passi dileguati.
*
Centinaia di metri di muri dove sono cementati frammenti di bottiglie, anche sui lati: per circa un metro le pareti sono tempestate di vetri affilati. Si percorre, in ripida e tortuosa salita, un viottolo accompagnato da questa muraglia con la cima scintillante. Siamo partiti da una piazza incuneata fra rotaie e costruzioni, tunnel, cunicoli, scale, architettura cristiana incastrata fino all’attrito. Anche la scalinata al tempio è irregolare. I piani sovrapposti dell’edificio religioso ricordano hangar, magazzini o tunnel adattati per il culto. Una piazza che non è neppure uno slargo è poco animata. Saliamo. Una porta bruciata. In alto due finestre ad arco murate da cui spunta un fico, le tracce di un’edicola votiva, erbacce, foschia. Scendono due ragazze, una tiene in braccio un neonato, i vestiti di velluto odorano di incenso, reliquie, cuori d’argento. Sono scese dal santuario della ***, noto per il suo presepe in legno, i suoi teschi sotto vetro, doppi tabernacoli, dorature, farciture di stucchi, tele sporche e altissime. Il santuario forma doppie mura, doppio recinto, ha una facciata grigia con poche tracce di affreschi – qualche rosso, qualche profilo inciso. Il cortile è quasi un cilindro, alto, ostile. Non invita a nessun raccoglimento ma alla fuga. A fuggire da un girotondo su pietre bianche e nere a forma di rapaci.
*
Il secondo livello del parco di Villa ***, villa neogotica, ha uno strato di foglie secche dove il passo affonda. Le aiuole hanno poca terra. Due statue simmetriche, reggono canestri di frutta nera: è il cancro del marmo. Attorno al collo hanno lacci che li annodano a un fascio di esili tronchi neri. L’espressione è come un morso affondato in una guancia. Dal primo livello scendono cani: guinzagli tesi come prima della caccia.
*
I demoni alati non hanno ali, si aggrappano a un festone, lo tirano dietro le orecchie e mirano i passanti col mento aguzzo. Non sono demoni ma satiri. Le cosce sono tese, gonfie, gli zoccoli puntati all’interno daranno lo slancio. Altre maschere decorano il palazzo di Corso ***: bocche grandi e sottili, occhi vacui, e replicato 12 volte, al piano terra, un volto dallo sguardo arrogante.
*
Ha il colore del carbone il secondo livello del parco di Villa ***, villa neogotica. Ha un bassorilievo asportato, un rettangolo di mattoni e cemento, foglie piccole, fittissime, due statue a pezzi dentro una siepe circolare molto curata. Dovete chinarvi e spostare i rami del pitosforo per scoprire il tronco rovesciato di una statua, i piedi consumati e una mano. Si alza la polvere, il vento è più veloce, il tono dominante adesso è il grigio.
*
Nelle figure levigate del presepe, quasi manichini, lucidissime, vetrificate, un museo delle cere, anche le rughe sembrano chirurgia plastica, lifting, cerone. Il cielo artificiale, il bambin Gesù grassoccio, sproporzionato e biancastro – dov’è l’anima? Nessun movimento, nessuna zuffa come nel teatro dei burattini: i gesti sono raggelati, i piccoli personaggi, non tanto piccoli da suscitare un incanto infantile, non si muoveranno mai, a quel gesto fissato nel legno non ne seguiranno altri, neppure immaginati.
*
Le voci sono basse, mischiate, continue, ostinate; un corpo sonoro compatto con suonerie, viva voce, sbandamenti sonori, silenzi brevissimi e immotivati; forse un segnale dall’alto impone qualche secondo di silenzio per riprendere a macinare parole.
*
Una costola impressionante di cemento e pietre, alta venti metri, fuoriesce da una parete piatta e poggia su un terreno di nessuno come un’enorme barra di timone. Siamo vicini a Piazza S. ***, sotto teschi e clavicole, accanto a una banca che ingloba una chiesa.
*
Un giorno, dentro i vicoli della città di C., alcuni uomini hanno trascinato una capra legata a una corda intorno al petto e al collo; la capra s’impuntava e allora uno la spingeva, gli altri tiravano la corda e imprecavano. Erano sudati sotto la canicola di agosto, i vicoli erano quasi deserti. Erano vestiti di stracci. Uno, strattonato dall’animale, era caduto. La capra era un magnifico esemplare col pelo bianco, gli occhi azzurri, le corna lunghe: sembrava una divinità. Manifestava paura e insieme collera. Quegli uomini la offendevano. Quegli uomini erano alla miseria, avevano la pancia vuota, la capra l’avevano rubata ai pastori che scendevano nel ***, e, non si sa come, erano riusciti a trascinarla fino a Via S. ***, in mezzo alla polvere, a un caldo opprimente, e a un certo punto non l’avevano più tirata per il collo ma trascinata per la pancia o la schiena. Questo avveniva più di mezzo secolo fa. Ostinati e affamati avevano spinto la capra davanti a un portone e l’avevano trascinata nell’atrio. L’animale emetteva suoni terribili, una specie di raglio o nitrito, quasi un barrito disperato. Gli uomini cercavano di tirarla su per la scala ma l’animale aveva incastrato le corna in mezzo alla balaustra. Allora le avevano legato i garretti e la capra aveva lo sguardo umiliato e gli uomini erano quasi sfiniti. A quel chiasso si era socchiusa qualche porta, una spalancata e subito richiusa. Allora, raggiunto un pianerottolo, davanti a una porta sfondata, poiché la capra resisteva oltre ogni limite, uno degli uomini le aveva piantato un lungo coltello dentro la gola. L’animale aveva contratto tutto il corpo e allungando il muso verso l’uomo che l’aveva pugnalata lo aveva fissato con disprezzo e pietà.
Poi gli uomini avevano tirato il cadavere dentro l’appartamento, strisciandosi dietro sangue e saliva.
*
La città che il Minotauro avrebbe amato replica il suo labirinto in centinaia di ponteggi. Il vento sposta i materiali friabili e li sparge a terra, l’oscurità raddoppia.
*
Un leone della cattedrale di S.***, liberato dai ponteggi ha un varco dedicato a chi lo cavalca, lo fotografa.
*
Sui ponteggi sono scese le reti: verdi, blu, bianche. Dall’alto, oltre il rosone, fino a terra.
*
Oggi pedalo e faccio pedalare una decina di turisti. Li ho raggruppati in Piazza *** per qualche istruzione, consigli per l’uso del mezzo, rispetto per tutto: cose e persone. Hanno il ventre sporgente, le unghie affilate, i capelli tinti e rasati sulle tempie, portano occhiali da sole, non riesco a dar loro un’età precisa.
*
Oggi, esibizione dell’aeronautica militare. Ascoltate il cupo risucchio, l’effetto di sottrazione, il cielo che sembra sul punto di cedere come un vecchio pavimento.
*
“Uno specchio, datemi uno specchio,” grida allarmata una donna con una collana in mano, un cappello bianco a larghe falde, un anello per ciascun dito, lungo e ossuto, occhiali enormi, rossetto e smalto rossi. Da una bancarella le porgono uno specchio brunito, acqua torbida vetrificata, dove la donna si guarda e ride. Dice: “Ma questa non è la mia faccia! Non ho quella piega scura sulla fronte né quella specie di cavità sulla guancia. E quelle macchie? Ma non sono mie! Non avete un altro specchio?”
*
La riviera è piena di limoni, aranci, bergamotti, mandarini, kumquat, limoni grandi come cedri, cedri. Il giardino del Principe ostenta limoni enormi, un cartello avverte di non toccarli perché trattati. Le aquile, sul bordo della vasca circolare, sono rivolte verso la statua, il poderoso Nettuno s’innalza dentro una vasca vuota.
*
Salendo, il secondo vicolo a destra di Via S.*** è quello con le pareti e le saracinesche talmente annerite dalle scritte che il metallo è sparito; appena voltate l’angolo c’è un capitello segato, due statue mutilate. A quel punto, data la notevole pendenza lasciatevi andare fino in fondo senza pedalare.
*
Le braccia mutilate erano tese nello sforzo di raggiungersi. Le due statue sono ricoperte di aghi che scoraggiano i piccioni e trasformano una statua in porcospino.
*
“Per adesso le onde non battono più sotto le mura”, mi dice qualcuno che sta inchiodando una porta di metallo a una porta di legno e nella porta di metallo si è aperto un spioncino protetto da sbarre. Via del *** è stata teatro di una rissa, sul selciato sangue, cassette di frutta rovesciate, gente alle finestre.
Un’onda lunga trascina lontano i litigiosi, lava i resti del subbuglio. Io alzo un telo azzurro, lo tendo fra muro e muro e mi sento protetto dalla stoffa anche se gli echi della zuffa non sono ancora spenti; il telo è arabescato, riceve luce dal mare, osservo le forme che si accendono di colori caldi. Adesso sento colpi, colpi sferrati con rabbia e nello stesso punto, colpi sordi. Un cane passa sotto il telo: è sporco, ha le zampe corte e mi fissa con lo sguardo mite, muove la coda. So che un’altra onda si prepara al largo, molto al largo. “Arriverà anche qui, le mura non basteranno. Non sente come un fragore remoto, non vede come volano i gabbiani? E questo silenzio, come un tunnel vuoto, e quelle nuvole scure?” Chi parla così è l’uomo che inchiodava una porta a una porta. “Cercavo di rafforzare la base della mia casa, ho usato chiodi spessi e lunghi, con la testa grossa, come quelli antichi. Il suo telo è bello, mi dice, sembra una vela, ma è orientata male, la direzione è sbagliata. Non verso levante; deve girarla. Faremo una zattera, ho degli ottimi tronchi, vecchi alberi di velieri smantellati. L’onda arriverà fra qualche giorno, da qui non possiamo andarcene, useremo il suo telo come vela, imbarcheremo anche il cane. Non pensi ad avvisare gli altri, non le crederanno, la guarderanno come si guarda un bambino che racconta una storia, le gireranno le spalle.”
*
Masticando pane lentamente sento la mia saliva mischiarsi alla farina e mi sembra di avere più coraggio; così rafforzo lo scudo, le insegne, gli ammonimenti scritti nella pietra, raddoppio porte e guardie, aumento le portate di una cena di cui sono l’unico invitato, circondato di lacchè neri e bianchi, silenziosi, impeccabili, dai gesti solenni e raffinati; di ogni piatto porzioni minime, il mio corpo asciutto temprato sulle navi, sulle torri, dagli assedi, durante gli arrembaggi, gli assalti, le notti a lume di candela per studiare i territori, le imboscate, le armi, le armi da inventare, i dorsi degli animali come ponti, fiamme, arcieri, frecce infiammate, pece, lo studio dei venti, la loro direzione, l’incubo ricorrente del mio corpo che precipita, le mie spoglie esibite in piazza, i traditori, i tornei, i versi dei poeti, gli affreschi con le gesta, il mio volto innestato sul corpo di un liocorno, elefante, cavallo di Nettuno, il deserto, le incursioni, le statue e gli onori, le poche ore di sonno, i mesi di navigazione sul mare più infido perché chiuso, due stretti marciapiedi allagati da correnti opposte, barchette di carta le mie, da sessanta metri, con 400 uomini, tre ai remi di diciotto metri, i miei alberi, le coffe, il sartiame e le vele sono ponteggi, i marinai sono muratori, il cielo è intonacato, la flotta chiusa in un otre è un modellino, l’acqua trabocca, lo spago gettato all’ormeggio, annodato intorno a una capocchia di spillo o bitta, ancoriamoci a questo tavolo, attacchiamo i cavalli ai cartelli stradali, nascondiamoci dietro mattoni, sabbia, spazzatura, tendiamo ancora agguati.
*
Alla fine di questo muro c’è il filo spinato; più in basso un rumore di acqua corrente, sotterranea, come una cisterna; oltre le Mura di *** si schiantavano le onde; sopra quel portone verde screpolato vigila un santo di marmo, il marmo è sporco, il portone socchiuso; scale ripide, altre scale; scendiamo in Vico delle ***, guardiamo la sequenza dei contrafforti, i lavori in corso, una ringhiera che s’innesta nel vuoto, lo strapiombo fra due edifici: vertiginoso, tagliente; quei tondi di marmo cementati sbucano dal muro; guardate il dislivello fra i vostri piedi e il primo muro, il ronzio dei cantieri, i ganci enormi, le tute bianche, il taglio dell’ardesia, il brusio s’infrange contro gli archi di mattoni.
*
Oggi, camminando per la città di C. ho cercato di non guardare, di non fissare nulla, di far scorrere tutto ai lati lasciandolo alla periferia degli occhi: strisce di cose e persone, pannelli semoventi, quinte teatrali spostate al ritmo del passo poco regolare, scansando, bloccandomi, evitando. Ai lati sembra che le cose pungano meno, le impressioni visive scivolano e volano via o permangono in un modo strano, come attaccate alle tempie, fanno ombra agli occhi, non sono meno tenaci. Davanti ho la punta dei piedi, gambe e piedi degli altri, rotelle di carrelli, zampe di cani, scarpe, e ogni tanto alzo lo sguardo. I lati scorrono all’indietro lenti, una vernice densa, persistente, macchie, rilievi, fughe di lato, linee intrecciate.
*
Le schiene e le mani intrecciate dietro le schiene coi pollici all’interno, custoditi, come quelli dei neonati.
*
A uno cade una maglietta, un altro la raccoglie e lo chiama. Il primo finge o non lo sente e accelera. Accelera anche l’altro e chiama più forte, ma l’inseguito svolta, quasi correndo infila vicoli stretti e bui; il secondo è ostinato, ha il passo agile e veloce ma non grida più perché crede sia questo a spaventare l’uomo. Sbucano insieme, da due vicoli diversi, in piazza *** dove c’è un cantiere, un gran rumore e molta polvere. L’uomo che ha perso la maglietta si è addossato a un portone, ansima, asciuga il sudore con un braccio; l’inseguitore si ripara gli occhi dal sole e dalla polvere e tende verso l’uomo la maglietta. L’altro non si muove, fissa un punto indefinito, il martello pneumatico fa un fracasso infernale e l’uomo si tura le orecchie, schiaccia la punta delle dita con tutta la forza possibile, abbassa la testa, ondeggia il busto. L’inseguitore lega la maglietta a una sbarra, fa dieci nodi molto stretti, nodi esperti, da marinaio, ha lo sguardo deluso e feroce, grida qualcosa verso l’uomo o il cantiere.
*
Lo sguardo strafottente, l’età di un bambino ma l’espressione di un adulto, espressione ironica e astuta. Fronte troppo ampia in una testa troppo grossa, una bocca piccola e stretta, da cocorita. Un vestito come un sacco avvolge la madre. Donna imponente. Seduta di profilo fra due colonne. Il vento ha già alzato il sipario. Il bambino vi fissa, ha un orecchio a sventola. Un cane grigio ai suoi piedi sembra preda di una rabbia convulsa e trattenuta. Tiene la lingua fra i denti. Dietro la balaustra il vuoto.
*
Un uomo sdraiato sul marciapiede, la faccia verso il basso è una linea orizzontale che non si calma fra linee verticali, verticali spezzate, ondulate – gli altri sono in piedi, lui è a terra. Un elicottero sorvola la città di C., sorveglia una famosa manifestazione sportiva. Nessuno si cura dell’uomo per terra. Si svolta l’angolo e il Palazzo *** è coperto dai ponteggi, mentre il palazzo di fronte è in stato di degrado. Una vetrina espone una stampa: un carniere da cui trabocca selvaggina e altre di soggetto botanico o navale o panorami della città di C. Lungo Via *** tracce di grasso e sangue: è il retro di una macelleria. Si sbocca in Via S. ***, ostruita da prismi di cemento, arredo urbano per soste, pic-nic, raggruppamenti. Volano i gratta e vinci di chi non ha vinto.
*
Addosso mi è rimasto l’odore della strada, negli occhi palloncini e ponteggi, feste, disegni a gessetto sulle pietre, giochi da bambini, appaiarsi di passanti, vetrate polverose. I richiami si smorzano dietro un portone a tre ante costruito con toppe di legno e di metallo, i passanti sembrano gareggiare in certi punti, rallentare in altri, e il motivo è incomprensibile. Una ragazza ha raccolto un piccione caduto dal nido e lo nutre. Sono in Piazzetta ***; sotto un cornicione affreschi fiammeggianti, palazzi altissimi, sono in fondo a un pozzo rettangolare, in fondo all’ombra, tra porte e saracinesche.
*
Il ronzio di un flessibile e le cascate di vetro della differenziata sono il canto del gallo della città di C. La foschia avvolge il mattino. Sbattono portoni, stridono saracinesche. Gli accovacciati sono già addossati alle vetrine, hanno le ginocchia in bocca. Da un androne rumore d’acqua, acqua che precipita. In piazza S. *** un magnifico portale è oggetto di centinaia di scatti. Arrancano carrelli di ogni tipo lungo Salita ***, silenziosa, quasi vuota, sinuosa, piena di vento. Il vento sembra avere un sistema di canalizzazione, s’interrompe di colpo a certe svolte, riprende imbucando altre strade. Accanto a un deposito di spazzatura, da un’aiuola, svetta il becco di una superba sterlizia. Intorno grate per lo sfiato sotterraneo, sottopassi abbandonati e pieni di rifiuti, chiusi.
*
“Forse inquadrano tutto il portale, o tutta la facciata. Forse i dettagli. Migliaia di scatti, decine e decine di corpi mi saltellano intorno. Io ho il corpo di un leone, credo, o almeno ne ho le zampe. Una guida sproloquia sullo strano animale e la mia faccia. Parla di enigmi, date, elenca nomi, sepolture, secoli. La mia faccia è ben levigata, ben conservata, custodita. Ho qualcosa di un mostro. Ho le zampe di un cane. Ho le ali di un’aquila e la coda di un drago. Alludo agli elementi, dice la guida. Sono inquietante, aggiunge la guida. Ai lati le mie code arrotolate diventano fogliame. Sono un fregio, sono grottesco, sdoppiato, messo sopra una targa.”
*
Una foresta di colonne nel primo vestibolo di Palazzo ***, muri scrostati, soffitti altissimi. Una scala fra due semicerchi, specie di terrazza con balaustre affacciata su Piazza ***: il dislivello è di pochi metri, la scala è quella da cui siamo saliti. I mattoni della Torre *** compatti e in certi punti levigati o porosi o sbriciolati: sbuffi di polvere rossa. Un cancello con punte affilate delimita uno spazio vacuo in cui cresce qualche vegetale. Su quella parete vediamo un graffito ricorrente: un pipistrello ad ali spiegate. Ai lati di un portone due sedie di paglia appese al muro, forse un’insegna. Appesi ai pali mediante catenelle contenitori per le ceneri e le offerte. Un archivolto trasuda acqua. Dalla vicina Chiesa di S. *** echi di letture. In fondo alla Scalinata del ***, ripidissima e aguzza, pali arrugginiti e reticolati. In Vico *** sgocciola acqua. Sulla parete dell’Oratorio *** una campana su cui dorme un piccione. Nel muro intriso d’acqua cresce il capelvenere. Più in basso una sfarzosa magnolia irrompe da un cortile, alta come tre o quattro piani. Ancora più in basso sfocia un corso d’acqua. Su diversi piani campi da tennis e da calcetto. Il complesso di San *** fa da pista da cui decollano i gabbiani.
**





**
Sono rientrato con una valigetta di impressioni, ritagli di pietra, di marmo e di metallo. Ora devono riprendere rilievo, sporgere, affermarsi per poco e poi sparire: nascosti, spostati, allontanati, lasciati sotto un arco, ai piedi di una scala, dentro una fessura nel marmo, presi dal vento dentro un piccolo e ostinato girotondo con altri scarti. Ritagli di aria, se è possibile.
*
Vediamo una colonna visibilmente inclinata verso sinistra in Vico ***, colonna poderosa accanto a frammenti di targhe, archi tamponati, un sistema per la raccolta dei rifiuti a parete con oblò di gomma, l’impronta di una statua sradicata e a livello del suolo un’apertura ad arco, le cui sbarre, inglobate dal cemento, non hanno più spessore. Da una breve distanza è un trompe l’oeil perfetto, le sbarre sembrano dipinte, la ruggine imita sé stessa.
*
“Nel palazzo del Marchese *** vedrai un piccolo busto di Balzac di pregevolissima fattura ma collocato male sulla lunga mensola di marmo di una massiccia specchiera con la cornice in oro zecchino decorata da volute, boccoli, putti, fiori. Cornice pesantissima che schiaccia il busto il quale si riflette come un punto insignificante nella mastodontica specchiera con tutto l’arredamento sovrabbondante di una sala enorme. L’ammirazione del Marchese *** per il grande scrittore è indubbia eppure sembra che l’ammirazione coincida con l’offesa: il piccolo busto annega dentro lo specchio, si disorienta in mezzo ai mobili, agli oggetti, alle pareti, al soffitto affrescato raddoppiato nello specchio. Su Balzac grava un peso che neppure un gigante come lui può sostenere. Sospetto il Marchese *** di invidia, di bassa invidia o di cattivo gusto nella disposizione degli oggetti.”
*
D’estate le pitture su pelle si mettono in movimento. I polpacci muovono un intrico di foglie e animali, le braccia agitano simboli, le spalle codici a barre, alfabeti, iscrizioni come incisioni rupestri.
*
Potete osservare un gran numero di opere in movimento, pitture su pelle, musei trasportabili, braccia dipinte, mani, spalle, gambe, polpacci hanno colori blu, i blu di un livido, rossi, i rossi di una ferita mal curata. Sul collo i disegni sembrano serpenti accolti dal torace che è una foresta. Sono tantissimi, sono corpi affrescati, opere d’arte. Quando la pelle sarà floscia per l’invecchiamento, le figure diventeranno pieghe, i simboli illeggibili, i colori un impasto come cartone verniciato inzuppato d’acqua.
*
Come lo spazio urbano diventa tormento, assillo. A quell’incrocio non si passa, o meglio, non si sa quando. Deviando s’incappa in un gruppo. Si torna indietro.
*
“Non ci sono altro che palazzi di marmo e qualche chiesa bianca e nera?”
“Ci sono giardini pensili, maschere di marmo a migliaia, statue sulle balaustre, magnifici portali, cortili con fontane, grotte, un vestibolo dove sfociano torrenti con dieci vasche, un fragore di cascata, volte affrescate, enormi lampadari in ferro battuto, draghi in ferro battuto, busti, porte di legno massicce, corridoi vuoti, balaustre affacciate sopra ringhiere, targhe di marmo, passerelle, scale a volute, resti di fuochi, soffitti sfondati, poca luce, grandi portinerie di legno senza custode, androni, altoparlanti, schermi, grate.”
*
“Non ci sono fiumi che convergono in vestiboli o androni, né dieci vasche. L’acqua è simulata nel modo d’irrompere e lo spazio amplifica il rumore che sembra una cascata, l’acqua sembra cadere dall’alto, da molto in alto, i riflessi, il gioco delle ombre sulle volte, sempre diverso, fanno del soffitto lo specchio di un fiume. Il mascherone di marmo, con un buco al posto della bocca, ha lo sguardo laterale. La grotta è finta, le incrostazioni simulate.”
*
Teste di leone, battiporta a tritone, faraoni in Salita***, disseminati ovunque, battiporta a forma di drago in Via ***, mirabili lavorazioni in ferro, battiporta asportati, buchi. I melograni in fiore, con qualche frutto secco ancora aperto. Sotto l’ombra del fico, addossati al muretto, occhiali da sole, berretti con visiera, giacche militari, ritmi ballabili, ubriachi, più di venti, come babbuini nascosti fra i rami e il fogliame, qualcuno balla, qualcuno si lava.
*
“Le posso riferire che i bambini girano sugli autobus nudi, il caldo è opprimente e la caccia all’ombra spietata. Sotto le putrelle, la ruggine e i graffiti, delimitato da una rete storta, qualcosa che ricorda il relitto di un giardino orientale. Erbacce, palme secche, rifiuti, rocce marroni forse di cartapesta, melograni e un fico e un macchinario sfasciato, forse un vecchio macchinario da tipografia. I carrelli degli spedizionieri s’incrociano veloci; molti non si orientano, guardano il foglio di consegna, chiedono informazioni e imboccano decisi, la faccia rossa per il caldo, la direzione sbagliata.
Posso dirle che c’è una bizzarra e sgradevole abitudine di cui non mi spiego il motivo: molti sputano, sputano camminando con getti lunghi, precisi, balistica applicata all’emissione di saliva. Si annunciano con rumori rochi o schizzano in silenzio. Ho visto molti cani afflosciati dal caldo. Nessun gatto, tranne nel quartiere del *** e dalle Mura della ***, pochissimi e per lo più tigrati; oggi sotto l’ombra delle auto. I denti di leone fra le pietre dei muretti sono tutti appassiti, il loro giallo vivo è paglia secca.
Intorno a un lato di Palazzo *** c’è una specie di fossa con ripidi gradini e resti di colonne, monconi adatti ai volatili, trespoli. Sui gradini in ombra siede o si sdraia un campionario eterogeneo soprattutto sul primo livello, più largo e accogliente.
Questa specie di fossa molto inclinata è sempre sporca.
Affreschi slabbrati, intonaco a nudo, odore di calce; cantieri non si sa quando aperti, due ancore enormi posate ai lati dell’ingresso a sud di Palazzo ***; in cima al portale un volto di medusa oblungo come in preda a un tremore e teschi di capre. Agganciati a una ringhiera resti di biciclette, catene che non assicurano più niente.”
*
Uno scrittore avventuriero, all’inizio del secolo ***, approdò nella città di C. dopo un lungo viaggio a bordo di un tre alberi, capitanato da un greco. Ormeggiato a un molo gigantesco in costruzione o demolizione (non riusciva a capirlo) scappò dal veliero con un bulgaro e un irlandese. Quest’ultimo li portò in un locale famoso, il ***, dove si poteva bere birra fresca e ascoltare un’orchestrina formata da cinque donne. Il locale era stata un’invenzione del padre dello scrittore ma lo scrittore non disse nulla. Una delle musiciste traeva effetti comici e animaleschi dalla sua tromba; di un’altra, magrissima e nera, s’innamorò lo scrittore. I tre le vollero tutte per loro almeno per un mese. Lo scrittore, per pagare al locale l’ingaggio delle musiciste, vendette una perla di contrabbando. Per un mese vissero in un appartamento all’ultimo piano, affacciato sul porto, con loggiato, facendo musica, sesso e bevendo. Lo scrittore aveva altre due perle: le usò per fare due orecchini e le regalò alla musicista, magrissima e tisica che aveva soprannominato Filo di ferro.
*
Accompagnato da un rumore di campanelli e di scarichi, accanto a un condizionatore che fa tremare una vetrina, le pozzanghere di Via dei *** si asciugano lentamente all’ombra, impiegano settimane; il lastricato non le assorbe, la pendenza non le fa defluire. Quando s’incrociano altri, si rasentano i muri. La via si biforca, una lunga strettoia è l’imbuto che raccoglie il brusio di Piazza ***, sul fondo sfilano carrelli, gente, scintillano le cianfrusaglie per turisti, l’angolo è ostruito da cartoline, magneti, cartoline lunghissime. Sul passaggio continuo, sul vociare, incombono gli archi di San ***, la balaustra, gli affreschi che hanno i colori dei canditi o della frutta secca. Le scatole di compensato alla base dei ponteggi, alte quasi un piano. Dietro, nessun movimento e molto buio. Un ragazzo ha messo nella custodia la sua arpa.
*
In Vico ***, dalle fauci di un leone, ondate di frutti e fiori scolpiti nella nera pietra di promontorio. Da osservare. Merita una sosta il sistema di aereazione a griglie sopraelevate fiancheggiato da un’alta cancellata che chiude un sottopasso e la sequenza di neon e i becchi delle sterlizie in piena fioritura, eclatanti, appuntite, blu smalto, arancione saturo. Capigliature a cresta come decorazioni per guerrieri. Sui gradoni a forma di sarcofago degli sfiati sotterranei, s’improvvisano un letto i senza casa.
*
Siamo saliti sulla collina in una giornata di freddo improvviso: meno venti gradi rispetto ai giorni scorsi. Molti non hanno i vestiti adatti per questo capovolgimento e serrano le braccia. Tutto ciò che può muoversi col vento, col vento forte sbatte e vola via: bandiere, segnavento, girandole, vestiti, carta, oggetti di artigianato, sospesi a fili sottili, oscillano convulsi e s’intrecciano, le reti di contenimento sui cornicioni scivolano, i teli schioccano. Nel cielo nessuna traccia di azzurro: alle nubi spostate si succedono altre nubi, tutte grigie, tutte scure, qualcuna sfilacciata di un grigio chiaro su grigio scuro. Saliamo da Vico***, stradetta di mattoni, umida e muffita, ma protetta dal vento. Vale la pena osservare quei ripiani inclinati agganciati a certe finestre, tutte ai piani bassi. Portavano luce di rimbalzo dentro locali scuri. Fuori sono di metallo, all’interno sono bianchi. Accanto a due panchine, in uno slargo, un nespolo carico di frutti. Centinaia di piccoli ovali giallo-arancione spiccano fra le pietre, i marmi e il cemento. Una grande nicchia vuota in cima a Vico *** è il punto obbligato, salendo, dove converge lo sguardo. Siamo nei pressi di S. M ***, complesso conventuale bianco, chiesa a tre navate, rivolto verso i quattro punti cardinali.
*
“La città di cui vi parleranno le guide non esiste; quello che vedete in rete, sulle cartoline, nelle agenzie di viaggi, nei video promozionali, in televisione, sui manifesti, quello che leggete, se leggete, non esiste; neppure quello che fotografate, perché la foto non è la realtà, la foto ha un occhio solo, è Polifemo; quello che vedete nei vostri monitor non esiste ma voi non sapete o non potete più guardare. Non potete neppure immaginare, perché altri fabbricano immagini con lo scopo di non farvi vedere, altri preparano lo scenario virtuale, il facsimile, il trompe l’oeil turistico; altri hanno già scritto la vostra storia; nascondono qualcosa che sembrerebbe impossibile nascondere tanto è visibile; eppure voi non guardate, fissate un monitor dove con uno scatto vi fissate.”
*
“Vi stupiranno centinaia di saracinesche chiuse, corrose dalla ruggine, pareti sgretolate, interi palazzi in rovina, le basi dei muri spaccate, angoli intaccati, cavi annodati a cavi, tubi di gomma, corde. Guardate in alto, e guardate bene: è un labirinto di fili sospesi e penzolanti, troncati, arrotolati a cappio. Dal primo marcapiano in su un’intricata flora di plastica si arrampica, si attorce, scompare e sbuca sopra e dentro capitelli, portali, sovrapporte. Dal primo marcapiano in giù è un groviglio di scritte su ogni superficie. Siete dentro un gomitolo sporco.”
*
Caro ***
la città di C. è la più adatta per chi ama il difforme e l’eccesso, la sproporzione e l’incongruo che si trovano a tutti gli angoli, ovunque. Se piacciono le vertigini e le ondulazioni, la dissonanza e le diagonali, i rovesciamenti di prospettiva, luce, suoni, odori, l’incrociarsi convulso di cose e persone, gli attriti improvvisi, la città di C. è perfetta. A distanza di poche ore certe strade cambiano radicalmente e il cambiamento non ha gradazioni, è un taglio improvviso. Qui convivono o si danno battaglia edifici, gruppi etnici, materiali, ricchezze e lurida miseria abitano lo stesso palazzo. Il sovrapporsi di muri e scale, ascensori, passaggi, ringhiere, l’esplosione di forme enormi in spazi angusti, il viale che diventa una stradetta a precipizio e svolta in una scalinata contorta e vertiginosa, sorprende, meraviglia, affascina e poi disorienta, angoscia, provoca malessere. Molte cose diventano incomprensibili, altre oscure e minacciose almeno all’apparenza. Il respiro notturno del mare è insidioso. Le forme incombono. Le ombre sembrano in fuga continua.
*
Caro ***
Se verrai nella città di C. non cercare quei gatti di cui tante volte hai letto nei libri: non li troverai. E non li troverai per il semplice motivo che non ci sono più. La città dei gatti è diventata la città dei cani. Sono tantissimi e hanno un aspetto poco rassicurante come a volte quello dei loro padroni che non di rado ne tengono al guinzaglio più di uno, della stessa razza o spaiati, a volte con effetti anche comici per il tipo e le proporzioni. Ti accorgerai che è una città di cani anche dagli escrementi e da un abbaiare spesso furioso che sembra provenire, per l’effetto dell’eco, da tutte le pareti. Vedrai molossi, pit bull, bull mastiff, doberman, levrieri, carlini, botoli spellati e ringhiosi, mastini napoletani, teste massicce e minacciose, occhi rossi, pelo corto e coda corta, enormi genitali, zampe che sembrano ceppi, e tutti senza museruola e non sempre al guinzaglio, soprattutto di sera, quando i padroni li portano fuori a passeggiare per i vicoli. Oggi ho cambiato direzione perché un vicolo stretto, Vico ***, era ostruito da due cani sdraiati, una montagna di muscoli, grigia, distesa fra muro e muro. Come avrei potuto passare? Anche la penombra intimoriva e la gente addossata ai muri, e il timbro delle voci, e il lastricato nero, e l’intonaco nero.
*
Caro ***
una processione poco numerosa, molte più suore che adepti, oggi si trascinava per diverse strade del centro storico guidata da un prete e dalla sua voce amplificata. Il prete era affiancato da due portatori di un cristo ritagliato nel cartoncino, una sagoma squallida e insieme comica che ballonzolava rigida, a scatti, come un busto a braccia aperte e ingessate. Il brusio monotono delle solite formule e il passo strascicato di quei pochi incolonnati dietro la sagoma di cartone, le schiene un po’ curve e il nero delle suore, in una giornata afosa, mi hanno irritato. Pur essendo pochi, facilmente tappavano i corridoi angusti (vicoli) e il cristo ritagliato era davvero patetico, quasi una parodia. La processione, giunta alla fine di Via San *** ha finalmente deviato verso la Chiesa di San *** accompagnata da qualche colorito commento.
*
Caro ***
puoi immaginare la processione e se vuoi, aggiungi, cambia, sposta quello che ti pare. Cambia stagione e immagina una tramontana che taglia la faccia e abbatte la sagoma di cristo, curva i portatori, il vento sibila nel microfono, i fedeli affrettano il passo per riscaldarsi. Poi spostala di notte. Ceri altissimi, ombre lunghe sparpagliate sulle case, sul selciato, luce gialla, grande partecipazione popolare, cori, vesti sontuose o stracci, il senso di un lungo cammino faticoso, non si sa quando iniziato, incensieri, turiboli oscillanti, superfici argentate rilucenti nell’ombra, preghiere silenziose. Ora invece prova a mischiarti al popolo, senti gli altri corpi, l’alito, l’odore dei vestiti, cammina con il passo di tutti, sosta quando il prete dice di sostare, recita le formule d’uso, tieni lo sguardo basso, curvo sul selciato, dai il cambio per reggere la sagoma di cartone, non fissarne il retro (la schiena), che è bianco.
*
La grande vasca di Piazza *** è asciutta. Ha un tono verderame opaco, le bocche dei mascheroni sono buchi vuoti e neri. Intorno alla piazza decine di furgoni, strutture tubolari, altoparlanti, piccole tendopoli. E dall’inizio di Via *** arrivano voci a folate, si vedono bandiere e stendardi, si sentono applausi.
*
Sono sparpagliati per tutta la città, entrano in tutti gli esercizi commerciali, indossano giacca e cravatta, hanno mocassini sfavillanti. Sono i raccoglitori di consenso per le elezioni del sindaco. Si adattano a ogni interlocutore in un esercizio acrobatico di mimetismo, sono flessibili, svelti, si disfano della vecchia pelle a un ritmo parossistico come la muta accelerata di un serpente.
*
Caro ***
Stanotte ho dormito male perché un cane abbaiava stridulo e insistente sotto le mie finestre. Stamattina mi sono lamentato con l’albergatore che mi ha risposto più o meno così: “Ne sono molto dispiaciuto, signore, ma è un cane, capisce? e abbaia come noi parliamo. Che cosa si può fare? Se mi mettessi a gridare di notte per scacciarlo aumenterei solo il baccano. Se parlassi al suo padrone, ammesso di rintracciarlo, mi direbbe che è un cane e quindi abbaia. Se gli dicessi di cambiare zona mi direbbe che i vicoli non sono di mia proprietà e che il cane va a spasso dove vuole e abbaia dove vuole e all’ora che vuole, non essendo regolato per abbaiare a certe ore in certi luoghi e in altri no. Il cane è un cane, direbbe, in un trionfo di dialettica.”
Il cane è un cane: abbaia, va a spasso dove vuole, sosta dove vuole, non è regolato secondo i nostri ritmi, non bisogna scambiarlo con un essere umano, è vero. Il cane dorme quando ha sonno, beve quando ha sete, mangia quando ha fame, è quasi un discepolo delle dottrine Zen. In tarda mattinata, passeggiando, ho ripensato alla nottata insonne, al suono rauco e meccanico del cane, un’esplosione nel silenzio generale; ho ripensato alle considerazioni dell’albergatore, degne di rispetto e di attenzione, in fondo. Poi, sono passato davanti a una macelleria e poi davanti a un droghiere…
*
Sorridono con la bocca storta. Indossano lunghe casacche bianche e lunghe scarpe di stoffa senza calze. I talloni strisciano sul selciato. Sono disposti ai quattro lati di Piazza ***, i bambini tengono in mano un palloncino rosa, i bambini stanno intorno a un chiosco, sul chiosco è distesa una tela bianca. Dietro il chiosco c’è un vicolo da cui sbuca un uomo con tre cani al guinzaglio, cani dal corpo tozzo e massiccio. Sotto i ponteggi s’inseguono, giocano a nascondino. Un acrobata vestito di metallo e un odore di vernice spray e di carne bollita. Dal sagrato di Piazza *** arrivano gridi festosi, canti, celebrazioni.
*
Sono seduti su sfere di metallo, sono una decina, fissano tutti un cellulare, sono un elemento decorativo di Piazza ***, tranne le dita agitate sono quasi immobili e molto seri.
*
La città di C. è un enorme elica il cui asse inizia dai monti e sprofonda in mare. I giri delle innumerevoli pale sono veloci, lenti, moderati, vorticosi, a strappi, a schiaffi, è una gigantesca elica guasta, malata.
*
Caro ***
nessuna fotografia, disegno, racconto o altro mezzo può descrivere la città di C. Solo il contatto con le sue strade, e una disponibilità all’osmosi, spesso estenuante, lasciano intravedere l’orribile singolarità di una città unica. L’osservazione acuta, penetrante è uno strumento considerevole ma non basta. Bisogna lasciarsi intaccare, per così dire, e aprire la porta senza accorgersene, quando ormai è troppo tardi per chiuderla.
*
Fanno irruzione scene, edifici, animali veri o raffigurati, odori, materiali, targhe, voci, rumori, rientranze, spigoli, donne enormi, tatuaggi, richieste, truffe, guide turistiche, trenini, altoparlanti, parlate, climi, assenza di vento, folate improvvise… interni squallidi, interni di una bellezza abbagliante, una porta socchiusa introduce in un breve corridoio sporco, dalle pareti spaccate, a cui è appoggiata una porta d’ingresso che sembra appena divelta dai cardini. Un colpo secco: è il portone che si è chiuso. Tre diramazioni, tre scalinate. Un’immagine di Cristo in ceramica. C’è silenzio. Il costante brusio esterno è rimasto chiuso fuori. Ci sono aperture simili a ingressi ma troppo piccole o troppo storte; accessi a scantinati, sportelli con le sbarre… è un palazzo altissimo, di larghezza imprevedibile, una scalinata affonda per un lungo tratto quasi in orizzontale e non si capisce perché abbia i gradini; conduce a un loggiato che si affaccia su un cortile, nel cortile un magnifico albero, un fico, e un pozzo. Una lunga e massiccia balaustra fiancheggia un’altra rampa sorvegliata da leoni stilofori, il naso e le guance smangiate dal degrado, le colonne di un marmo splendido venato di verde. In basso, da qualche parte, voci e rumore di acqua come una piccola cascata; in una larga spaccatura cresce rigoglioso il capelvenere.
*
Uno dei truffatori storici, figura ben nota nella città di C., è un arabo vestito di tutto punto, un uomo di circa 65 anni, con una bella barba bianca, un bel cappello marrone, giacca, pantaloni, scarpe, cravatta, fermacravatta, occhiali, grande anello, camicia… molto elegante. Gira con una falsa laurea, o certificato di studi o curriculum, si avvicina ai tavolini, è impeccabile nei modi come nel vestire; racconta di essere dottore in una certa disciplina vittima di angherie, soprusi, burocrati invidiosi che gli impediscono di esercitare qui, o nel suo paese; chiede un piccolo contributo per mantenere la famiglia e pagare le spese di un avvocato che cerca di difenderlo perché possa tornare a lavorare. Esibisce anche altre carte, ogni anno aggiornate nelle date e nei contenuti, tranne la falsa laurea, la stessa da almeno 10 anni. Esercita la sua vera attività di truffatore soprattutto nei giorni festivi quando le vittime, soprattutto straniere, abbondano.
*
Un giorno – era il periodo del Covid – si è avvicinato a un banco di frutta e verdura gestito da un arabo. Quel giorno non era elegante, non portava gli occhiali, non aveva fogli in mano; indossava una lunga veste sporca e delle babbucce. Anche la barba sembrava sporca. Si è rivolto al commerciante con arroganza: pretendeva per l’ennesima volta di rifornirsi senza pagare. Dopo un breve alterco ha preso qualcosa per pochi spiccioli, l’ha mangiata e poi ha sputato i noccioli sul banco, ha girato le spalle e se ne è andato gridando non so che cosa, forse maledizioni al suo compatriota peraltro non andate a buon fine.
*
Tutti trasportano piccole lapidi elettroniche, le fissano, sembrano consultarle con accanimento.
*
I gradoni di Via *** che delimitano gli sfiati sotterranei della sede centrale di una nota banca, hanno la forma di sarcofaghi. Attraverso le griglie soffia il respiro artificiale e caldo. Il sottopasso illuminato dai neon è uno dei luoghi più tetri della città. In questi giorni, sopra una delle reti, marciscono e seccano i fiori esuberanti di tre sterlizie.
*
Caro ***
avrai notato che nelle mie lettere non metto nessuna data. Non saprei dirti perché. Forse è una forma sciocca di reticenza o fastidio per calendario e ore; del resto, riporto spesso indicazioni di clima o fioriture o altro che lasciano facilmente capire, se non il giorno, almeno il mese, o meglio la stagione, per quanto il clima, nella città di C., subisca drastici capovolgimenti da un giorno all’altro. Inoltre, caro ***, tu sai che il tempo scandito dall’orologio non mi è mai piaciuto; per me è difficile accettare orari, appuntamenti e agende; ancora di più in questa epoca dove il peccato capitale sembra la perdita di tempo. Ma di quale tempo? E quale la perdita? E quale il guadagno? Nei giorni scorsi mi è capitato di vedere due clessidre incise sopra un marmo che fa angolo fra Via di *** e Via ***. Un’incisione raffinata ma imbrattata dalla solita scritta.
La città di C. è in campagna elettorale. Da settimane la propaganda mangia gli occhi da ogni parte. Inutile dirti che è oltraggiosa. In questi giorni, a ridosso della votazione, la vigilanza della città si è moltiplicata.
Oggi, mentre camminavo per Via *** strada vuota e silenziosa in genere, ventilata, abbastanza ampia, in parte ben tenuta, dalle tinte chiare, dall’assenza di auto posteggiate e manifesti – divieto d’affissione – perché sede di importanti istituzioni, musei, palazzi e proprietà della curia, ho guardato in cima, dove la strada svolta in Piazza ***, accorgendomi che non avrei potuto passare. Un addetto alla nettezza urbana spazzava la strada con un getto ampio e potente di acqua e disinfettante che ha interrotto giusto il tempo per aprire un varco a una colonna di poliziotti, circa una ventina, che si sono poi allargati a ventaglio: proprio come il getto d’acqua. Al centro del ventaglio c’era un individuo. Ho dato un’occhiata e sono tornato indietro di qualche metro.
La squadra di poliziotti era silenziosa quanto l’individuo; scendevano lentissimi e ogni tanto sostavano consultando i cellulari. Trasportato dal vento, arrivava il rumore e l’odore del getto di disinfettante: un odore acido che prendeva alla gola. Da un locale, musica brasiliana e odore di fritto; due senegalesi, col tipico berretto da marinaio, il camugin, ondeggiavano appoggiati alla porta del locale. Due carrelli sono sbucati ai lati del ventaglio dei poliziotti, due carrelli carichi di pacchi: uno ha svoltato in Salita ***, l’altro ha proseguito diritto nella mia direzione. In quel momento una nuvola più grigia, in un cielo già opaco ma abbagliante, ha creato per pochi secondi un effetto quasi di oscurità. Mi sono voltato verso Via ***, stradetta di raccordo, a dosso, dove un uomo si era accovacciato davanti a un portone e stendeva per terra un foglio di carta unta. In una piazzetta attigua scaricavano materiali, calcinacci, sacchi di cemento; lo sbuffo della calce imbiancava l’aria e il vento debole non riusciva a spostarla.
*
Dopo aver parlato per circa mezz’ora la guida tace, si pulisce gli occhiali, fa qualche smorfia, guarda nel vuoto. Ha spento il microfono, ha la voce roca, i gesti lenti. Lascia ricadere le braccia lungo i fianchi, sorride nel vuoto. Poi si appoggia a un muro, gira le spalle al pacchetto n. 4 –bis. Guarda in alto, vede lunghissime fessure grigie fra un cornicione e l’altro, i soliti piccioni posati sui davanzali. Anche oggi la luce è quella di una perla sporca. L’umidità atterra. Qualche folata agli incroci di certe strade, molti sono sdraiati per terra sui gradini di Piazza *** sotto Palazzo San ***, sfiniti dal caldo e dal vino pessimo. Una fossa di marmaglia, rovinata come le colonne, quei monconi bianchi e neri, denti lunghi e spezzati.
*
Gli affreschi si scrostano a grandi pezzi, da anni la facciata a levante perde la pelle, affiora il secondo strato, poi il terzo si raccorda ad altre zone deteriorate formando una geografia, una mappa, contorni di isole, continenti, paesaggi lunari. *** non poggia più la mano su una sfera, le sue dita s’immergono nei mattoni, *** non si appoggia più alla spada, il fianco entra nel cemento, *** poggia i piedi su crepe, spaccature. Le ali sono ancora intatte, come i seni e il fallo. L’animale con le ali di uno Stukas morde l’aria terrorizzato, le orbite del cavallo schizzano fuori, la donna si volta e benché protetta sembra scappare, l’orologio è fermo come il segnavento – i turisti scattano fotografie.
*
Piazza *** è vuota per il gran caldo. Lungo il perimetro, è caccia ai passaggi in ombra, anche infossati; i trolley rotolano sotto le colonne amputate con un bizzarro rumore di macchine giocattolo. A guardia di un vicolo, sotto i ponteggi, fra le luci rosse, un grande cane nero, sdraiato sulle zampe davanti, alza gli occhi e sembra controllare chi si avvicina. Ha il pelo ispido e grigiastro, lo sguardo né aggressivo, né docile. Una donna parla una lingua sconosciuta, parla ad alta voce, è seduta all’altro capo del vicolo; il cane volta la testa nella sua direzione e resta immobile. Una volante a sirena spiegata accorre accanto ai portici di ***. Da lontano si sente gridare. Un gabbiano vola in cerchio sulla pattuglia: dieci agenti, sotto il sole, sembrano piccoli e smaltati, soldatini appena verniciati.
*
“All’inizio del XXI secolo, in Piazza ***, imperversavano i predicatori cattolici sud americani. Erano perlopiù adolescenti e bambini sostenuti da un gruppo di adulti vestiti come se andassero a un funerale, a un matrimonio oppure a messa. Da questo gruppo si staccava un bambino col microfono in mano che sproloquiava come un gesuita sulla fine del mondo – era in ritardo – su Gesù in croce – sempre attuale – sui peccati abominevoli – sono sempre abominevoli – sulla non-vita di chi non crede nell’unico Dio, nel Salvatore, nel Resuscitato, nel Giudizio Universale. Microfono amplificato in mano, andavano e venivano sotto la statua del celebre armatore oggi imbiancata di sterco, una precoce canizie di escrementi gli ricopre infatti i capelli, cola sugli occhi e riga i vestiti del celebre cittadino. Gridavano litanie imparate a memoria con un tono lamentoso e pieno di minacce. Citazioni sconnesse dalle Sacre Scritture. Quando, finita la performance, rientravano nel gruppo degli adulti, scattavano gli applausi e un altro predicatore bambino, dal vestito immacolato, dai capelli impomatati, attaccava la sua predica. Mi sentivo soffocare da una nuvola di borotalco e naftalina, vedevo fiori di plastica, sentivo puzza di armadi e tarme. E la predica urlata nel microfono, rinforzata dalle cavità dei portici di *** mi schiantava i timpani. Era tutto squallido, miserabile, agghindato e sporco come un trucco sporco. La piazza era in pieno sole. In quello spettacolo nessun fascino, solo catechismo ammuffito, icone sempre uguali, raggi celesti tra nuvoli folti, un triangolo occhiuto nel cielo, peccatori tra le fiamme, diavoli col tridente e il tutto sulla bocca addomesticata, plagiata, di bambini.”
*
Bene. Oggi vi farò notare un aspetto interessante della città di C.: la città armadio o guardaroba. Stracci, scarpe, vestiti, mutande, calze, stoffe variopinte e ammuffite, sdrucite, sporche, consunte ma tenacemente appese a qualcosa. Ecco una scarpa allacciata a un cavo in Via ***, a due passi dalla sede di una famosa banca. Penzola lassù da anni, ruota, si aggroviglia. Essendo di gomma potrebbe pendere sulla strada per decenni. Ai volatili non interessa. Invece in Vico ***, luogo di storia antica, tracce di affreschi, archi ciechi a mattoncini, contrafforti di ardesia, finestre sfondate, plastica al posto dei vetri, un orsacchiotto di pezza è infilzato sui chiodi antipiccione – è sopra un capitello, da anni. Invece, in mirabile sospensione, abbiamo lassù, in Via ***, stringhe, assorbenti, felpe e, poco più avanti, in Vico ***, una tazza del cesso appoggiata al muro. Ora seguitemi. Ecco una pala di ventilazione in Passo della ***, forse recuperabile, forse manderebbe ancora vento, forse di tramontana, raffiche, pelle scorticata, cielo blu di ghiaccio, facce livide, labbra raggrinzite. Intorno vediamo siringhe, cartacce, cartocci, erbacce, muretti diroccati, muffa – anche un bell’albero di nespole mature che fa la gioia dei pappagalli. Da quel muro, appesa al filo spinato, penzola una camicia. Il portone verde con guardiola a sbarre, del convento di *** è stato rattoppato con una cancrena di vernice spessa dieci centimetri. In quel punto potete vedere come materie diverse convivano in beata armonia: legno, plastica, marmo, erba, vetro, metallo, vernice, condensati in piccoli, grandi e grandissimi grumi, escrescenze da cui spuntano fili, cavi, punte di ferro, piume. Perché visitare un museo di arte informale quando potete vedere dappertutto, nella città di C., capolavori anonimi che Fontana e Burri e Tapies avrebbero ammirato? Dentro quello sportello l’immagine di una santa; su quella balconata, anzi sotto, un palloncino a specchietti ruota e balugina; fra le pietre di un muro bombolette, confezioni, pacchetti – lo rinforzano. Quella spaccatura è stata riempita con gomma a espansione, così tanta che la spaccatura si è allargata: un bel rigurgito giallo e denso. Quel sovrapporta ha il cavaliere con la faccia falciata. Gli resta il profilo. Altre figure logore, corrose, con effetti geometrici. Una palma s’indovina, un cigno s’intuisce, un santo s’immagina.
*
Vico *** è un breve vicolo chiuso, molto scuro. Il muro in fondo è alto circa 15 metri, un moncone, grandi pietre scorticate e umide, il resto di un bastione, forse. Alla base del muro, in un angolo, una sedia di legno, e sopra la sedia una bottiglia di birra. La sedia è schiacciata dalla massa a cui si appoggia, sembra alta pochi centimetri.
*
“Ora le farò qualche domanda sulla città di C. Ma dovrà rispondere rapidamente, senza riflettere.
– D’accordo.
– Quale colore le viene in mente?
– Nessuno o piuttosto tutti ma sporchi, coperti da una patina dall’odore sgradevole. Colori vecchi, screpolati.
– Quale albero associa alla città di C.?
– Nessuno. Forse smilze palmette, qualche platano. Ma dove sono gli alberi nella città di C.? Ah! qualche fico.
– E i giardini che cosa le fanno venire in mente?
– Pubblici?
– Sì
– Incuria, poco verde, panchine dormitorio, ubriachi, cani senza guinzaglio, polvere.
– La città vecchia?
– Una carcassa perforata in tutte le direzioni da corrieri, biciclette, carrelli, mezzi per la raccolta dei rifiuti, centri per la raccolta dei rifiuti, unghie finte, ciglia finte, depilazione esibita dietro grandi vetrine, tatuaggi, ponteggi, tavolini poggiati su strati di merda di piccione, sedie incastrate fra una pietra sconnessa e l’altra, selciato semovente, scritte, simboli, graffiti su portoni, muri, colonne, pietre del selciato, porte, battiporta, cornici di marmo, scale, cancelli, sbarre, catene, vertigini, urli, cani aggressivi, zecche sonore a centinaia, a migliaia, un brusio inesausto di parole, merda di cane, piscio di cane, grovigli di cavi.
– Grazie.
– …
*
Caro ***
dato che siamo quasi in estate e già fa molto caldo, devo tenere le finestre aperte. Entrano odori e rumori poco gradevoli. Fra gli odori: puzza di fogna, spezie, vernici, fritto, carne bollita in un miscuglio a volte indefinibile. Nonostante l’abbondanza di deodoranti sparsi nella mia camera sotto forma di bastoncini immersi in un liquido profumato, gel sistemato in bagno e nei cassetti, gli odori penetrano e ristagnano. Fra i rumori accennerò solo allo svuotamento del vetro, la famosa cascata di vetro, rumore che non ha orari come i mezzi della nettezza che percorrono ossessivamente la città di C. a qualsiasi ora del giorno e della notte. La cascata di un materiale fragile e tagliente, che in un lungo boato si schianta in mille frammenti, evoca immagini poco piacevoli e dato il fenomeno acustico tanto elementare quanto frastornante provocato da pareti vicine e altissime su cui il suono rimbalza, questa cascata irrompe nella mia camera con forza moltiplicata dal numero di rimpalli compiuti. È uno dei principali temi sonori della città.
*
“Durante i primi due decenni del XXI secolo, la città di C. subì un’autentica rivoluzione nel modo di gestire la spazzatura. Scomparvero quasi tutti i contenitori all’esterno, e uno dopo l’altro vennero aperti locali o punti di raccolta dei rifiuti a cui potevano accedere solo commercianti e residenti. In che modo venissero individuati i locali e con quali criteri, ancora oggi non è dato sapere. Alcuni si trovavano proprio accanto a esercizi di ristorazione. Altri aprivano i cancelli davanti a sedie e tavolini di bar, caffè, locali. In pochi anni la città vecchia si ritrovò traforata da quelli che allora si chiamavano Ecopunti; spuntavano dappertutto, incastrati, incastonati, sfondati fra un negozio e l’altro. Una vera rete di locali dove depositare la spazzatura era sorta come una piccola città nella città. Il via vai di spazzini, sacchi, furgoncini era continuo. Qualche Ecopunto pare fosse di pulizia esemplare, altri erano sudici e puzzavano. Il maggior numero di questi locali era concentrato nei quartieri della ***, del *** e di ***. Piccoli, medi, grandi, erano ormai parte dell’arredo urbano. Nessuno poteva più frugare nella spazzatura. Gli accessi erano sorvegliati da personale specializzato: metà spazzino e metà buttafuori. Le più agguerrite nel far rispettare il regolamento erano le spazzine: muscolose e con le tute fluorescenti, piantate davanti ai cancelli a gambe divaricate, pronte al rimbrotto, al rimprovero, a scacciare l’indesiderato, spesso uno di un altro quartiere. Per aumentare la sicurezza le chiavi vennero cambiate ogni mese. Le video camere furono piazzate anche all’interno dei cassoni. Poi venne inserita una serratura a codice. Il codice veniva aggiornato ogni due settimane. La richiesta del nuovo codice avveniva compilando un modulo dove si doveva precisare la quantità di spazzatura, il genere, la forma e, se era il caso, perché la quantità o il volume di un certo materiale fosse aumentata in misura rilevante. Poi, venne introdotto un nuovo orario molto più ridotto che in passato. La nuova giunta deliberò che gli Ecopunti sarebbero rimasti aperti al mattino fra le 10 e le 11, al pomeriggio fra le 17 e le 17. 30 e la sera fra le 20 e le 21. Per evitare, si diceva, quel continuo via vai di sacchi, spazzini, furgoncini, camion, consegne, rumori, tracce di rifiuti, spazzatura sbalzata dai camion, disinfezione continua dei locali e delle zone attigue.”
*
Una vasca di pietra, due teste di leone e una colonna. Vi sarete accorti, lungo il tragitto, di una strana fioritura: papaveri di plastica dai grandi petali, a decine. Legati dove capita, decorano soprattutto Via San *** e Via del ***. Ci spostiamo di poco per vedere il palazzo di un poeta-notaro con due statue emerse di recente dall’ammollo in candeggina: sovrastano, bianchissime, un portone, hanno entrambe un braccio mutilato, sembrano tendere a un ricongiungimento impossibile. Sono speculari. Annodato a quella grata, ecco uno dei grandi papaveri di plastica però appassito come fosse un fiore vero. In quel negozio hanno scritto Male anziché Mele. Se volete approfittare… a 2,99 comprate un chilo di Male.


*
Raccolgo voci, frammenti di conversazioni, tracce di affreschi sotto i cornicioni; torri color seppia, sottili, piano dopo piano, inalberano bandiere sdrucite, interrotte da finestre, riprese fino alla punta che buca il cielo dipinto.
*
A che ora mi sono svegliato? Qualcuno parlava, era sul tetto. Sembravano voci giovani, profonde. Erano sconosciuti, probabilmente operai, ma chi li aveva mandati? Sono sceso dal letto e ho chiuso la porta; poi ho aumentato la velocità del ventilatore per coprire le voci. Adesso erano remote, smorzate. Mi sono quasi riaddormentato. Sulle pareti bianche ho fissato una goccia di stucco. Dall’esterno sentivo o immaginavo un rumore come il ronzio di un citofono guasto e poi colpi, sferrati da che cosa e su che cosa non era possibile capire. I portoni, qui sotto, sono altissimi e pesanti, nessuno riesce a chiuderli piano; risuona un colpo secco e insieme profondo che ho imparato a distinguere ma non la provenienza esatta.
Le voci sul tetto – forse non erano sul tetto ma dentro il palazzo di fronte o in quelli dietro oppure a fianco o sopra o appoggiati per un lato, uno spigolo, una parete – adesso mi sembravano più numerose. C’è stata una lunga pausa, probabilmente mi ero addormentato, e all’ennesimo risveglio ho sentito un rumore metallico cadenzato provenire dalla mia scala interna. Ricordo che ieri notte c’era quasi luna piena, un biancore sporco attraverso una finestrella col vetro opaco, entrava nella mia camera. Era una luce triste. Meglio la lampadina che appoggio su un cilindro di carta gialla opaca aperto per metà. Vi si riflette una luce piccola e calda e per leggere mi basta.
*
Riempite dai graffitisti con enormi scarabocchi molte pareti da poco ridipinte. La pittrice di strada oggi non dipinge, si limita ad addossarsi a un portone. Un uomo alto, longilineo, in completo azzurro attillato, ha il passo sonoro, percuote il selciato con i suoi mocassini di vernice, attraversa un portico. La pittrice stringe fra i denti grigi un mozzicone e non guarda niente. La giostra è ferma. Tra le fessure delle pietre cresce l’erba che in cima è già secca. Sotto i gelsi, macchie nere a centinaia. Un cane si è impuntato. Lecca i gelsi schiacciati.
*
Esasperante nelle continue giravolte, negli incroci, negli spigoli, il labirinto della città di C. esaspera anche per la varietà della toponomastica. Nessuno si orienta, neppure chi ci vive. Non si orienta, intendo, con i nomi. Le bussole sono piuttosto i negozi, i locali, qualche particolarità, qualche sfregio o assurdità architettonica. Si trova una strada ricordando una panchina storta, una statua che sbuca fra centinaia di auto, un portico con saracinesche alte e arrugginite. Oppure un odore.
*
Durante ogni inverno, per anni, appena il vento rinforzava, dal mio letto sentivo uno sportello o finestrella sbattere. Non era fastidioso. Immaginavo un boccaporto dimenticato dove s’infilava il vento, il boccaporto di una nave abbandonata ma che proseguiva il suo viaggio, senza timoniere, senza ciurma, avvistata al largo di una costa o di un’altra, in un mare o in un altro; segnalata a diverse latitudini, a vele spiegate, a superba andatura, oppure a vele stracciate, il legname scalfito, sconnesso, inclinata paurosamente, gli alberi piegati, le sartie in balia del vento. E sempre quello sportello il cui colpo secco e ripetuto centinaia di volte si udiva anche in mezzo al fragore di una tempesta. Di notte il vento s’ingolfa e rimbomba sul mio terrazzino lungo e stretto, cerca una via di uscita, sembra arrotolare arbusti spinosi, spingere sabbia e accumularla davanti alla porta. Qualche scheggia di ardesia vola nel vuoto. I rumori della piccola bufera sono quasi protettivi. Resto nella mia branda, in ascolto, aspettando il momento in cui lo sportello o finestrella, fra tanti soffi e boati, batterà il suo colpo secco e ostinato.
*
Ho ricordato Via del ***, di notte. Forse d’inverno, un inverno di molti anni fa, gelido. Di notte è quasi insopportabile. Soffia teso, inarrestabile. In Via del *** c’erano pochi uomini, forse tre o quattro. Nelle case silenzio, oscurità, finestre e fessure ben tappate. I mulinelli afferravano carta, polvere; i residui di qualsiasi cosa venivano risucchiati verso l’alto o schiacciati sulle pietre.
Dall’angolo di Vico *** uscì lentamente un grande contenitore rettangolare di plastica poggiato su un carrello. Dall’interno proveniva una specie di sciabordio e ogni tanto si sentiva un colpo contro le pareti. Un uomo, attraverso la sciarpa, gridava ripetutamente di fare attenzione. Il contenitore oscillava su rotelle troppo piccole per quel carico e per quella pavimentazione sconnessa. Pochi lampioni illuminavano Via del ***. Dall’interno della vasca si sentivano fremiti. Un uomo sbucò dall’ombra e, appena sopraggiunto, stringendosi dentro i vestiti, disse: “Bisogna sbrigarsi. Dentro la vasca il movimento aumenta, le rotelle sono già piegate.” L’uomo che spingeva il vascone sembrava esausto, ma non dal peso, bensì dalla tensione di mantenere in equilibrio il carico. Si fermò per un attimo. Uno spruzzo lo raggiunse al viso. Un altro a una manica. Il bordo del vascone era più alto della sua testa di almeno venti centimetri. In una mano teneva una rete a maglie strettissime fissata a un lungo bastone. Il vento continuava a spazzare la strada. Un altro uomo si mise a spingere il carrello ma sembrava meno attento, benché più forte del suo compagno. Una delle ruote si era incastrata in una fessura del selciato. Intorno alla vasca adesso c’erano quattro uomini che tendevano un telo provando a circondarla. Il vento rendeva l’operazione molto difficile. Uno infilava una corda dentro gli occhielli e tirava e annodava. Le raffiche gelide gonfiavano e schiaffeggiavano telo e uomini. All’interno della vasca l’agitazione sembrava aumentare, si alzavano spruzzi il cui biancore sporco era illuminato dai lampioni. C’era uno strano odore. Come di grasso.
*
Oggi faremo il tour degli animali. Fantastici e veri. A volte mischiati. Vedremo cavalli, capre, cani, basilischi, draghi, cigni, struzzi, maiali, pavoni, pesci, rapaci, leoni, serpenti, colombe, salamandre e molto altro. Vedremo anche un Tirannosauro di cartapesta ospitato nell’abside della chiesa di Santa ***, protetto da sbarre alte e spesse, come fosse in gabbia. Se volete possiamo aggiungere lo zoo sui muri: i graffiti, i disegni, gli stampi. Allora vedremo topi e pipistrelli, farfalle, gechi, bruchi, pesci mostruosi, formiche, ragni e impronte di chissà quale animale…
*
Sono stanco. Chiudo il libro e tengo aperti gli occhi attraversati da immagini: acqua, ragnatele o crolli. L’acqua è una figura che dura un istante. Un colpo di vento fa tremare la ragnatela. Mi ritrovo in piedi dietro una grande finestra a due battenti e sto guardando una montagna. Sono solo. Da sette mesi vivo da qualche parte nell’entroterra. Il tronco bianco di una betulla si appoggia ai vetri. Nel cielo una miriade di stelle ed è scoppiato un incendio sul crinale dietro cui sorgerà la luna piena. Più tardi vedrò le fiamme agitarsi contro il chiarore abbagliante mentre mi avvicino alla città di C. Sono stanco e quelle fiamme erano convulse, il cielo nero, profondo, terso e gelido. La luna, luminosa e netta sembrava un disco tagliente. Appena chiudo gli occhi, i personaggi del libro si muovono accanto alle figure viste oggi, le incrociano, si scusano, le spingono. Le attraversano. Sembrano divertite e dispettose. Una goccia d’acqua cade dentro l’acqua e il tonfo dà il segnale a un edificio che crolla senza polvere e senza rumore.
*
Li rivedo alti e scuri benché non lo fossero. Oppure col corpo e il viso largo e con la pelle bianca e opaca, appena arrossata dal sole. Li rivedo sotto gli alti cancelli della facoltà di ***, quasi silenziosi, a scambiarsi cenni, poche parole come in codice. Uno è appoggiato all’ingresso e un altro è in fondo alla scalinata, sotto l’imponente cancello di Stradone ***. Sembrano molto lontani l’uno dall’altro, separati da chilometri e dislivelli d’aria e muri. Una voce smorta richiama un cane. La terra dei Giardini *** è asciutta e compatta, le piante immobili, il copertone-altalena pende senza un’oscillazione, anche minima. Gli escrementi sono secchi. Le pesche settembrine sono verdi. Qualche raro soffio di vento infila le scale ripidissime, svolta fra un muro, un palazzo, una parte del complesso di San***. Rinfresca per un attimo. Li rivedo mentre sono appoggiati, trasognati, stanno quasi dormendo. O inghiottiti dall’ombra di Vico ***, mentre in fretta chiudono un portone. Sono tornato molte volte negli stessi luoghi, constatando piccoli cambiamenti, oggetti che non c’erano o avevano un’altra forma. Un tronco è stato sezionato. Com’è secca e screpolata la terra! Anche la ruggine è asciutta. Le scaglie di un telaio arrugginito con resti di vernice, brillano sotto il sole della metà di giugno. Salendo la ripida scalinata i cui gradini riflettono una luce fredda, incontro facce che non conosco, sento uno spostamento d’aria né piacevole né altro, solo uno spostamento d’aria.
*
La facciata dell’ex chiesa di S.*** ha davanti un cantiere. Nell’ora più calda, un solo operaio dall’andatura dinoccolata entra dove i non addetti non possono entrare. Le ombre sono appuntite. Le baracche di lamiera abbagliano. I graffiti, in parte slavati, sembrano colare macchie sul selciato. Un edificio tagliente, azzurro e piatto impone la sua mole, estranea a quello che ha intorno.
*
“Perché ritorni tutti gli anni negli stessi posti e quasi sempre da solo, che cosa cerchi ancora, che cosa pensi di vedere? Hai consumato il tuo tempo; sei ostinato e ancora brancoli in luoghi che dovresti conoscere a memoria. Stai fingendo? Ripeti il solito percorso con qualche deviazione, ne parli come di una scoperta, fosse un fico che per anni non avevi notato, un archetto di mattoni, un portone di lamiera, di toppe di lamiera, come ce ne sono tanti, e che solo tu trovi interessante. Quella grata polverosa a livello del pavimento, quella prospettiva con una luce diversa, un intonaco rifatto, non meritano di essere notati, e men che meno scritti o raccontati. Del resto che cosa raccontare di un intonaco? o di una porta? Eppure anche oggi hai notato un’apertura con le sbarre, le sbarre avvolte dalle ragnatele, sudicie, accanto a un magnifico portale. Appoggiato alle sbarre un quadro con la cornice sgangherata, una marina con il tipico borgo di pescatori, le casette colorate… una grande macchia blu, una specie di nube d’acqua enorme, si alzava da un angolo del quadro, la prospettiva era sbagliata, sembrava sbagliata, come le case e le altre linee, tutte sbilenche, il dipinto era rozzo e piatto, ma prendeva rilievo, si alzava nell’angolo trascinato da quella massa blu che incombeva sull’abitato, abitato peraltro che sembrava evacuato a guardar meglio, nessun uomo, né alle finestre, né sul molo, solo gabbiani in attesa.
*
“Qui sorgeva l’officina dei mostri di cartapesta. Dinosauri, giraffe e altri animali il cui scheletro era costruito con giunchi ed erbe flessibili. Erano alti anche dieci metri. Una giraffa blu cobalto con grandi occhi bianchi affiancava un dinosauro dalle unghie affilate. Venivano pacificamente esibiti dentro le rovine di una chiesa, S.***, erano rozzi e simpatici. Ogni animale aveva una valvola dentro cui veniva soffiata aria; l’animale si gonfiava in certe parti dando l’idea di un aumento di muscolatura o di un cambiamento di espressione. Per esempio, il dinosauro aveva la valvola dietro il collo. Insufflata l’aria aumentava il volume della gola che sembrava enorme e palpitante. A volte l’aria in eccesso lacerava la cartapesta e gli animali venivano rattoppati come vecchie camere d’aria bucate. Le toppe però erano di vari colori, così l’animale perdeva la monocromia e prendeva una certa vivacità. Oggi sono rimasti pochissimi frammenti: qualche lacerto di cartapesta inchiodato alle pareti, una scarsa documentazione fotografica.”
*
La struttura a corridoi o corsie intrecciate, svolte continue, ingressi senza porte, crea un senso di allarme, di attesa angosciosa di un qualche evento che s’immagina sgradevole, nocivo; l’ambiente sezionato in crepacci, migliaia di pareti in caduta, le gigantesche facce di marmo grottesche, il disorientamento… Si varca sempre una soglia. Si cerca un nome, un rumore, un’edicola votiva, come una barca di notte scruta il mare per individuare un gavitello lampeggiante e calcolare la propria posizione rispetto ad altri punti. Riferirsi a un rumore è ingannevole: questo rimbalza da una zona all’altra; riferirsi a un nome, nell’intreccio fittissimo di targhe, accentua lo smarrimento; il vicolo che si credeva già percorso è un altro, e alla prima deviazione – quale? – sotto un arco che si credeva già oltrepassato, davanti a un battiporta che si credeva già visto o un famoso palazzo di cui non si ricorda il nome, l’orientamento vacilla, la colonna di fronte sostiene una targa arrugginita, illeggibile.
*
Sono le 17.10 di un lunedì che precede di un giorno l’estate. Il caldo è opprimente tranne in qualche vicolo buio, la cui oscurità è rafforzata dai ponteggi. Alla base dei tubi cartacce, mozziconi e liquidi. Fra le sbarre avvolte di nastro bianco e rosso sbuca una puttana. Una figura magra, alta, coi capelli lunghi quasi bianchi raccolti in parte sulla nuca, di una magrezza malata, s’intrattiene con qualcuno che non vedo e una porta spalancata per il caldo dà accesso a Vico ***, tutto spigoli, sporcizia, carrelli, lattine di birra schiacciate, cartoni, facce di cuoio screpolato, rosse o smorte. Le bottiglie di plastica schiacciate, quasi piatte, danno un curioso effetto ottico. Sembrano intarsiate nel selciato, un selciato variegato da oggetti dimenticati, abbandonati, corpi sdraiati. C’è un’ostinazione a riproporsi anno dopo anno nello stesso punto da cui si è stati scacciati tante volte; spostandosi di qualche metro si spera di non attirare l’attenzione; confondendosi all’uscita di un supermercato con altri consumatori si attua una specie di mimetismo e si ribadisce la propria presenza proprio lì, come un diritto acquisito.
*
Dialogo minimo sul clima:
– Oggi fa caldissimo.
– Sì, ma meglio di ieri. Di mattina presto c’è fresco… mi sembra.
– Il problema è il caldo umido; quando ero a *** il caldo era secco. Qui, no.
– Forse pioverà nei prossimi giorni.
– Ho paura di qualche alluvione o bombe d’acqua. Il Po è in secca, l’acqua è razionata.
– I condizionatori vanno a metà regime.
– Staremo a vedere.
– Sì, ma camminare sotto il sole… al mare si sta bene…
– Sono andato al mare: c’era da morire.
– Forse qualche nuvola, ma al nord… nell’entroterra…
– Magari arriverà fresco anche qui.
– Se pioverà, qui dopo sarà peggio, ancora più caldo umido.
– In effetti…
*
Mentre il mio gruppo si sparpaglia per la città a fare acquisti, io entro nella vineria di Vico *** e bevo uno, due, tre bicchieri. Seduto coi gomiti appoggiati sopra una botte considero la mia vista, soprattutto l’occhio destro, che si offusca. Non è niente di che: dopo un giro coi turisti mi accade spesso. Anche i gesti diventano opachi e lenti. E ho il solito tic alla spalla destra che salta. Mi tremano un po’ le mani. Di solito al terzo bicchiere la spalla si acquieta, la vista migliora, le mani tornano ferme. Scambio quattro chiacchiere col cantiniere e non so su che cosa. Ricordo scarpe di gomma che avevano una suola come una piattaforma larga e spessa su cui poggiava un’altra suola. Erano di un bianco immacolato. Tenevano il piede isolato dalla pavimentazione, rialzato di molti centimetri. Un vero carro armato o una chiglia di motoscafo. Dei miei gruppi non ricordo quasi mai una faccia o la ricordo per poco. I cappelli sono tutti uguali, gli occhiali anche. Il modo di ridere è fatto in serie. Un uomo senza un braccio entra nella vineria, ha un viso interessante, scuro, gli occhi astuti, piccoli. Magro. Si appoggia col fianco al bancone e mi guarda per un attimo. Poi fissa il vuoto o così sembra. Fissa il muro di fronte, tiene la testa ferma. I passanti scorrono lenti, veloci, a precipizio, quasi fermi, a indugiare davanti alla vetrina della vineria che espone bottiglie da collezione e vecchie botti, cavatappi di due secoli fa. Fra mezz’ora andrò a radunare il mio gruppo che sarà carico di pacchi, sudato, esaltato.
*
Ci sono giornate che non si dimenticano; sono poche e spesso legate a un ricordo sgradevole o doloroso. La memoria di tutto ciò che rattrista, offende, disgusta è fortissima e assale quando uno è impreparato, crede di aver dimenticato o s’illude di essere sceso a patti con certi episodi della propria vita. Il disgusto non è quasi mai assoluto, inattaccabile, lascia un margine imprevisto da rosicchiare. Così oggi il volto di uno sconosciuto, un abito, un modo di parlare, un odore, un dettaglio. In apparenza niente degno di nota, niente di nocivo, tutto trascurabile, pronto per essere archiviato definitivamente. Invece tutto resta nell’angolo degli occhi, agganciato, trasportato, spostato di spazio e di tempo, sul punto, sempre, di rientrare al centro dell’attenzione, di imporsi, bucando la pupilla.
*
“Andavamo, noi appassionati di lirica e di donne, in Piazza *** dove al pianterreno c’era un bordello e al secondo piano una scuola di canto”, dice uno con i capelli tinti e la pelle tesa dagli interventi di chirurgia plastica. “Non trovo la piazza sulle mappe, mi piacerebbe tornare sotto quel portone e ricordare meglio gli scambi di battute fra le cantanti e le puttane. Gustosissime. L’insegnante di canto soprattutto aveva il dono dell’umorismo colto e insieme popolare. E una delle puttane aveva una voce meravigliosa. A volte partivano duetti e anche cori, s’intrecciavano variazioni da caserma su arie celebri e canzoni napoletane. La scuola di canto era di fama internazionale, dicono, e il bordello era di fama nazionale, esemplare per gestione e pulizia. Chissà… adesso il palazzo non ci sarà più e Piazza *** non compare neppure sulle cartine…
*
“È un errore, un errore di stampa. Le assicuro che è un errore, un refuso. Del resto ne avete fatti circa un centinaio. Avete sbagliato direzione, nome, posizione. Quel che è a destra è finito a sinistra, uno slargo è diventato una via, molti vicoli sono stati dimenticati, Piazza *** è diventata Piazza ***. E la mappa adesso è in tutta la città. Che cosa pensate di fare? Niente? No, non potete correggere, l’errore è strutturale, dovete rifare tutto. Dunque? Ma perché parla d’altro? Che cosa c’entra? Ma non c’entra nulla! Dovete rifare tutta la mappa…”
*
Il giro delle pale è simile al vortice dei vicoli e manda lo stesso rumore di aria sottratta, succhiata via. Un tunnel. Laggiù avete un’uscita: un confine o soglia che immette su un altro vicolo sormontato da un arco che sbuca in un vicolo dove sui gradini di un palazzo vedrete un piccolo accampamento di ubriachi e alle sbarre di una finestra vestitini appesi ad asciugare e attraverso le sbarre un interno squallido le cui pareti sono abbellite da stelle adesive, cuoricini e scritte in rosa. Osservate anche la quantità di muffa fra i mattoncini sconnessi e la gigantesca ombra di una tettoia metà di plastica e metà di metallo: un locale profondo, fra due palazzi, dove s’innestano decine di tubature, protetto da una lamiera e da filo spinato. Se vi piacciono i graffiti fluorescenti venite qui di notte e osservate accendersi quelle pareti. Vico ***, piuttosto uno slargo che un vicolo, non è più sovrastato da un magnifico arco di cui restano le colonne e un inizio. Qui molte strutture iniziano e non finiscono. Quel terrazzo compresso fra due pareti, infossato, inizia con una balaustra di marmo e finisce come raspato via, limato, per dare spazio a una canna fumaria enorme, altissima. Il portale di San *** ha un’anta di ferro e una di legno scheggiato.
*
Sui gradini pezzi di carta e lattine di birra, sui gradini che portano davanti all’ingresso bottiglie di birra e vino in cartoccio. Dietro la porta a due ante colpi di tosse convulsa. L’anta sinistra, di legno, è sfondata alla base tanto da far passare un braccio. Il quadro del citofono è appeso a un cavo. Dalla spaccatura esce un liquido, forse la condensa di un climatizzatore. Il palazzo si affaccia a sud sopra Via di ***. Di fronte all’ingresso c’è una finestra protetta da sbarre che servono per asciugare i vestiti. Accanto alla finestra, conficcata per metà nel muro, c’è una palla di cannone. In Vico *** dietro un cancello, spazzatura. Passando sotto un arco sordido, si sbuca in Via di ***. Sui tavolini di acciaio becchettano i piccioni. Passa un’ambulanza a sirena spiegata, la segue l’auto dei carabinieri, silenziosa. Che cosa è successo? Poco più avanti si sente il ronzio della folla che accorre, attirata da un incidente forse, forse è cosa da poco, del resto in ogni metropoli accade qualcosa tutti i giorni, la gente gira, telefona, si fotografa, fa le previsioni del tempo per la prossima ora, la serata, l’indomani, si affaccia sull’incidente. Il caldo umido è raddoppiato dopo una pioggia esile, i gabbiani roteavano schiamazzando stamattina in un cielo molto grigio, molto basso, ma non fermo, con accenni di schiarite temporalesche, e il vento soffia da nord, incontra aria calda e ci saranno temporali con piogge torrenziali per tutto il giorno. “No, non pioverà, dice uno, con grande sicurezza, avremo mesi di siccità, razioneranno l’acqua.” In piazza *** gettano grossi pezzi di pane ai piccioni e un odore di spezie e un odore di carne bollita e un odore di fritto sono le essenze dell’aria in quei metri, non pochi, e anche oltre, dove il vento sposta le particelle, la polvere, e le imbuca.
*
… poi mi sembrava che la luce di un riflettore, una luce potente, esplorasse la facciata e poi puntasse sulla porta, restringendo l’angolo di campo come uno spot e illuminando solo il battiporta a forma di drago. Ero sdraiato sui gradini di marmo di un palazzo in Vico ***, fra pozze di vino, bottiglie di birra e cartacce. Qualcuno rideva. Mi guardava dall’alto standomi sopra a gambe divaricate, fissandomi il viso. Ero ancora annebbiato, facevo fatica a tenere gli occhi aperti. “Buongiorno!” mi ha detto sorridendo.
Mi diceva di asciugarmi la barba e di tirarmi su in fretta perché stavano arrivando gli spazzini a disinfettare la scala e il vicolo. “Getti forti, diceva, ti faranno male, ti andranno negli occhi, puzzerai di disinfettante. Alzati.” E mi tendeva la mano. La mano, mentre cercavo di afferrarla, arretrava. Così afferravo l’aria, il niente, e tuttavia cercavo di stringere anche quel niente come fosse carne o pietra o metallo, qualcosa di solido, insomma, a cui aggrapparsi. Sentivo che non sarei mai riuscito ad alzarmi: troppo vino, troppa fatica, troppo caldo. “Potresti rotolare giù dai gradini, sono pochi e poco ripidi, diceva.” E di nuovo mi tendeva la mano e di nuovo arretrava.
*
“Certo che preferisco un intonaco spaccato, una pietra porosa, un tombino o qualcuno che corre e svolta l’angolo e sparisce, oppure una balaustra consumata dal salino o macchie di vernice, alla tela di un qualsiasi pittore famoso che ha addomesticato, controllato ogni dettaglio con una tecnica superba, anche lo schizzo di saliva di un cane che abbaia, anche le mani contratte dalla rabbia e l’impotenza sono neutralizzate da un’esecuzione perfetta. Non si sente neppure l’eco di un dramma o uno scoppio di risa. Che cosa me ne faccio? Ammiro? A bocca aperta? Sto zitto? Aspetto di girare per strada ancora una volta per incontrare una sterlizia sbucata chissà come da un’aiuola sporca contro uno sfondo degradato e ripasso per vederne la sfioritura, poi il secco definitivo, fino alla prossima stagione.”
*
In Salita di S*** si appoggia a una rete di metallo, la stringe con le mani. Oltre la rete un gruppetto, forse sei o sette, fra uomini e donne. Il cielo è grigio, è caduta qualche goccia, si è alzato il vento. Sui mattoncini del selciato macchie nere e nòccioli di prugne. Fra una cancellata da caserma e l’altra un muro alto e compatto.
Si rivolge al gruppetto e dice:
– Scusate!
Il gruppetto si avvicina alle sbarre. Avanza una donna piccola sui 50 anni.
– Scusate che cos’è, chi siete?
– Un collettivo.
– Sì ma che collettivo?
– Un collettivo di persone.
– Ma che cosa fate?
– Organizziamo.
– Sì, ma che cosa?
– Stiamo preparando.
– Sì ma quei mostri di cartapesta?
– Serviranno.
– Ma avete un programma?
– Se entra dall’altro lato troverà un pieghevole.
– Mi scusi, siete quasi sempre chiusi. Vi autogestite?
– Sì.
Stringe più forte le mani intorno alle sbarre, si gira verso di me e scuote la testa.
*
I Giardini *** sono terrazzamenti, forse rovine di un parco, forse qualcosa che non è mai stato e non è niente: cespugli di alloro malati, una ripida scalinata e una costruzione rossa che incombe. La scalinata è lunghissima, attraversa diversi livelli, passa accanto ai Giardini ***. La prospettiva verso il basso è una spaccatura ondulata. I terrazzamenti hanno pochissima erba e molta terra, oggi polvere.
*
Non si vede bene. Scende la foschia sul mare, sul porto. Da lontano il rintocco di una campana; è la campana della giostra di Piazza ***, sembra ancora più lontana, come andasse alla deriva. Le locandine sono cadute. Diversi colpi di vento abbattono. Qualcuno cammina impettito in diagonale, impugna il cellulare come una spada, procede come su un carrello, come su una rotaia e parla ad alta voce. Su quel tronco sono raddoppiate le scritte; è inciso fino al bianco. Molti negozi chiusi. È aumentato il numero degli altoparlanti intorno a Via di ***, intorno a Piazza ***. A che cosa serviranno? Un gruppo di 60 turisti procede compatto, bandierina in testa, affronta Piazza S.***. Allora si cambia strada, si gira intorno a San***, si scantona. Un mobile bar in disuso è appoggiato a una parete, contiene qualche libro e una zuppiera di ceramica. Le lampade rosse illuminano un vicolo buio, le lampade dei ponteggi. In Piazza *** c’è una costruzione quadrata di legno e strisce di carta da cui la gente entra ed esce.
*
“Guarda come cammina, guarda come cammina…” e non capisco se parla di una nuvola o di una donna.
*
Mi ritrovo a fotografare angoli e palazzi ripresi tante volte, persone, insegne, la solita statua, oggi con una luce impastata, uniforme. Nessuna ombra portata. Perché in un passaggio stretto uno mi vede, mi squadra e torna indietro? Non subito. Ha indugiato ruotando per tre quarti su sé stesso poi, come avesse ricevuto un comando, è tornato indietro. Le pareti del breve passaggio sono gialle. Verso sud si vede l’arcata che ride di Palazzo S.***, ponteggi, cavi penzolanti, poca gente dato il caldo umido. C’è, come tutti i giorni, un uomo piccolo, grasso, dalla faccia gialla, sempre col sigaro in bocca. Il colore del viso è sgradevole come il modo di guardare, un modo padronale, come se lo spazio intorno fosse di sua proprietà. Il vento rinforza e i cappelli per turisti svolazzano, le corde di un’arpa vibrano da sole.
*
“Vedrai che ci sarà tempesta… verso le due.” Sono seduto qui, in questo chiostro, e ascolto le chiacchiere degli altri, vedo scendere e salire, mi colpisce un vestito rosso fiamma, un passo energico, il bianco delle spalle, gli animali fantastici dei capitelli di S.*** e un odore di terra in cielo.
*
In genere mi attira qualsiasi forma che accenni a un vuoto, a un’accoglienza, anche pericolosa, non troppo brusca. Dislivelli o un vaso; cavità, conchiglie, vasche, arcate, archi rovesciati, portici. Lo schiocco di una mano contro l’altra è un colpo di fucile in Piazza ***, oggi semideserta. Fra i mezzeri mossi dal vento sbuca la faccia del venditore.
*
Ho dimenticato quello che volevo scrivere. Fisso la copertina di un libro sulla città di C. Una foto presa dall’alto: in primo piano Porta ***, in fondo, dopo qualche famosa cupola e campanile, il porto. Non ricordo quello che volevo scrivere. È legato alla città di C.? E se è così, a che cosa in particolare? Un rumore, un sogno, il ricordo di un episodio, di una strada? Lo avevo bene in mente, da pochi minuti. Doveva essere ben trascurabile per finire nell’oblio in pochissimo tempo! Sarà sommerso da vernici o strati d’acqua forse più insignificanti di quel che volevo scrivere. Non posso saperlo, non posso ancora saperlo, ammesso che venga mai a saperlo. Non sento nessun movimento sul fondo. La melma è compatta.
*
Il volatile che ho visto ogni anno sul molo, a inizio primavera, azzurro e rosso, col becco affilato, in discesa rapida e precisa dentro l’acqua, è un Martin Pescatore fuori dalla sua zona. Non l’ho mai visto più di due o tre volte. Aspetta sopra una ringhiera, si tuffa e scompare non so dove. Ricordo piume quasi fluorescenti.
*
“Più avanti. No, più indietro. Sì, sopra le lettere. Arrampicatevi. Così. Passami la bacchetta, annoda il nastro, assicuralo bene. Ieri è volato via, senza il nastro gli ultimi non mi vedevano, qualcuno si è perso. Uno l’ho ritrovato dentro un getto d’acqua, un altro contrattava per comprare dei fossili falsi.”
Sotto un tendone carico di escrementi di piccione, in Vico ***, che cosa fanno? Davanti hanno una parete grigio-nera, sotto i piedi un selciato sporco, sopra, molto in alto, una fessura di cielo, a pochi metri un bidone della spazzatura. Ristagna odore di calamari alla piastra come odore di pelle bruciata. Stanno sprofondati nell’ombra, sono circondati, guardano un monitor. Vico *** è oblungo, schiacciato, contiguo a un vicolo chiuso da cancelli. Passa un cane e accenna un movimento delle mascelle contro una gamba. “Se lo rifà, dice uno, gli sparo in bocca.” Arriva il camion della spazzatura seguito da un furgoncino con sirena lampeggiante e sonora.
*
Avrei voluto essere da un’altra parte. Oppure non vedere quello che vedevo. Nessuna sorpresa, in realtà. Un ritorno di massa. La leccata in massa del gelato. La pittrice addossata a una vetrina, in Piazza di ***, disfatta dal caldo e dal vino pessimo, qualche foglio dipinto scivolato per terra. Meglio non guardare i dettagli: né edifici, né muri, né persone, né gesti, né scritte, né affissioni abusive, né tendoni instabili per il vento, né camion della spazzatura, né biciclette, né monopattini elettrici, neppure quei rigagnoli sospetti, quelle secchiate di ammoniaca. Non guardate i dettagli, i cavi a migliaia, la centrale termica con i fili annodati, un groviglio inestricabile, raccordi e ponti, vecchi, nuovi, tutto insieme in una scatola dietro un cancello incastrato fra muri.
*
Un brusio, volevo solo un brusio, e un po’ di luce, ma non quei tamburi, quei gruppi elettrogeni, quelle voci acute, quei morsi all’aria, quel riflesso sulla plastica o sul metallo, quei cani a pelo corto, simili a sciacalli, le auto in coda, le carrozzerie bollenti, la corsa ad acchiappare un cartoccio di fritto, il camion della spazzatura che sosta all’altezza del naso. E il chiasso, il chiasso provocato da una persona sola, col cellulare, il vivavoce a tutto volume, il cellulare che fende la folla, innalzato come una lancia allo scopo di filmare, gli scambi di spazzatura, ritrovamenti, in un angolo, lo stemma di una celebre famiglia sfaldato, lo striscione arrotolato, sospeso, di una mostra finita da un anno.
*
Il primo tombino è a labirinto, il secondo a zampa di gallina, il terzo è una variazione del primo. La grata con tre feritoie sotto cui passa l’acqua nera, ristagna. Mi sposto tre volte per l’insopportabile odore, ascolto la storia del cardellino che tolse le spine a Gesù e si macchiò di sangue, parliamo di un’edicola in Via S. *** lasciata andare in pezzi. Oggi mi accorgo che un commesso è mancino – mentre taglia la carne. Uno entra in un negozio schioccando le dita, un altro fischia, è acuto, insistente. Alzano altri ponteggi, calano e sollevano assi di metallo, corde, secchi, caschi. Una corda oscilla ma non per il vento oggi assente. Uno ha le ossa disarticolate e sporgenti. Un giorno gli bucheranno la pelle, penso, e si vedrà il telaio. “Ho scoperto nel levante tre pale d’altare, sono nel sotterraneo di una chiesa sconsacrata. Seguo certe tracce e incontro collaborazione.” Mi prude la pelle, forse per il caldo umido. “A Villetta *** ci sono circa undici colonne senza busto. Ne rimane uno, quello di ***, impiastrato di vernice. Una colonna è sdraiata in un’aiuola. Il busto è ben ventilato, guarda il mare a ponente con la faccia un po’ corrosa, come i capitelli del chiostro di S.***.” C’è un altro busto con un occhio bruciato, è in cima al parco della Villa di C. Dentro lo stagno dai riflessi smorti, s’impilano tartarughe nere e gialle. La collezione di busti ottocenteschi, che nessuno al mondo invidia, vigila sui passanti e sugli alberi. La rete nera ha lo stemma della repubblica, qualche volta abraso. Dentro le gabbie dove c’erano gli uccelli esotici è vuoto e polvere. Una pietra imita un volto. Il caldo aumenterà, dicono. Ma la parola d’ordine che oggi attraversa i vicoli è: arrivano i turisti, arrivano le navi. Aumenta il consumo di vaselina, aumentano i reticolati di tavoli, sedie, ombrelloni, diminuisce lo spazio per il cittadino. Il quarto tombino ha un motivo a virgole. Sarebbe un eccellente superficie per il frottage. Intorno agli scoli, liquidi lattescenti. La rete nera non scorre.
*
Oggi verso le 13,30 entro nella Chiesa di S.*** e leggo un cartello scritto in cinque lingue: La visita alla chiesa è gratuita. La visita ai pochi metri che separano l’ingresso dalle navate è gratuita, vero, poi tre sbarre di legno ne vietano l’accesso. Mi guardo intorno: a ridosso delle sbarre un altro cartello: è gradito un contributo per la manutenzione della chiesa.
*
Stanotte, nel dormiveglia, registravo i versi dei gabbiani: a volte sembra uno sghignazzo, oppure una risata, a volte uno strumento a fiato, un incrocio fra clarinetto basso e sax baritono, oppure si modula a singhiozzo, o esprime collera, incitamento.
A volte è frastornante fra le pareti dei palazzi, gli abbaini, le terrazze, i cornicioni, le innumerevoli scatole con cui è costruita la città di C. Ho sognato che l’impatto sonoro sbriciolava bastioni, curvava campanili, spaccava vetrate. Bastava un piccolo stormo, e quel verso, che ricorda anche un barrito e una minaccia, faceva tremare i tetti. Una parte dei gabbiani si staccava dallo stormo e s’imbucava nei vicoli, emettendo una specie di fanfara di guerra.
*
Sopra una tettoia, lungo Via di ***, un paio di scarpe, lattine di birra e la carcassa quasi disseccata di un piccione.
*
Risalendo una scala quasi buia, sosto sul primo ballatoio e si apre una porta. Dall’interno nessuna luce. A pochi centimetri, in un debolissimo chiarore, il contorno di un corpo che sembra alto, è fermo sulla soglia. Forse avevo sentito girare una chiave, forse avevo rallentato. Venendo dall’esterno, con gli occhi ancora abbagliati dal riverbero di un cielo opaco e luminoso, sono passato troppo in fretta in un ambiente scuro. Quanto tempo è passato? Nessuna parola, nessun movimento. Dovrebbe essere il primo piano, penso. In alto, filtrata da un tessuto sporco, una debole luce, a cui comincio ad abituarmi, mi fa scorgere una grande testa eretta che tocca l’architrave. La porta, in realtà, non è alta. Sempre silenzio, solo rumori e voci dall’esterno. Non ho salito molti gradini e verso l’alto sembra ci siano parecchie rampe, con molte svolte. I gradini sono neri, di un nero opaco, senza riflessi. Ho portato la mano al volto, istintivamente. Dalla strada un rumore come di un grande telo di plastica strisciato lentamente. Poi una saracinesca si abbassa, il colpo del ferro che batte sul marmo, lo scatto del lucchetto massiccio, due voci.
*
Frammenti per strada:
– non me ne frega un cazzo
– il tuo vettore per guidare nella tua morale, non è il mio
– se questo è un principio risulta che bisogna assolutamente parlarne come priorità
– hai visto? ha i tatuaggi anche sulla punta dell’alluce
– domani andiamo al festival a Villa ***, dura tre giorni, c’è musica, gastronomia, lezioni di cucina, lezioni di teatro, rap italiano, rap bosniaco, quel comico che si vede in tv, tre schermi giganteschi, un comizio politico, un reading, un wisting, un torneo di cirulla a coppie, un maestro di tango, un corso di scrittura, un corso di fotografia, un incontro con il capo spirituale della Concrezione Orientale-Occidentale, un banchetto di miele, un corso di apicoltura…
– non riesco più a parlare
– faranno una grande opera, una monorotaia sorretta da decine e decine di piloni, un trenino come quello di un tempo
– quanti anni ha? che bello, che amore, che patatino, ma che amore, e sta dentro una borsetta! e non abbaia! che amore…
– non riesco più a lavorare
– va bene ma io trascino sacchi della misura sbagliata, si rompono per strada, lascio una scia di spazzatura
– fregatene
– i prezzi cambiano tutti i giorni, anche durante la giornata, dovete stare attenti
– aspettami, raccolgo la cacca del cane
– stasera bisogna assolutamente che prendiamo l’aperitivo insieme
– un film nuovo ogni giorno, capisci che meraviglia? Non costa tanto e puoi cambiare programma durante l’abbonamento
– non me ne frega un cazzo del vicino
– papà, pensa se un giorno non potremo più connetterci
*
Se ripasso gli ultimi anni, come un album di fotografie, mi sembra tutto irreale, sopra o sotto la realtà; forse è la fotografia, un ritaglio nello spazio, una caduta sospesa nel tempo, irrigidita, un po’ estranea, simile a qualcosa che conoscevo. Simile ma con scarti improvvisi, come un viso dai lineamenti in genere poco mobili e d’improvviso agitati, un viso che ho conosciuto bene, che ho creduto di conoscere bene. Era quasi sempre impassibile. Qual è il viso della fotografia? Una parabola di oltre dieci anni si è bloccata, si era messa in posa, è andata in pezzi. Eppure nella foto è sospesa e compatta. La sequenza non ha aggiunto movimento al movimento sospeso.
Sono rimasto impigliato fra gli ultimi ganci. Albeggiava, era mezzogiorno, poi tramonto, sera, notte. Ero lì nei passaggi, solo nei passaggi, un raccordo sottile, necessario forse, neppure un ponte. Le fasi si ripetevano. Ero un raccordo per collegare tre o quattro ante.
*
Facciamo un nome in mezzo a questa cancellazione toponomastica. Non lo troverete su nessuna delle innumerevoli targhe della città di C. Non è celebrato, non ha corone di marmo. Morì a 33 anni. E non scrivo “a soli 33 anni.” È un uomo da ascoltare. Per lui un altro uomo diede le dimissioni. Altri lo aiutarono quando seppe. Era già avanti di trent’anni. Toglieva polvere. Andate a trovarlo al confine, non il suo.
*
Altri frammenti (con vivavoce)
– Fatti i cazzi tuoi.
– Quando sei arrivato in Italia? (Voce di donna)
– Stamattina.
– Allora ti richiamo fra due anni. (Voce di donna)
*
Qualcuno è sbucato da Vico *** e si è appoggiato contro un muro accanto a una decina di bidoni della spazzatura. Dentro l’ennesima nicchia vuota sosta un piccione. Passa un uomo che cammina scalzo (lo rivedrò dopo, in Piazza ***). Fisso dall’alto il contenuto di un cartoccio a cono, il modo di spremere il limone e di gettare via il lungo stuzzicadenti. Dal distributore automatico non è sceso lo zucchero. Il caffè amaro è imbevibile. Osservo un volto di marmo con spaccature, una finestra alta con tenda bianca proiettata all’esterno, le smisurate tubature di metallo o di gomma, la sequenza dei cassoni per la condensa, alcuni zitti, altri agitati, una mela rossa sospesa fra vetrina e casse, braccia simili a ragnatele. Il chiarore opaco sembra luce artificiale. Il caldo aumenta. Qualche decina di turisti cammina con passo da sonnambulo, lo sguardo vitreo, fra i palazzi di Via X.
*
Così anche oggi mi sono mischiato ai passanti, alle ombre, ai tagli di luce. È il primo di luglio. Le sgargianti sterlizie, sotto la sede della ***, sono appassite; una ha conservato un ciuffo secco e disordinato color paglia, le altre due hanno arrotolato il becco come una pergamena stinta.
La città di C. con le centinaia di ponteggi è ancora più stratificata. La sensazione della gabbia, del labirinto fortificato si accentua. Sotto le reti sono sparite centinaia di metri quadri di facciate. Dietro s’intravedono figure, corpi o corpi affrescati, finte architetture velate dai tramagli1 edilizi. Altri corridoi, dunque, altro cordame, nodi, ancora più ombra, una foresta di pali dentro la foresta di pietra.
*
Sostare o andare avanti fra queste contorte spaccature. Le ho tutte in mente, come un marchio. Ripeto lo stesso tragitto anche se lo cambio. E dunque provo a guardare il cielo col suo movimento di nuvole. Di cui mi stanco presto perché il blu domina, è perfetto, smaltato. Il blu del cielo di mezzogiorno il primo di luglio, e i suoi riflessi sul metallo, sulle plastiche, sui tendoni bianchi: da qualche anno decuplicati. Le piazzette sono scomparse sotto tavolini, sedie e i massicci ombrelloni sorretti da braccia metalliche sproporzionate, vere gru, e tutte nere, come i tavolini e le sedie.
La deliziosa piazza *** rialzata, è una gran mangiatoia. Dopo aver osservato il cupo spettacolo masticatorio, devo andarmene perché un’improvvisa zaffata d’immondizia sorvola e scende su piazza, palazzi, porticato, via ***, e toglie il fiato.
*
“Graffiate e scrivete sui muri solo per ragioni territoriali e non ve ne accorgete. Vi impadronite di una zona o di un angolo o di una strada coprendola di segni. La firmate come se fosse la vostra opera. Si tratta di proprietà. Invece di pisciare, di secernere liquidi da ghiandole, voi graffiate, scrivete, disegnate, macchiate. Volete essere proprietari, ma di spazi pubblici.
Non siete diversi dai colonialisti che detestate.”
*
Speravo di essermi chiuso la porta alle spalle, di aver lasciato definitivamente la città di C. e non solo su carta, ma nei fatti. Sarebbe stato un gran sollievo sbattere in faccia la porta a una città che già dalle sue porte accoglie solo minacciando.
Qui si fanno affari, s’impila, si accumula. Senza idee, solo per il gusto perverso o tradizione dell’accumulo oppure per i privilegi comprati senza merito. Una grande passione, gli affari. Gli affari sono affari. Pecunia non olet. Tassa sui rifiuti: la più alta.
Oggi, come da un decennio, quasi una tradizione, Via dei *** era un vero cesso pubblico. Merda di cane e piscio. Merda secca o fresca; spalmata o appena deposta, e piscio a pozzanghera o a rigagnolo: per tutti i gusti. Selciato a pezzi, come da tradizione. Pecunia non olet.
La città di C. accoglie tutto e tutti. Non scarta niente e nessuno. Qui trovate lezioni bibliche di strada, poesia per strada, adoratori di Nostra Signora del Pesto, cani e urli, esercizi di pianoforte, esercizi di canto, opportunità, cibo di strada, fritto di strada, bottiglie spaccate per strada, artisti di strada, messaggi mistici a forma di fiore dipinti anche sui tronchi dei pochissimi alberi, dispensatori di baci schioccanti adornati di piumaggi simil-aztechi – sempre per strada. È la città mobile, è la città portatile, è la città del futuro. Si decora di farfalle e fiori. Sbatte i fiori ovunque: manifesti, striscioni, mostre. Mettete dei fiori nei vostri cannoni. Non fabbricate armi. Dipingete di giallo le bombe, fatele pop e poi potrete venderle. Qui non si discrimina, non si guarda in faccia a nessuno, il nome non conta. La città di C. è l’elenco del telefono, ferma gli autobus perché tutti, tranne l’autista e un passeggero, non hanno la mascherina. E le porte si aprono, sale la polizia e scappano tutti.
*
Mi chiedo perché vedo immagini di fango e cancelli. Un ricordo? Una fotografia? Durante l’ultima alluvione sotto le mie finestre scorreva un fiume in piena, uno andava a spalare fango, il fango seppelliva sottopassi e negozi poi sigillati per sempre. Sono passati anni ma non è finita. Adesso è siccità prolungata, il letto dei corsi d’acqua non assorbirà, la terra è compatta. Ripetizione. Si gira per anni e si torna al punto di partenza, davanti alla stessa ripida scalinata che non si ha più voglia di salire. Scoppiasse un temporale? La scalinata diventerebbe un orrido come in alta montagna, però in città. Qui è pieno di crepacci, dislivelli, precipizi, cavedi, e in fondo giardini, cemento, cortili per stendere e buttarci un pallone. La cancellata in ferro battuto, ampia, alta, a due ante, di Vico ***, arrugginisce. Oggi è domenica. Lo stretto davanzale ospita una coppia di piccioni e due uova. Il nido è fatto con pochi legnetti. Hanno ombra tutto il giorno.
*
– I cazzi miei sono i cazzi miei.
– Ma…
– I cazzi miei sono i cazzi miei.
– …
– Devono mettersi il berretto giallo argentato, tutti. Devo vederli subito e anche da lontano. Devo contarli rapidamente.
– Ma…
*
Le palme del parco dell’*** sono state tagliate. Una lunga fila di pietre tutte uguali delimita. La redola è eccessiva, il passo sprofonda. Anche una bella mimosa non c’è più. Ma l’odore di plastica surriscaldata dei giochi ovunque uguali c’è.
*
– La Storia… vaffanculo…
– Quando hai davvero bisogno, si allontanano tutti.
– Il vaiolo trasmesso dai pipistrelli… chissà…
*
Sono sempre più raccolti come un sacco. Sembrano inginocchiati dentro il corpo. Rosicchiano uno spazio esiguo di mensola in marmo ed è come fossero sdraiati o seduti per terra. Sbucano dai portoni. In Via dei ***, in Vico del ***, in Vico ***, un po’ dappertutto. Qualcuno si addormenta sui gradini della chiesa di S.***, un altro è riverso contro il portone della chiesa di S. ***. Il caldo e la siccità proseguono. Le ombre sono nitide: un lampione, un filo, una cancellata.
*
Li ammassano sulle panchine del Porto Antico, sotto le misere palme, accanto alla gabbia di vetro, recente struttura accanto alle biglietterie, fra catene e sbarre e cancelli, pali, tognolini, corsie intrecciate multicolori: bianche, azzurre per i pedoni, blu per le auto, gialle, rosse, simboli, segnaletica orizzontale, frecce adesive, tondi adesivi. Da mesi odore di uova marce.
*
Cerco di non guardare niente. Men che meno osservo. Soprattutto nella stagione in cui la voracità visiva è inesausta. Domina il genere autoritratto con cibo. Qui, autoritratto con focaccia, pesto e fritto. Ma la pancia piena di immagini e di cibo e di immagini di cibo non è mai abbastanza piena, benché tesa come un otre o sacca sul punto di straripare. Ci si accanisce su vetrine di ogni tipo, e su ogni tipo di variante: basta che ci sia la faccia, o le facce. Sono sempre operosi, occupati, impegnati a far rendere al massimo il tempo della vacanza con il massimo di multipli: filmati, fotografie, audio, audio video, messaggi scritti o vocali. Masticano e masticano.
Oggi, verso le 12, come ogni giorno c’era la pittrice, sdraiata quasi per terra, sul lato in ombra di Via dei ***. Tutti cercano l’ombra che non attenua la calura se non nei rari incroci attraversati dal vento che non si sa da dove arrivi. Come all’incrocio tra Via di*** e Via ***, luogo temuto d’inverno, molto apprezzato d’estate.
*
Nel mio ricordo questa strada, Via ***, viene evitata perché attraversata da un vento gelido. Vedo una figura che rasenta i muri, si protegge col bavero, ha un cappello. Altre figure, poche, più indietro, procedono controvento, chine, quasi di profilo. Oggi il caldo opprime e l’aria di Via *** è benedetta. Qualcuno si ferma all’incrocio con Via ***, allarga le braccia, chiude gli occhi. Chiudo gli occhi e un colpo sordo, forse un portone chiuso bruscamente, un carrello, un richiamo, non mi fanno ricordare niente, solo un presente sgradevole, che nella sua lentezza torpida, accaldato, fiacco, tuttavia non smette di aggredire.
*
In fondo al negozio, dietro al bancone, improvvisamente inizia ad agitarsi. Dopo, si agitano tutti. In Via dei ***, nel banco di marmo, si apre una fessura. Sono l’unico dei passanti che non continua a camminare, che si ferma, ascolta e guarda. Dietro ai banconi spuntano lunghi pali appuntiti rivolti verso l’entrata. Passano due moto della polizia e procedono oltre. Dal quarto piano cade una molletta per stendere. “Ha cercato di ferirmi!” grida un passante e si massaggia la testa ma in realtà non è stato colpito. Cerco di capire perché ha inventato, perché dentro una macelleria i commessi sono tutti alti e hanno la faccia grigia, molle, senza età. Con un sorriso ambiguo, uno dalla testa calva dice: “È iniziato tutto da qui, mangiavano qualsiasi animale.” Da Piazza *** proviene un brusio sempre più intenso. “Passami la tua chiave, sì, quella più lunga” mi dice uno sconosciuto. “Proiettano tutto su un grande schermo, lassù, in cima al grattacielo. Danno ordini, mandano musica da ballo, immagini di vacanze.”
*
Quando ho visto i primi alberi abbattersi non capivo. Poi è caduta la seconda fila. Il tonfo dei tronchi era smorzato, il fogliame, invece, per lo più secco, mandava un rumore fragoroso. Adesso cadeva una pioggia fitta, riempiva qualsiasi cavità. L’acqua saliva di livello, mi costringeva ad andare sempre più in alto. Da una rampa, ad un’altezza indefinita, vedevo l’acqua alzarsi a spirale trasportando i tronchi degli alberi abbattuti e già lavorati, privi di rami e foglie: puliti. “Ti offrono il materiale per una zattera” diceva qualcuno, e intanto l’acqua defluiva verso il Parco *** dove avevo visto abbattere gli alberi. Uomini in tuta imbracciavano seghe a motore. Altri risucchiavano le schegge con un tubo aspirante.
*
Tutta questa luce, da tanti giorni, e questo caldo continuo, anche di notte. La percezione è alterata. Si vede come attraverso un pezzo di plastica. Tutta la Città di C., che sembra scolpita in un unico blocco di marmo, abbaglia. E abbaglia d’improvviso, quando si sbuca da un lungo intrico di vicoli in ombra. Oggi, fra le 13 e le 15, rari i passanti. In Via S.*** qualche gruppo davanti alle gelaterie. Una faccia mi sembrava nota e mi volto subito per non incrociarne lo sguardo: sono stati pochi secondi ma sufficienti perché si stampasse e più tardi, prepotente, ritornasse con i lineamenti instabili, nel ricordo.
*
Ricominciano a parlare dopo una breve pausa. Fanno un brusio continuo, strascicato. Voci di donna, uomini, bambini, vivavoce. Tre o quattro lingue. Versi, risate sguaiate. La piccola barista oggi aveva un grembiule viola; si muove come una coccinella fra il bar e Piazza***, quattro tavoli all’ombra di fronte a un ponteggio-fortezza: pannelli altissimi di truciolato, metà piazza ostruita. Dagli scavi sono emersi come sempre resti del passato.
*
Dalla Rocca *** mi sparano addosso. Sono ex amici d’infanzia passati al nemico, un nemico che non ha volto, neppure nomi. Corro su un terreno sabbioso verso una porta che non trovo. La spostano sempre, penso. Qualche anno fa l’avevano messa lungo uno sterrato in costa, poi l’hanno sistemata nella zona di ***. So che trascinano palle da cannone lungo Salita *** per rifornire l’artiglieria pesante sulle alture. Vedo uno che misura con i passi il perimetro di *** per sostenere una teoria sulla costruzione di alcuni bastioni. Ripete quel percorso parecchie volte. Sfuggendo alle raffiche salto su un autobus che sbanda lungo una strada di campagna e si abbatte lentamente contro un gruppo di alberi. Uno si mette alla guida, fa aprire un paio d’ali, e mi riporta alla Rocca *** ma questa volta all’interno. L’autobus è flessibile, pieghevole come una sdraio da spiaggia, e penetra agevolmente. Dall’interno, guardando nello specchietto retrovisore, vedo una sala ampia, di pietra, con i soffitti altissimi. La sala è vuota di persone e cose. Le pareti hanno centinaia di feritoie. A un tratto compaiono i miei ex amici, quelli che mi sparavano addosso. Propongono una trattativa, una tregua, portano un rotolo di carta scritto e lo recitano quasi salmodiando. Scendo dall’autobus. Uno mi tende la mano. Sorride. Ha il viso tondo, pallido ed è pelato. Lo guardo, poi guardo la mano che mi tende. Anch’io sorrido. Da una feritoia, introdotto dall’esterno, vedo un oggetto che luccica. Guardo ancora la mano che mi viene tesa. Tendo la mia, sorrido., l’avvicino all’altra. Poi di colpo schiaffeggio quella mano con violenza. Fuori riprendono a sparare.
*
Mi era sembrato proprio lui mentre rasentava i muri di Via***, disegnato contro le pareti chiare, il cappotto nero, avvolto nella sciarpa nera, il bavero rialzato, il cappello nero ben calcato. Sempre pallido, sottile, controvento. Lo sguardo diffidente. Soffiava un vento gelido. Ci siamo incrociati, dopo anni. Non sapevo se avvicinarmi o tirare diritto accelerando il passo. Quali inconvenienti o dispiaceri avrebbe portato quell’incontro? Il vento tagliava. Non si poteva indugiare. Lui, pur continuando a camminare, si era rannicchiato. Procedeva lento col passo regolare. A un certo punto mi sono fermato qualche metro più avanti. Soffrivo il freddo, ero all’incrocio con via *** dove il vento turbinava. Il giorno prima aveva nevicato anche a bassa quota. Lo fissavo. Lo aspettavo. Avevo deciso. Avrei abbassato la sciarpa perché potesse vedermi bene e lo avrei colpito. Lo avrei colpito perché non sopportavo più quella voce querula, femminea, quel corpo esile eppure resistente, quell’aria da jettatore che sempre emanava da tutta la sua persona.
*
Avevamo appuntamento in Piazza ***, era primavera inoltrata. Lo guardavo da qualche metro di distanza. Aveva la barba lunga. Mi sembrava che nel tentativo di fare qualcosa annaspasse. Quello non era il suo quartiere. Quella non era la sua zona. Ero in anticipo, così potevo osservarlo. Cercava di allacciarsi una scarpa. Nel tentativo gli cadevano un sacchetto e una cartella. Anziché posarli per liberare le mani, ogni volta li raccoglieva, sempre provando ad allacciarsi la scarpa puntata contro un basso muretto. Si guardava intorno come se tutti lo stessero osservando, aveva la faccia rossa, sudata. A volte sbuffava ma non riusciva ad allacciarsi la scarpa. E sacchetto e cartella cadevano. Per un attimo avevo pensato di andargli incontro per farmi dare sacchetto e cartella e porre fine a quella scena penosa. Poi mi ero bloccato. Perché? Perché in realtà non volevo aiutarlo, volevo continuare a guardare quegli occhi che roteavano pieni di sgomento, quelle mani goffe, quei gesti scomposti. Doveva continuare a sentirsi come sotto una lente d’ingrandimento. Pressappoco un insetto.
*
Se avessi continuato ad aspettarlo senza scendere sarebbe calata la notte. Un po’ di ritardo era normale. O forse aveva sbagliato strada o portone. Conosceva male la zona ma sapeva arrivarci – mi aveva detto. In quel periodo abitavo in Via ***, all’ultimo piano. Il citofono non funzionava, ma lo sapeva. Doveva mettersi sotto la mia finestra, in linea col portone e chiamarmi. Avevo aperto tutte le finestre che davano su Via***, se avesse chiamato lo avrei sentito facilmente. Eravamo d’accordo così. Un paio di urli e gli avrei lanciato la chiave. Ma gli urli non si sentivano. Aveva mezz’ora di ritardo. Per il resto era una persona puntuale, meticolosa. Gran raziocinio. Squadrava le cose a minuscoli cubetti e tutti delle stesse dimensioni. Non uno diverso. Quando ragionava mi ricordava i cristalli di neve. O il caleidoscopio. Comunque, continuavo a non sentire il mio nome dalla strada. Quasi tre quarti d’ora di ritardo. Che cosa era successo? Mi sporgevo dalla finestra ma non lo vedevo. Così mi sono deciso e sono sceso. A una decina di metri dal mio portone… era lì. La testa verso l’alto, lo sguardo fisso a una finestra… era lì, immobile. Io lo guardavo, lui non mi vedeva. Sembrava ipnotizzato. Gli avrei chiesto da che cosa. Perché quasi un’ora di ritardo. In realtà era arrivato puntuale. Ma si era piazzato davanti al portone sbagliato che però riteneva quello giusto in assoluto. Con le mie indicazioni si era fatto una sua mappa che non poteva e non doveva essere sbagliata. Tornava tutto: via, piano, forma delle finestre, numero civico; nella sua mappa tornava tutto. Così era lì, impalato da circa un’ora, fissava in alto e ogni tanto mi chiamava. Non si era neppure accorto del tempo che passava.
*
“Dovresti conoscere bene tutte le voci, i versi, i suoni e i rumori che da quattordici anni senti sotto le tue finestre e nei dintorni del quartiere. Per esempio quei campanelli, quel vibrafono, quel colpo secco di una saracinesca sul marmo. Hai individuato la fonte? Le frequenze? Quale cane abbaia adesso? Chi tossisce? Chi traina che cosa? Sei allenato, l’orecchio si abitua, dopo anni le voci cambiano, alcuni oggetti vengono spostati, certi appartamenti cambiano inquilini, più o meno in fretta. A volte piantano le tende, si radicano, e si arrampicano come le piante parassite. A volte l’avvicendamento è basato sul sesso, la statura, l’età, la professione, la capacità di bere, di fumare, di far circolare certi beni, di ostacolare, di creare un blocco, alleanze, avamposti, tavolini sull’angolo, compiacenze, passaggi. Una catena di solidarietà.” Io sono stanco, rispondo. Solo stanco. Un tempo c’era il suono di un bel sax e il resto erano rumori. Adesso il sax non c’è più e mi accorgo che i rumori non sono mai andati via. Sono lamenti e alti lai nell’aer sanza tempo tinta. Per quanto cambino gli attori, lo spettacolo è sempre uguale. Una fossa. Una sponda di venti, venticinque metri. Approdano. Ma nessuno li traghetta altrove. E come i balani, bucano e s’incrostano.
1 Rete da pesca, spesso molto lunga, disposta in orizzontale. È una rete da posta.









(Narrazioni, 2)