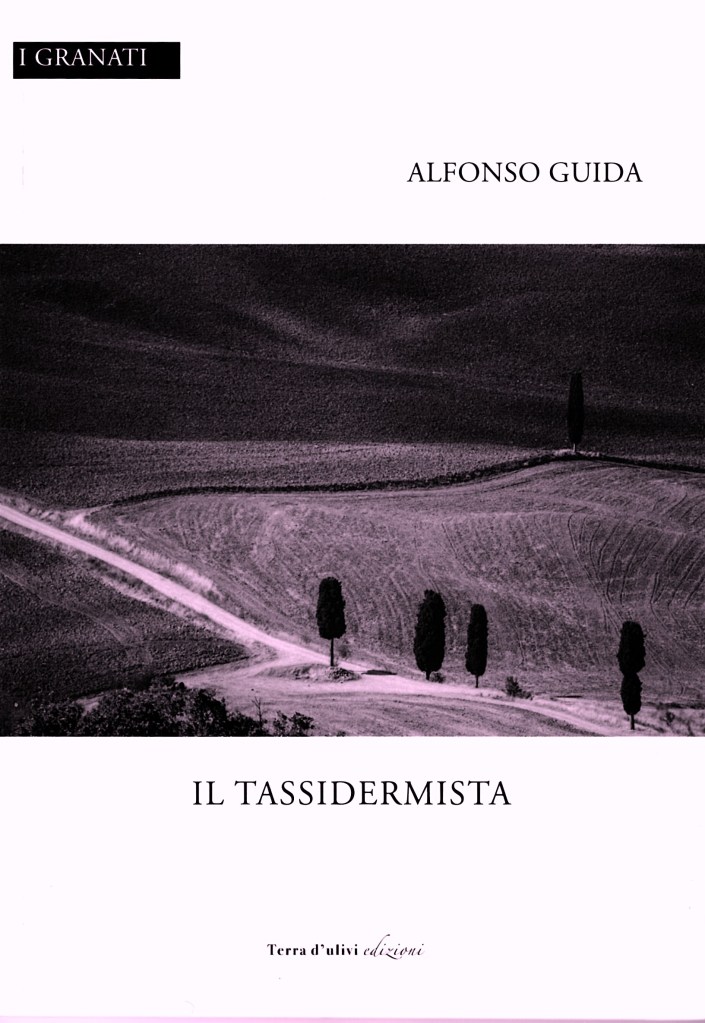
Il compito del critico, davanti alla poesia di Alfonso Guida, non è mai quello di comprendere: è, molto più umilmente, quello di immergersi in una inclassificabile e incessante “parola in atto”, un monologo scritto in una qualche notte insonne a San Mauro Forte e suddiviso in stazioni-poesie, monologo per il quale l’autore non sa trovare una fine e di cui il critico può vedere solo una tappa del viaggio, e anche questa in modo non conclusivo, non definitivo. Il concetto di “interminabilità” della sua scrittura, sul quale ritorneremo, è evidente, come per altri libri dell’autore, anche ne Il tassidermista (Terre degli ulivi, 2022). Se la “tassidermia” (dal greco: taxis, ordine, e derma, pelle ‘disposizione della pelle’) è etimologicamente l’arte di preparare e ordinare la pelle degli animali morti in modo che più si avvicini alla forma naturale, nel caso di Guida il titolo evoca direttamente un suo ricordo d’infanzia: ad Alfonso capitava spesso di vedere, in casa sua, animali impagliati e la sua felicità più intensa era dialogare con loro come con creature viventi. Ciò non esclude che il titolo, misterioso per una raccolta poetica, rimandi anche alla volontà del poeta di classificazione e di riordinamento delle forme del mondo in altre forme. «Si salvano col gelo, pregano il fuoco. Subiscono l’incanto, falsano la maledizione. I morti lasciano impronte sul quaderno di geometria. Sanno nominare, rinunciano al varco, Ombre coperte al di qua da ombre di soglia. Non la ferita notturna, ma la descrizione devota, per un inciampo nel limite, alla sua commedia» (I poeti). Un libro che inizia con questa epigrafe «Scrivere non è ricevere lettere. / È ciò verso cui lancio un destino» è già un libro che sommuove, un libro “destinale” e “assoluto”. Nella poesia, La sopravvivenza di Torremozza (Torremozza è il nome fittizio con cui Alfonso nomina l’istituto psichiatrico dove venne internato per anni), Guida scrive: «L’opera è una lunga notte d’insonnia./ E tu ragionavi con un vaso di spine, con la promiscuità dei colori,/ in un profumo di aghi, la calma verticale dei primi canti./ Ora non avviene nulla. L’istante si è spogliato./ La potenza viscerale era la Russia agreste, non la Grecia nuda./ I giorni uscivano, tenui e attediati.// Stava fermo, seduto, fumava educato/ come un allievo, al tenero grido innamorato,/ a un odio indifeso».
Molto tempo è passato, da allora. L’”opera scritta” di Guida si è prosciugata, è diventata conoscenza, aforisma, secca visione, ma senza mai sottrarsi all’idea di essere uno “stato estremo”, nel destino di un uomo che ha fatto, dell’”estremo”, la sua esclusiva ragione di vita. «Scrivo nello stato del funambolo o del pane rappreso./ Nessun fondamento. La poesia smette: né frutteto né supplizio./ Ora è chiaro. Resta il fondale./ E lo chiamano verità o mistero, a volte dolore». Il magma barocco, che pervadeva la poesia giovanile di Guida, si è illimpidito a favore di una diversa conoscenza, dove ciò che conta è essere “funambolo”, vivere sulla corda incerta di cui parla Kafka negli Aforismi di Zurau: «La vera via passa per una corda che non è tesa in alto, ma appena al di sopra del suolo. Sembra destinata a far inciampare più che a essere percorsa».
Se volessimo approfondire questo concetto, ci avvicineremmo alle affermazioni del regista tedesco Werner Herzog, autore di Aguirre furore di Dio e Fitzcarraldo, che teorizza, per l’arte, una sorta di nuova ermeneusi: una forma di “verità estatica”, che coincide con una “percezione altra” caratterizzata da un rigore assoluto di “verita”. La “verità estatica” è, senza ombra di dubbio, la “verità poetica” che lo stesso regista, in un’altra riflessione, fa coincidere con “la conquista dell’inutile”.
Scrive Guida, della propria terra: «Sale un tanfo di licheni. Il corpo viene con la sensazione dell’erba che si sforza e si radica. Una busta di cenere sventola sul parapetto. Il tempo scorre con un altro ritmo, che è solo di villaggio e palude. La casa si alza su un dirupo di argilla dove entra ed esce la bogliente lue grifagna di Dante». O ancora: «È dei passanti la poesia. Il testamento è una registrazione di fughe, di sottrazioni. Invochiamo la religione sottostante e le dicerie notturne. Si disperde l’essenza, che diventa questa semina, la “Semaison” di Jaccottet. I nomi, le citazioni. Immanenze spettrali, spettralità immanenti». L’occhio di Guida è un occhio visionario strettamente aderente alla terra, alle cose viste, alle sensazioni del corpo, ed è interminabile.
Lo testimonia una poesia che citiamo interamente, TABERNAE: «Tornano indietro di un passo./ L’inferno: calmo e preciso. (Tela tessuta/ da mani guaritrici)//. Noi restiamo incantati /davanti al filo che non scioglie i propri nodi./ Non vuole. Noi amiamo la notte di questa volontà.// Lautréamont chiedeva continuamente/ caffè negli alberghi dove alloggiava./ Lo usava per curarsi l’emicrania./ Di notte strimpellava al pianoforte/ disturbando i clienti che insorgevano,/ collerici. Forse le emicranie persistenti avvalorano/ la tesi di una morte per tumore al cervello. //Stasera ho chiuso presto/ la doppia porta che fa di questa casa una fortezza/ sottoterra. È due stanze petralia sottana.// Il discorso incede logicamente,/ si nutre delle sue spoglie, pago di una muta/ verticale e serena». Perché, a proposito di questa poesia, parlo di “interminabilità”? Perché TABERNAE è un tenebroso incantamento che non presuppone una poesia precedente e una poesia successiva. Esiste comunque e dovunque: descrive un poeta, un paesaggio, un inferno. E noi “sappiamo” che, ovunque vada il libro, poesie come questa martelleranno la nostra percezione in un inesorabile, interminabile continuum di cui ignoriamo l’inizio e la fine, immerse in uno sprofondamento arcaico di cui il dialetto (la “lingua mammerol”, la “lingua morbosamente materna”), restituisce il più nitido specchio:
«Chesta lengua t facij cantà.
Ndian fin a sent com chiov tra l sol e l scescl.
L cocm l’ann pttat d na terra giall
Leggere Guida porta a una specie di “stupore metrico” per la lingua italiana. Sembra, a una prima lettura, che la sintassi sia slegata, i concetti sparsi, il senso dissolto, e il discorso risuoni caotico. Ma poi si torna a ri-leggere e tutta la poesia è davanti ai nostri occhi nuova, esatta, non più imperscrutabile:
«Saliva e terriccio, la sostanza
del miracolo, i ciechi
fedeli ai propri occhi. Torna, tra alberature gremite
di uccelli, il paradiso della porta
perenne e della porta scardinata
che batte come una mente informe, come uno spavento
che raggela. Le mani arrancano.
Le tende sui tetti. L’amaro delle immagini.»
Pur continuando a parlare della poesia di Alfonso Guida, dobbiamo arrenderci all’evidenza di un mistero che Il tassidermista ci ripropone ancora una volta, come per ogni suo libro: il mistero di una poesia trascritta da baudelairiani “uragani tenebrosi”, incalzante, che non concede scampo, mai “classica” ma sempre guidata dal suo ritmo abissale, dove ogni forma di bellezza è bellezza demonica e urticante destinata a non trovare pace. Anche se questo non è del tutto vero: la serenità, in Alfonso, trapela da forme sorprendenti e nuove, ed è viva, fragile, forte:
«Ci si specchia cercando con l’istinto
di chi va verso la propria porta, la semplicità
dei passi quando si vede la strada.
Scrivi: fuoco e fune sul tetto.
Scrivi: inevaso
Non c’è una ribellione maestra.
Gli oggetti non chiedono niente
E nel loro silenzio non c’è servitù. Accettano, tacciono
La quiete non viene dai morti
ma da un mutare lento di rovine».
Concludo riluttante questa nota di lettura perché il libro è molto più ricco di come lo abbia commentato e molti dei temi trattati si prestano a interminabili variazioni. Guida è in accordo con Schelling quando afferma che “la follia è il fondo dell’essere”: senza quella follia non è immaginabile confrontarsi con qualsiasi forma d’arte. Ma qui chiudo, sapendo che altri libri di Alfonso sono di imminente pubblicazione, testimoni della sua interminabilità, pronti a rovinarci come a salvarci (2022)
(Critica poetica, 2)
