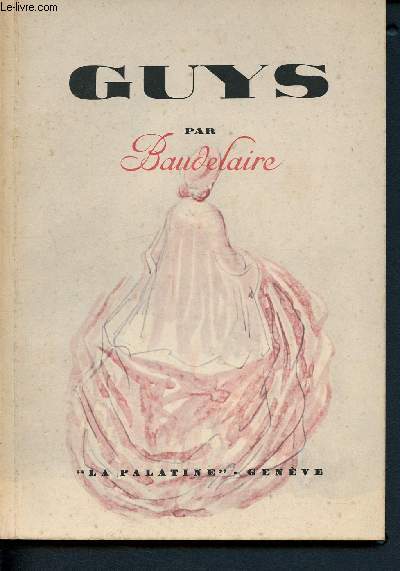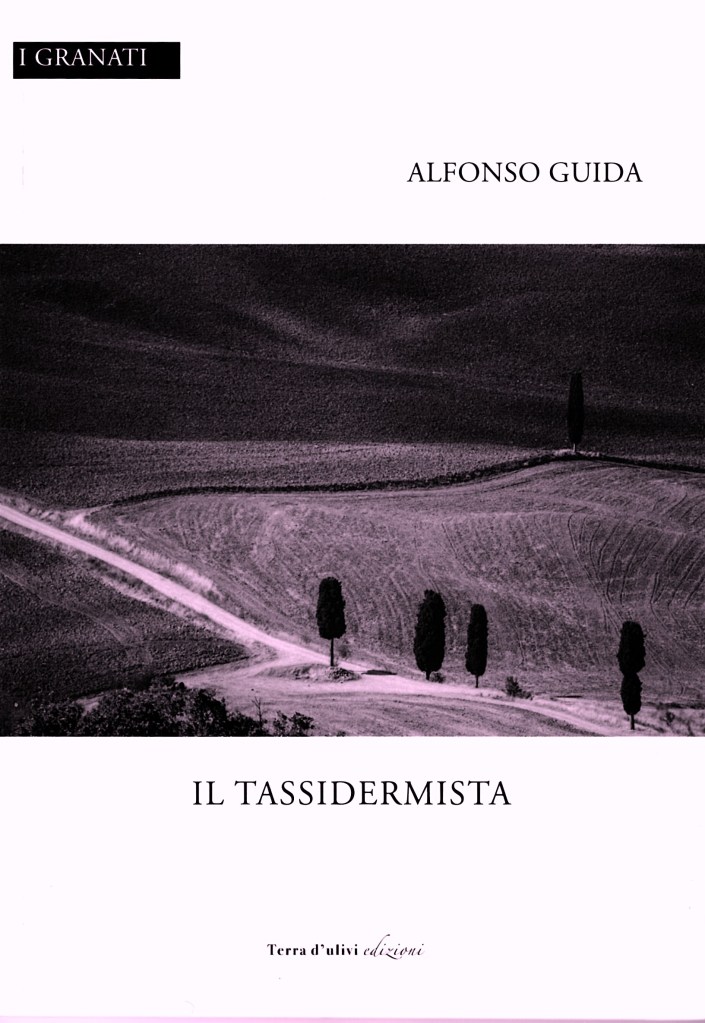**
INDICE
Guida alla città di C. (Servo e padrone)
Guida turistica alla città di C.
Appendice
**
Una guida menzognera, precaria nei percorsi, oscura nei riferimenti topografici, attenta a ciò che non esiste più, ai suoi innumerevoli strati, raccontata da voci diverse, ossessiva e labirintica come la città di C.
Nella prima parte, il testimone è un valletto-marinaio al servizio di un gentiluomo gran viaggiatore che approda e soggiorna nella città di C. in un’epoca che potrebbe essere quella di fine ‘800.
Nella seconda, la voce principale è quella di una guida turistica, il tempo è il nostro presente, ma alterato da sogni, innesti di passato, presagi.
L’Appendice riferisce i nomi e sragiona.
Testo e fotografie dell’autore
**
PRIMA PARTE
GUIDA ALLA CITTÀ DI C.
(Servo e padrone)
La citta di C. vista dal mare è meravigliosa. Arroccata dentro un semicerchio naturale ai piedi delle montagne sembra strapiombare nell’acqua con un effetto vertiginoso; il porto è piccolo ma perfettamente organizzato in settori, bacini, moli, darsene, cantieri, torri, magazzini, silos, banchine, gru, con una sconcertante varietà di imbarcazioni: a vela, a vapore, miste, a remi, con lo scafo di legno o di acciaio, chiatte, zattere, pescherecci multicolori, navi gigantesche, gozzi, velieri, alberature come una foresta, una foresta di cavi tesi e pizzicati dal vento, ganci e gru, bandiere di ogni paese, prue affilate, tonde, polene dorate dal corpo di sirena, poppe decorate con madonne e santi, amuleti, ossa di squali, strani pesci rotondi e irti, essiccati e usati come lanterne.
*
Appena sbarcati, percorrendo vie e vicoli tortuosi, sorprendenti per il decoro, la pulizia, il fresco odore di salmastro attraversato da una vena di aria più densa, con un sentore di catrame, pesce squartato, vernice, spezie, nasse e reti stese ad asciugare, colpisce una serie di portici in pietra, a ridosso della piazza più importante del porto dove sostano innumerevoli veicoli a braccia, tirati da animali, a due o quattro ruote, a due o quatto zampe, carretti e vetture raggruppate a centinaia sotto lo sguardo benevolo di una gloria cittadina effigiata in bronzo.
*
Non sono poche le glorie dei mari e dei monti raffigurate in ogni parte della città. I caduti, i cartografi, i navigatori, i poeti, i patrioti, i generali, i santi, i politici, i mecenati, le vittime, i carnefici. Così, al centro di piazza C., circondata da aiuole a forma di mandorla, ingentilite dai fiori, sopra una base di pietra gialla alta sei metri, svetta la cavalcatura in bronzo dalle natiche poderose, dai garretti muscolosi, dalle froge dilatate, tenuta con mano ferma e sapiente dal re che porge il cappello impennacchiato al cielo, alla terra, ai sudditi, in un gesto di solenne, vibrante omaggio.
E, poco più in alto, in cima a un obelisco di marmo immacolato, con le braccia conserte, col volto bonario e pensoso, vigila sulla città un condottiero di popoli.
Alle spalle, uno dei parchi più belli d’Europa, annunciato dal mormorio ancora lontano della sua famosa cascata.
Entriamo nel parco accolti da una serie di busti, con o senza braccia, tutti con i baffi, di marmo o di bronzo, piantati o eretti come sentinelle lungo l’entrata principale. Di fronte, svetta ancora lo stilita che ora vediamo di spalle. Più in basso, la statua equina di bronzo, imponente, sovrasta la piazza.
Sotto grandi magnolie fiorite, costeggiando un ruscello formato dalla cascata, saliamo lentamente verso la sommità del parco dove si trova la villa costruita dal celebre architetto C.
Nel ruscello spumeggiante nuotano pesci rossi e bianchi, tartarughe, gamberi di fiume. Si respira l’odore intenso dei fiori di magnolia. Le ninfee sono spettacolari. Continuiamo a salire lungo il viale serpeggiante. Sostiamo su un ponte affacciato sul ruscello. Il rumore della cascata adesso è più forte. In un punto più largo sorge una gigantesca voliera che accoglie uccelli esotici: aironi, colibrì, pernici verdi, una gran varietà di pappagalli, passerotti, pettirossi, gazze, quaglie.
Superata la voliera, stranamente silenziosa, senza quel chiasso che ci si potrebbe aspettare da una simile fauna, ma con la sensazione netta di essere osservati da centinaia di occhi piccoli e acuti, vediamo rimbalzare sopra enormi rocce e sentiamo il rumore fragoroso di acqua che precipita. Siamo in prossimità della famosa cascata di C.
*
La statua equina di piazza C., cavalcata da un re che tiene la briglia con la sinistra e ha tolto il cappello con la destra, è rivolta a sud. La base, alta circa sei metri, è di pietra gialla. La coda del cavallo è folta, esuberante, ben resa. Anche i finimenti sono lavorati con destrezza, sembrano ricami in bronzo.
*
Fra le querce e le magnolie di piazza C. sorge la statua in bronzo di un poeta. Al posto delle braccia si allungano festoni di alloro che s’innestano in un libro conficcato per metà nello stomaco del poeta. Sul dorso del tomo si possono leggere titolo dell’opera e nome del poeta.
*
La statua in marmo del poeta C. ha le braccia conserte. La statua in marmo del condottiero di popoli che dall’alto di una colonna domina piazza C., ha le braccia conserte.
*
Quasi nessuno sente il crepitio del bronzo arrugginito mentre si stacca. Lamelle verde-ruggine sembrano stridere prima di staccarsi e disperdersi. Certi rigonfiamenti della materia, bolle, ondulazioni, esplodono liberando un debolissimo suono.
Qualcuno azzarda l’ipotesi di un richiamo di soccorso: la statua degradata, e che avverte il suo degrado, invocherebbe cure.
*
Dopo che occhi e pelle si sono tuffati, inebriandosi, nei gorghi della famosa cascata, non senza un brivido di timore per il dislivello vertiginoso e il frastuono della massa d’acqua a precipizio che abbiamo osservato in diagonale contro lo sfondo del cielo; dopo che abbiamo goduto, attraverso gli spruzzi, di un incomparabile paesaggio a terrazze che digrada, tra prospettive lineari, palazzi e giardini, statue, alberi e fiori, fino all’orizzonte e al mare che s’intravede lontano in una nube di foschia, continuiamo a salire verso la cima della collina su cui sorge villa C.
*
Nei ripidi giardini intorno a Piazza C. spicca un busto di donna in marmo. La donna, vetusta e nobile, l’enorme testa avvolta da una cuffia, sembra poggiare sulla sua base per un miracolo di equilibrio, un trionfo sulle leggi fisiche. È questa la prima sensazione se osservata da lontano; in realtà, la testa, quattro volte più grande di una testa normale, è sostenuta da una base potente, conficcata solidamente nel prato scosceso. Anche questa statua è priva di braccia ma la testa smisurata, addolcita dai merletti di marmo, dall’espressione severa e benevola, possiede un’eloquenza e occupa così tanto spazio che le braccia sarebbero state un ornamento superfluo.
*
Superata Villa C. arriviamo in cima al parco. Una fontana a forma di trifoglio, asciutta, col fondo calcinato, e al centro un piccolo tritone che sembra lottare con un gronco; tre panchine in pietra, un belvedere di legno che aggetta sopra la città, e la fine ghiaia che ricopre questa sorta di piazzetta, il cielo di un blu smaltato, e rarissimi i visitatori; sotto, il basso continuo della cascata, qualche vago rumore della città.
Sul limite nord, un busto in pietra ci osserva. Sostiamo per riprendere fiato e godere dell’aria fresca che sembra arrivare, scavalcandolo, dal semicerchio delle montagne che sovrasta la città.
Sotto di noi, esposta verso sud, sorge la villa di C.: possiamo vederne il tetto, il retro e parte dell’entrata principale.
*
Villa C. fu ampliata aggiungendo al corpo principale due torri di altezza diseguale; la prima, la torre C., ha una sola finestra costituita da un lungo e stretto rettangolo che la attraversa dalla base fino al tetto. La seconda, la torre C., venne eretta incautamente su terreno friabile incurvandosi in pochi mesi. L’architetto C. bloccò i lavori di innalzamento e fece rafforzare il terreno allargando anche la base della torre la cui costruzione fu terminata dopo circa 18 mesi.
Il corpo principale è formato da un blocco squadrato dove si aprono due alte porte di ferro separate da un muro costruito con pietra scura del promontorio. Ai due lati di questo blocco di pietra scura si allargano ventagli formati da una fitta trama di mattoni sovrapposti e incrociati. Un ventaglio s’incurva e si distende verso l’interno dell’edificio, l’altro verso l’esterno.
*
“Se questo non fosse l’unico lavoro che sono riuscito a rimediare negli ultimi anni, non sarei qui. Accompagno i due viaggiatori che in questo momento stanno osservando Villa C. e, in particolare, uno dei due che è il mio padrone. Padrone non disprezzabile e anche sensibile, per quanto può esserlo un padrone nei confronti del suo valletto e un padrone dotato di grande energia, accanito viaggiatore, instancabile.
L’ho accompagnato in molte parti del mondo ma non sarei mai venuto qui, nella citta di C., nel parco di C., e non sarei qui a osservare chi osserva la villa di C. peraltro interessante, ma soprattutto inquietante, sia nell’insieme sia nei dettagli.
La città vecchia è sporca, buia, maleodorante. Dalle sue strettissime e interminabili viuzze emana un lezzo insopportabile che fa rimpiangere il mare aperto, le vette delle montagne o le foreste. Si vorrebbe fuggire all’istante perché gli edifici sono di altezza smisurata, accostati l’uno all’altro, e la luce del sole, anche in estate, entra solo a sciabolate, accecanti diagonali che si abbattono sulle pareti e incidono per pochi minuti lo sconnesso e sudicio lastricato.
I portoni sono massicci e altissimi, innumerevoli porte, piccole e grandi, murate, socchiuse, spalancate, cancelli, grate, acque di scolo, figure appostate sugli angoli come sentinelle, appena affacciate alle finestre, ingressi che danno su altri ingressi, scale interminabili, ombre rapidissime, un porto enorme eppure rinserrato, un’inestricabile bosco di alberature, una ragnatela di reti, cavi, ganci, cordame, una massa scura e compatta di chiatte, altissime gru, improvvisi e abbaglianti riflessi sull’acqua dei bacini, e un brusio costante, tonfi, richiami, colpi, come di un perpetuo cantiere sotterraneo, lunghi moli che s’innestano nella città, chiavistelli, serrature complicate simili a merletti di metallo, battiporta di ogni forma e grandezza, palazzi magnifici da cui vi guardano mascheroni di marmo grotteschi, e accanto a questo splendore di marmi policromi, decorazioni, affreschi dai colori vivacissimi, logge, colonnati smaglianti, ecco gli affreschi più deteriorati, il marmo più consumato, gli angoli più lerci e corrosi che abbia mai visto.
Basta una svolta per cadere e impigliarsi in un labirinto di sozzure, strisciare contro il degrado di persone e cose.
Non sarei mai venuto qui. Non sarei mai sbarcato.
Già dal lento avvicinarsi al porto avvertivo una sensazione di pericolo e crollo, forse per la montagna strapiombante sull’abitato, per la verticalità delle costruzioni, compatte e insieme inclinate, precarie per una strana luce, una strana prospettiva o il velo dei vapori di caldo che la rendevano ondulata; una sensazione di ostilità, forse per le fortificazioni sui rilievi delle montagne aspre, brulle alcune, altre verdeggianti ma sempre come se fossero spuntate di colpo dietro le vostre spalle, altissime, come le chiese, i palazzi, le muraglie, i vuoti, i dislivelli improvvisi, come ho sognato questa notte: palazzi altissimi di una città impervia, donne che per la calura dormivano sui terrazzi dentro grandi ceste di vimini; e io, da una posizione sopraelevata e sporgente nel vuoto, le guardavo dormire, e alle spalle, girandomi di colpo, vicinissima, una muraglia di granito dietro la quale s’innalzava un campanile molto alto contro lo sfondo nero del cielo e tutti i piani compressi, ravvicinati spaventosamente: il campanile schiacciato contro la muraglia, il cielo schiacciato contro il campanile e la muraglia schiacciata contro le mie spalle. E tutto come fosse germogliato in silenzio e in un attimo. Piatto eppure profondo, alto e massiccio.”
*
I due viaggiatori, che accompagno in qualità di valletto e marinaio, non sospettano nulla del mio stato d’animo che, del resto, mi sforzo di nascondere.
L’entusiasmo del mio padrone per tutto ciò che vede è tale che sto bene attento a frenare ogni mio minimo malumore. Di sera, consegno le mie inquietudini, le mie paure e la mia solitudine a un taccuino che non abbandono mai.
La villa di C. cambia aspetto, talvolta quasi radicalmente, a seconda di una combinazione di luce e punto di vista. Questa è anche la caratteristica principale di tutta la città di C.
Quando pensate che il panorama finalmente si spalanchi, l’attimo dopo spiate dietro una fessura, e viceversa.
*
Qui il senso di immobilità, o piuttosto di una deriva secolare, è fortissimo. Slittano lentamente i volti e le cose.
*
La città è disseminata di teste scolpite; in genere bisogna guardare dal primo marcapiano in su, sono sparse a centinaia, sporgono dalle pareti, hanno cornici, talvolta, o ghirlande. Oppure dal muro emerge solo la testa levigata, l’ovale piccolo e perfetto di una santa dall’espressione triste, smarrita dentro una parete così ampia e alta, costruita con un materiale totalmente diverso dal suo e nel quale non può riconoscersi.
*
Sul petto di una statua, un volto sbalzato ha l’aspetto di un seme.
Emblemi, insegne, edicole votive, bassorilievi, sovrapporte scolpite, colonne dove animali favolosi si divorano. Una testa di leone con la bocca spezzata sorregge una faretra piena di armi. Sulla parete di una chiesa, un santo ingrigito, sfaldato, quasi ridotto a scaglie e tuttavia ancora tenacemente aggrappato al suo muro.
*
Nella città nuova c’è una galleria di ferro e vetro. Sono entrato. Dal soffitto a vetrate scendeva una luce polverosa, come attraverso una serra dai vetri sporchi.
Sugli angoli del soffitto troneggiano grandi aquile di ferro ad ali spalancate – i rapaci sono replicati in mille modi nella città di C.
Il pavimento a mosaico è tutto su toni scuri: neri, argentati, qualche rosso, dorature opache. Su queste tessere si spegne una luce già smorta.
Al centro della galleria, sul tetto, una specie di struttura a piramide sorregge la testa di una creatura bifronte. Si dice sia il simbolo di una città che accoppia gli opposti ma non sa unirli, limitandosi a registrare, a constatare le ripetute, innumerevoli contrapposizioni, gli attriti, i conflitti millenari che è incapace di sanare.
*
Mi hanno detto che la città è molto arretrata nei suoi sistemi fognari. Sembra che le acque scure e quelle chiare scorrano in un unico canale.
*
Appoggiati a una balaustra di marmo, sotto l’ampia ombra di un pino marittimo, osserviamo meravigliati la villa di C. I tetti delle due torri sono per metà identici nei materiali, nelle linee, nella forma spiovente. Uno spiovente dolce e lento, il lato di un triangolo poco inclinato. Nella torre C. l’altro lato è un semicerchio con lievi ondulazioni, come una mezzaluna sfumata dalle nubi. Nella torre C. sorprende la totale assenza di una metà del tetto. Lo spiovente dolce è tagliato da una linea retta perpendicolare che forma una parete senza finestre, senza affreschi, compatta, liscia, di pietra nera, fra il lucido e l’opaco e quasi refrattaria alla luce.
*
Il mio padrone sembra accogliere ogni cosa con lo stesso umore curioso, stupito, vivace. Nessuna impressione sembra dominarne un’altra e tutte sembrano distribuite con equità per formare un panorama armonico.
A me sembra che guardi con un occhio solo e attraverso una lente acromatica. Le sue parole sono iridescenti anche quando il loro oggetto è buio, calcinato o grigio di un solo grigio. Calcinato come la vasca a quadrifoglio, nero e piatto come lo spiovente della torre C.
*
Da una settimana accompagno il mio padrone attraverso la città di C.
Oggi, dopo aver osservato gli affreschi dai colori squillanti del palazzo C. e dopo un episodio violento che non voglio raccontare, anche se il ricordo, temo, disturberà il mio sonno, abbiamo visitato la chiesa di C., composita negli stili, stratificata. Ha un bellissimo campanile in pietra, un chiostro, una facciata bianchissima dalle linee semplici, tre navate, innumerevoli cappelle, innumerevoli lastre tombali, stucchi, dorature, una cupola mirabilmente affrescata, altari con marmi policromi, confessionali con i vetri gialli smerigliati; oltre il transetto, in fondo alla navata sinistra, un grande crocefisso di legno dal viso orientale, l’aureola sbreccata e spine lunghe quanto un braccio.
*
Ho notato vetture il cui aspetto ricorda carri funebri: strette, lunghe, squadrate, con telaio e ruote nere, i finestrini scuri, i cavalli coi finimenti neri, prive di ogni decorazione, stemmi, monogrammi, stranamente silenziose anche quando procedono su un selciato sconnesso; all’interno è impossibile intravedere anche un’ombra; la gente, ho notato, si ferma e si scansa istintivamente, cede il passo, china la testa per pochi secondi. Eppure non compiono nessun ufficio funebre, mi hanno detto, facendomi capire, allo stesso tempo, che non sarebbe bene insistere con domande. Del resto, hanno aggiunto, non causano sofferenza a nessuno, tranne a coloro che trasportano, ma che vi salgono volontariamente ricambiando chi li ospita per quel viaggio del tutto segreto, dove l’imperativo, la condizione di chi mette a servizio le vetture e di chi lo accetta, è il totale anonimato fino al luogo di destinazione.
*
Quando abbiamo iniziato a salire lungo i vialetti che portano alla villa C., fra i cespugli e dentro le pietre dei muri ho sentito qualcosa di simile a un brusio.
Quando siamo arrivati davanti a una balaustra ai cui piedi ci sono aiuole quasi senza vegetazione, alle mie spalle ho sentito un rumore come di una pietra smossa e poi uno scalpiccio rapidissimo.
Distratto dal panorama, da una sequenza di colonne che un tempo sostenevano i busti di cittadini illustri, ho dimenticato quei rumori.
Dei busti è rimasta la base; il nome inciso, attraversato da spaccature, è tuttavia leggibile. Solo uno, quasi intatto, sembra sporgersi dietro la balaustra; ha il viso rosicchiato dal tempo e dal salino. È girato e curvo verso il mare. Vi dà le spalle annerite dallo sporco, fissa un orizzonte opaco.
*
Sul sagrato davanti alla chiesa di C. è incastrata una piccola targa. Sulle pareti di Palazzo C., sorrette da ganci poderosi, sono appese, a grandi frammenti, targhe di pietra che testimoniano atti infami. Alle pareti del chiostro dell’incantevole chiesa di C. sono appese decine e decine di targhe incise con cifre e lettere di vari secoli: danno l’effetto di un papiro di pietra srotolato sui muri.
*
Un gigantesco frammento, un torso incompiuto, rimaneggiato, impastato, ferocemente tagliato come tutte le facciate di Via San C. arretrate di metri, decine di metri, come i capitelli amputati del lungo, strettissimo C. il ***. Gli ingressi ai palazzi non sono quasi mai quelli che si vedono; città sconnessa e insieme compatta, a trafori e a blocchi, con centinaia di logge murate, migliaia di finestre finte, la ripetizione nei marmi, nella pietra, sopra i portali, negli affreschi, della stessa scena dove un animale favoloso è trafitto e calpestato.
*
Ho assistito ad atteggiamenti inesplicabili. Uno ruotava su sé stesso parlando senza sosta; un altro, davanti a una porta, sembrava che scalciasse; una donna minuta trasportava una pianta altissima dai fusti sottili e flessuosi: doveva fermarsi continuamente perché l’altezza della pianta, le raffiche del vento e la statura della donna rendevano il trasporto impossibile. E la donna rifiutava qualsiasi aiuto.
*
Svoltando un angolo ho incrociato un corteo funebre: mi sono affrettato a lasciarmi indietro singhiozzi, fiori, litanie, accelerando per allontanarmi dal dolore, da quel dolore inaspettato, esibito, che non era il mio, ma per ritrovarmelo poi di fronte, a un tratto, in una piazza.
La chiesa, dalla facciata abbagliante, con l’enorme portone spalancato, lasciava scorgere l’altare, il corteo già disposto, la cerimonia appena iniziata.
*
Tre quarti della città vecchia è degradata. Il degrado ha una scala: dall’intonaco un po’ sporco a muri spaccati, cornicioni pericolanti, fenditure, pozze di acqua lurida, infiltrazioni, infissi barcollanti, finestre senza vetri, ruggine, scolatoi a imbuto sospesi nel vuoto, rovine ammassate, travi sporgenti … un interminabile catalogo dell’incuria e della precarietà avvolto da un’apparenza compatta, fortificata.
*
Sul cimitero monumentale che tanto ha entusiasmato il mio padrone (da giorni ricorre tenace nella sua conversazione), dirò solo che l’ho trovato grottesco, opprimente, una specie di museo delle cere in marmo.
*
Osserviamo la copertura del corpo centrale, fitta di cifre e figure incise nel marmo. Una lieve, misurata pendenza del tetto, e un mirabile sistema di potenti getti d’acqua ne assicurano la pulizia. I getti d’acqua escono dalle bocche di una serie di volti in pietra quasi sferici, dall’espressione enigmatica. È un capolavoro d’ingegneria idraulica. L’acqua sale a forte pressione fino a raggiungere il tetto, viene scaricata con getti potenti sulle incisioni e poi convogliata, attraverso un sistema di passaggi quasi invisibile incorporato all’edificio, verso una cisterna collocata a metà della collina.
Successivamente, l’acqua raccolta nella cisterna, è usata per irrigare la vegetazione del parco di C.
*
Qui l’oscurità si può vedere in pieno giorno. Dietro le Mura delle C., percorrendo vicoli tortuosi e strettissimi, piazzette minuscole, schiacciati da edifici alti come torri, aperture improvvise su vertiginose scalinate, spigoli taglienti, mi sono fermato a osservare un passaggio lungo, quasi buio alle due estremità – era circa mezzogiorno di una giornata limpidissima. Al soffitto era sospesa una grande lampada la cui luce giallastra rischiarava pochi metri formando un alone sporco sul soffitto a volta. Quel cerchio di luce, quel passaggio lungo e così stretto che per toccarne le pareti sarebbe bastato allargare un po’ le braccia, dissuadevano, erano un invito a non continuare in quella direzione.
*
Gli sportelli. Una città di sportelli. Per lo più murati o legati con catene, a volte li trattiene una corda.
A volte sono spalancati e dentro la pietra nuda.
*
Chi farà mai l’inventario delle porte, delle aperture, dei cancelli, delle grate, delle finestre, delle piccole porte dentro porte enormi, delle nicchie, di ogni variante di una soglia o passaggio?
*
Il mio padrone partirà domani per la città di C. che si trova sulla costa di levante. L’ho pregato di lasciarmi qui e sono bastate poche parole perché capisse. Mi ha confessato di non essere sorpreso. Di recente, ha detto, mi ha visto stanco e ieri notte mi ha sentito gridare nel sonno, e non era la prima volta.
*
Questa città stanca. Tutte le città labirintiche e scoscese stancano. Si cammina per ore, come guidati da una spinta invisibile, come sfere lanciate dentro un tubo innestato in altri tubi.
Succede questo: senza accorgersene, dopo ore, sembra di ritrovarsi nel punto da cui si è partiti: lo stesso tabernacolo, la stessa immagine, lo stesso angolo, le stesse pietre, gli stessi cornicioni… All’estremità opposta di una strada, lo stesso portone; sui muri le stesse spaccature.
*
Il mio padrone è partito all’alba accompagnato da un altro domestico di pelle scura ingaggiato qui. Sono rimasto con la cuoca e un altro servitore che prima di oggi non avevo mai visto. Dorme nell’altra ala della villa. Nessuno ci ha presentati. Per adesso lo vedo solo nel giardino, nel vasto giardino coltivato.
Sembra un uomo taciturno, interamente occupato dalle sue mansioni, poco disposto alle chiacchiere.
*
Negli occhi, oggi, credo di avere solo il riflesso grigio delle pietre e qualche venatura di rosso acceso, di arancione squillante.
Il verde, nella città vecchia, è raro; il blu del cielo è segmentato in strisce fra un cornicione e l’altro.
*
Ora passa una grande nuvola e il caldo già opprimente si rafforza. È una nuvola lenta, compatta, ha una luce opaca il cui riverbero fa male agli occhi. Non c’è aria; si sposterà lentissima.
*
In mezzo alla strada, oggi, due neri si sono affrontati piantandosi silenziosi uno di fronte all’altro. Intorno, la gente si è bloccata senza interferire. Privi di armi, senza parlare, sono rimasti a fissarsi per un tempo interminabile. Tutta la scena sembrava un quadro vivente: nonostante la calura nessuno dei due sudava, e quel che c’era intorno restava immobile.
Non c’è stata lotta; neppure a parole.
Così come si erano bloccati l’uno di fronte all’altro, a un certo punto, agilissimi, sono scattati, girandosi intorno come in un balletto, restando schiena contro schiena.
*
La sproporzione fra le dimensioni di un santo in terracotta e la sua nicchia fa provare un senso di pietà comica.
La statuina, alta pochi centimetri, è sovrastata da una cavità che sembra altissima e profonda come una caverna. Se la statuina non resta del tutto invisibile è perché una mano accorta l’ha posata sul bordo.
*
Non capisco che cosa abbia visto il mio padrone. E soprattutto non capisco che cosa ho visto io. La Villa di C. nel parco C. non ha nulla d’interessante. La facciata a nord è piatta, suddivisa da quattro pilastri di cemento sporgenti, coperta da piastrelle marroni. Il tetto, a due spioventi, è di lamierino. Tutta la costruzione è squadrata, banale; nessun gioco di luce la ravviva.
E non capisco neppure quale parco abbia visto. Le ridicole voliere, in stato di abbandono, non hanno vita: né animale né vegetale. Sono polverose, sporche. Le reti sono arrugginite. All’interno, finti alberi secchi fatti col cemento che imita il legno. Gabbie vuote, cupe.
*
In tutto il parco una collezione di busti, uomini celebri che hanno un legame con la città. Alcuni sono consumati nella faccia. Il parco è irrigato male: foglie verdi ma accartocciate, foglie secche, bacche rosse e avvizzite.
*
I vialetti che salgono alla villa C. si snodano a serpente. Ogni tanto li taglia una scalinata. Avvolgono la collina, un tempo bastione, si biforcano e convergono su un pianoro o belvedere. Qui vi accoglie un grande busto di pietra con una pupilla annerita, una scacchiera dipinta sulla sezione di un tronco, un belvedere di finto legno inaccessibile perché pericolante, e alti pini dal fusto rossiccio. Intorno, a nord, le ultime costruzioni e dopo, a ridosso, i monti, verdissimi.
Una bassa ringhiera delimita, seguendone il perimetro ondulato, il pianoro. Una vasca di marmo a trifoglio, calcinata, alcune panchine e siepi di alloro; aghi di pino sulla piccola ghiaia chiara. Sale il brusio della città, la sirena delle ambulanze, spunta un uomo dall’andatura incerta, la testa bassa, su un angolo delle labbra una sigaretta spenta, appesa.
*
Ieri, una donna che dormiva su una delle panchine si è sentita guardata, si è alzata ed è scomparsa in fretta.
Appoggiati alla ringhiera, il mio padrone e il suo anfitrione di C. discutono indicando questo o quell’altro punto.
È caduto un ramo e subito dopo un pezzo di corteccia col rumore secco di una pietra scagliata. Salendo ho visto pezzi di carta bruciata, tartarughe nere e gialle, immobili sulla pietra, sembravano idoli. Ci sono molte grotte sbarrate da cancelli; sono finte grotte, come finta è la cascata, finto il legno.
*
Otto pini dal tronco rossiccio circondano la ringhiera di ferro che delimita a cerchio la vasca senza acqua. In realtà sono sette: l’ottavo è solo un ceppo su cui è stata disegnata una scacchiera. Anche i bellissimi pini sono disposti a cerchio.
*
Sul belvedere a sud, una specie di terrazza piastrellata, crescono piante selvatiche, si accumulano sterpi e foglie secche. Da questa terrazza si vede il porto. Il blu impeccabile del cielo di ieri, oggi è velato. Non c’è vento. Pochi visitatori, torpidi, salgono e scendono la collina seguendo la torsione dei vialetti.
*
All’inizio del parco di Villa C. c’è un platano secolare il cui tronco, a un tratto, si biforca; osservato da una certa angolazione riproduce la testa di un crocefisso per forma e inclinazione. I rami che si dipartono dietro il mento appoggiato al petto, la guancia sopra una spalla, imitano un crocefisso.
*
Qui il cemento imita il legno, le grotte e i rami degli alberi.
Oggi la foschia si è mangiata il panorama. Appoggiato alla balaustra il mio padrone si sbraccia, indica, parla molto. A volte sento un frammento di frase, qualche parola sconnessa che rallenta, s’invischia nella calura.
*
Anche oggi, ancora una volta, siamo tornati alla villa di C. Il mio padrone e il suo anfitrione sembrano stregati da questo luogo e non riesco a capirne la ragione. Che cosa vede? Che cosa lo affascina? Dopo mesi di siccità le piante sono avvizzite, le foglie sembrano colpite da un autunno precoce o da una malattia. In cima alla collina il panorama è bello, non c’è dubbio; ma in questa città verticale i punti panoramici non mancano. Il parco non è privo di fascino ma è un’eco, un residuo, un resto di qualcosa, un’imitazione goffa come la cascata, le grotte, le voliere di finto legno.
Dentro le grotte, sbarrate da alti cancelli, sporcizia e ombra. Che cosa ossessiona il mio padrone? La fitta trama di ringhiere in cemento, le voliere senza uccelli protette da reti arrugginite? uno strano elmo di metallo o bacile capovolto sorretto da sbarre? La vasca senz’acqua a forma di trifoglio al cui centro un fanciullo – forse Ercole bambino – strangola un serpente di mare?
Il fondo della vasca è così asciutto e velato di bianco che guardarlo fa male agli occhi. Il fanciullo e il serpe sono calcinati, tranne la schiena da cui affiora il verde cupo del bronzo.
Forse è il busto con l’occhio annerito, o i pini dal tronco rossiccio, o la scacchiera dipinta sull’ottavo tronco tagliato, oppure le nuvole, il porto, strane torrette, una massa di costruzioni che precipita verso il mare, oppure la villa di C. la cui descrizione che ho sentito per caso, dettagliata nei minimi particolari, non corrisponde a quello che vedo?
Anche oggi la calura è opprimente; qualcuno cammina come rallentato, si affaccia da un livello, guarda, è guardato da un livello superiore, riprende a salire o a scendere.
*
Sono dodici le colonnine prive di busto che sfilano equidistanti, piantate fra muro e ringhiera. Solo un tal C. ha conservato il busto. Una è abbattuta. Dai cilindri di pietra spuntano i perni di ferro su cui si avvita il niente.
*
Ieri siamo passati da Salita S. C. strada larga, sinuosa ed elegante, fiancheggiata da bei palazzi, al limite della città vecchia, quasi un raccordo. Il mio padrone si è fermato in una piazzetta indicando le facciate ricche di architetture dipinte: colonnati, capitelli, finestre, timpani, sbarre, balaustre, archi, logge: inganni ottici, quinte teatrali, ombre finte.
Non lontano da Salita S. C., sul palazzo C., grandi riquadri dove il marmo imita il ferro brunito di celate, cimieri e armature con un effetto di verosimiglianza stupefacente.
In cima a Salita S. C. siamo sbucati in Piazza C., piazza circolare da cui si dipartono quattro grandi strade, delimitata da alte magnolie, piante di alloro e altri alberi ad alto fusto, siepi, aiuole, e gli immancabili busti di poeti, patrioti, soldati che sbucano fra le piante o le sovrastano.
Ho lasciato proseguire il mio padrone e il suo anfitrione e ho deviato in un giardino seminascosto dove su quattro livelli, disposte ad anfiteatro, ho visto un gran numero di panchine arcuate di marmo bianco. Sembrano convergere, con un crollo o slittamento calcolato, verso un fondo di pietre bianche e nere delimitato da muri di pietra bianca a blocchi geometrici. Queste panchine, non troppo dissimili da lapidi, formano un triangolo equilatero i cui lati sembrano risucchiati verso il vertice.
*
Sbarre a protezione di una finestra murata.
*
Mentre camminavamo in Salita di Santa C. un mendicante è sbucato dall’alto e scendendo ci veniva incontro mormorando una litania incomprensibile. Mentre scendeva deviava verso altri passanti. Non tendeva la mano, stava curvo da un lato, e a quella distanza era di età e sesso indefinibili. Scartava i passanti oppure erano loro a evitarlo. Continuava a scendere verso di noi come fossimo la meta predestinata di quel percorso a zig zag. Il mio padrone si è immobilizzato e così il suo anfitrione. Io sono rimasto un po’ indietro, da un lato.
Mentre si avvicinava, quella specie di preghiera con cui il mendicante ritmava il passo, proseguiva e si definiva nei suoni.
*
Non so quante ore siano passate. Questi appunti notturni, mio malgrado, mi tolgono ore di sonno. Ma non sono stanco. Il mio padrone è assente e le mie mansioni, perciò, limitate. Uso le ore del mattino per recuperare energie.
I ricordi sfuggono. Quando credo di averli radunati, portandoli all’interno di un recinto, scivolano fuori. Quando credo di aver dato una cornice, anche sottile, a una scena, uno spigolo si apre, appare una luce non voluta, cede un altro spigolo e la luce irrompe, diventa abbagliante, dissolve l’intero quadro.
Non saprei dire quanto tempo mi occorra per incollare con affanno qualche pezzo sul foglio prima che un angolo mostri una fessura e quella luce importuna, parassita, cancelli.
A volte sono rapido a mettere insieme i ricordi e tengo insieme il quadro: i lati non si aprono, non ci sono fessure né porte socchiuse. Conservo quel buio, così prezioso, proteggo il silenzio, tengo lontano il chiasso della luce e scrivo.
*
Il mio padrone e il suo anfitrione sembrano ipnotizzati dal mendicante. È alto, magro, avvolto in un mantello che gli fascia anche la testa e nasconde una parte del volto. Immobile e curvo, dal basso appare imponente. S’intravede una barba folta, nerissima e per un attimo uno sguardo affermativo e insieme di richiesta. Rimane raccolto e fermo sotto il mantello senza pieghe che scende diritto fino ai piedi.
*
Oggi, con la scusa di un vago malessere, non ho accompagnato il mio padrone nelle sue perlustrazioni. So che andrà a visitare la Chiesa e il convento di S. M. di C. e la visita lo terrà occupato per buona parte della giornata.
Non so ancora quanto ci fermeremo in questa città; è come se il mio padrone ne fosse soggiogato.
Io rimpiango le vele, il cordame, la volta del cielo e il mare aperto. Il movimento e i colori dell’acqua, il paesaggio visto da lontano, il vento, le mie mansioni di marinaio, gli approdi e i brevi soggiorni in quei paesi con poche abitazioni colorate riflesse nell’acqua. Rimpiango le nuvole, ma non frantumate da cornicioni, grondaie, terrazzi, abbaini, compresse e ridotte a linee sottili e storte.
*
C. è una città affascinante ma insidiosa, quasi malsana. Come il salino, col tempo sembra corrodere e intaccare sia le cose sia le persone. C’è una specie di accanimento o ripetizione nei suoni e nelle forme, un’eco che non trova sbocco e risuona all’infinito. Così le facce: a migliaia sulle pareti delle case, sotto i balconi, dipinte o scolpite, grottesche per le smorfie, o levigate in poche linee silenziose, a forma di sole, animale, fiore, le bocche spalancate, la lingua di fuori, l’espressione beffarda, demoniaca.
Così gli emblemi, le cifre, i cartigli, le insegne, le targhe. A ogni angolo un’edicola votiva, un lastricato sempre grigio e sconnesso, un odore forte e spigoli, gradini, rampe interminabili, case una sull’altra, pareti che si urtano.
Un volto sbuca da un petto, un cranio da un elmo. Il bronzo imita la stoffa, i ricami, le frange di una gualdrappa.
*
… il mio padrone e il suo anfitrione sono sempre immobili. Il mendicante li fissa, continua la sua incomprensibile preghiera e muove la testa lentamente, oscilla lentamente con tutto il corpo; qualcuno si è avvicinato, altri si allontanano, io resto a guardare, immobile, per un tempo che non saprei dire. Il mendicante ha interrotto la sua giaculatoria, il corpo adesso è immobile, la testa ferma e reclinata sul petto.
*
Se non continuo l’episodio del mendicante, è perché alla fine non è successo niente di particolare. Mi sarei aspettato un gesto, forse violento, un improvviso risveglio del mio padrone da quello stato di torpore in cui sembrava sprofondato, oppure che io stesso, avvicinandomi, interrompessi quello strano quadro dove due persone sembravano ormai statue davanti a una terza – quasi nemmeno un corpo ma un mantello – che oscillava lentissima mugolando parole sempre incomprensibili.
D’un tratto il mendicante si è inginocchiato.
*
La città di C. è sporca, si sentono spesso cattivi odori. Anche se le strade sembrano pulite, le pietre esalano qualcosa di maleodorante. Due bambini, data l’altezza, sentono di più questa esalazione, scoppiano a ridere e si mettono a correre gridando: “C’è puzza di cacca!”
*
Come un rogo dell’inquisizione, ma di stracci, una massa alta dieci metri e larga quindici si erge in una delle piazze principali. Una specie di grande covone formato con vestiti vecchi, scarti di sartoria, sacchi sfondati, tessuti consumati di ogni tipo s’innalza tra la facciata ovest di Palazzo C. e piazza De C.
Per quale scopo? Una festa?
Il mucchio è impressionante, sembra compresso da mani gigantesche, è compatto e domina una tonalità scura. Più che stoffa sembra pietra, un blocco unico di pietra nera.
*
Un pomeriggio caldo rinfrescato da una brezza di mare. Seguo il mio padrone lungo Via C., una via importante per storia e architettura, così sento dire al mio padrone che mi precede, mentre la via s’inerpica, abbastanza larga e poco sinuosa.
In alto, un cane randagio spunta da uno dei tanti vicoli che incrociano Via C. Sul momento restiamo fermi e un po’ spaventati: il cane sembra non vederci, annusa, costeggia i muri. Poi prende una via laterale e scompare. Non sono pochi i cani randagi nella città vecchia e non conviene incontrarne uno, soprattutto in spazi così stretti. In genere sono solitari e scansano gli uomini.
Sotto le pietre di via C., come in molte parti della città vecchia, scorre un torrente. La via è animata e il brusio delle voci ha strani effetti di risonanza. Dove sostiamo per osservare un portale, che il mio padrone ritiene interessante, il brusio delle voci diventa simile all’acqua che scorre, ribolle come di fronte a un ostacolo, e sbocca col suono di una piccola, sorda esplosione.
Proseguiamo verso Piazza C.
*
Il cane che ho visto oggi, si è fissato tenacemente nei miei ricordi e si mischia a un colore come di ombra profonda e al ferro arrugginito di tante grate, cancelli, portoni e ringhiere: sfondo ripetuto della città di C. Era magro, appuntito nel muso, di taglia media, marrone scuro chiazzato di bianco, con la coda corta.
*
Siamo quasi fermi in un punto dove la folla comprime. Folla multicolore nei vestiti, nel portamento, nella parlata. Non siamo distanti da una piazza dove oggi è giorno di mercato. Riusciamo a deviare imbucando Vico del C, che è breve, a gradini larghi, lievemente in pendenza. In cima vediamo una cancellata chiusa e a destra un’edicola azzurra senza statua.
*
Gli effetti acustici nella città vecchia sono sorprendenti e spesso sgradevoli. Una voce sembra un colpo di fucile improvvisamente sparato a poca distanza, una strada deserta si riempie di rumori di cui non si riesce a capire la provenienza. Capita spesso di voltarsi improvvisamente in una direzione per rintracciarne l’origine. Dentro un androne, dove una testa di leone getta acqua raccolta da una conchiglia, sotto volte decorate con figure fantastiche dai colori accesi, confluiscono i rumori della strada e si smorzano fra i colonnati, le balaustre e gli scaloni. Le pareti sembrano oscillare per il riflesso proiettato dall’acqua. Dopo tanto clamore di folla, trovo piacevole lo scrosciare dell’acqua di un verde-azzurro trasparente, riposante il bianco dei marmi e la regolarità degli spazi. Il mio padrone osserva incantato le splendide decorazioni delle volte e con i gesti delle mani imita le fluide ghirlande, i fiori che diventano corpi, i corpi che diventano piante.
*
Dopo mesi il cielo è cambiato. Le nuvole hanno forma e movimenti autunnali, il caldo si attenua, le foglie del parco di C. si accartocciano e ingialliscono. Alcune cadono veloci e battono sul selciato con un colpo secco. I gialli spiccano sullo sfondo di quegli alberi che in apparenza non hanno mai autunno.
*
Accovacciati fra stracci, vestiti di stracci, scoppiano a ridere, battono le mani e hanno voci stridenti, agitate, come se litigassero. Vorremmo allontanarci, tornare indietro, ma la strada che si restringe in un cunicolo ormai ci obbliga a passare in quel punto che suscita repulsione e allarme.
*
Le nubi sono pesanti e scure: fra qualche ora pioverà. Il grigio del cielo e un bagliore bianco, l’ultimo del sole al tramonto, che ha rischiarato di colpo la facciata di un palazzo, annunciano un violento temporale.
*
L’acqua trabocca da un tombino che sussulta e si solleva spinto dalla pressione. Siamo in piazza B, fra la loggia della M. e la chiesa di S. P. in B.
Sotto la piazza, dice il mio padrone, scorre un largo torrente che sfocia in mare.
Il tombino è saltato; intorno si spande un’acqua marrone, piena di ruggine. Passano venditori e carretti. Da una delle strade che convergono in piazza B, avanza un colosso nero che sovrasta tutti di due teste.
*
Quando il mio padrone non ha bisogno di me, mi concede un po’ di tempo libero che uso per scendere nella città vecchia.
Procedo in fretta, imbocco scalinate, mi lascio andare per viottoli di mattoni e non mi guardo intorno finché non arrivo in piazza della M., piccola piazza quasi circolare sorvegliata da un paio di giganti in marmo, un orologio solare e negozi eleganti: una specie di preludio alla via più bella del centro storico.
Il mio padrone ha una grande memoria per i nomi; io, invece, ne ricordo pochissimi. La città vecchia, del resto, è un accavallarsi di nomi: piazze, piazzette, vicoli, strade, vie, stradoni, salite, vie con due nomi che differiscono solo per una parola, discese e tutti quei nomi che appartengono a un luogo dove sorge una chiesa, un monastero, un oratorio, e poi scalinate… un intreccio di nomi convulso come la città.
Eppure, ho scoperto che riesco a orientarmi. Con quale bussola o carta non so. Mi lascio andare ai ricordi che emergono mentre cammino, più o meno confusi, da cui estraggo, sfilo uno spigolo o un colore, un affresco o un qualsiasi dettaglio quando buca lo strato opaco dei ricordi e con cui riscostruisco una mappa personale. A volte afferro un odore o un suono e lo combino con facce che mi sembra di avere già visto. Oppure è una svolta che sembra cadere di colpo dietro qualcosa che non vedo, non ho visto prima o che forse non ricordavo.
Oggi, ad esempio, credevo di non ritrovare più una certa strada. Mi guardavo intorno perplesso, quasi smarrito, perché tutto mi sembrava identico a centinaia di altri luoghi già attraversati.
Poi ho ricostruito un tratto del percorso grazie a un dettaglio insignificante. Quasi al livello del lastricato di strada N., si apre una sequenza di finestre sbarrate molto simili fra di loro e quasi identiche a tantissime altre. Ma una, intorno alle sbarre, ha metri di catene attorcigliate e grandi lucchetti, e fra questa ferraglia arrugginita, dentro una cornice ovale, è incastrato il ritratto di una santa col volto che s’indovina dolce sotto uno strato spesso di sporco. L’immagine è alta circa 40 centimetri, la cornice sembra di legno, il volto sporge ondulato da uno sfondo ancora azzurro.
*
Qual è il centro della città di C.? Sembra averne tanti ma finisce col non averne nessuno. E ogni abitante sembra avere una propria idea di centro. Domandate. E ad ogni risposta il centro si sposterà a nord, a est, o altrove. Sarà vicino a questo o a quell’altro quartiere, piazza, monumento, palazzo, zona… sarà in alto, in basso, sempre spostato un po’ più in là.
*
Ho visto una scena di tempesta o battaglia. I vascelli avevano le vele ammainate o ripiegate, erano inclinati fra onde paurose e livide come il cielo. Erano quattro. L’alberatura della nave in primo piano sosteneva ancora qualche vela. In secondo piano, una strana colonna o torre bianca emergeva dall’acqua. Non capivo se le navi s’inseguivano o cercavano di scampare alla tempesta. La composizione formava un cerchio o piuttosto un ovale. I quattro punti principali, cioè le navi, sembravano spostarsi seguendo questa forma di rotazione.
*
Ho notato che da certe piazze sono spariti gli orologi e un paio ritardano, ma nessuno sembra farci caso.
*
Il trascorrere delle ore meridiane è affrescato, inchiodato, murato sui palazzi. Sine sole sileo, recita uno dei tanti detti che si leggono nei cartigli intorno agli orologi solari.
Un passaggio di nuvole, un cambiamento nella direzione del vento, ed ecco che l’ombra non segna più niente perché l’ombra portata non c’è più, il quadrante è muto, l’asta inutile.
*
Oggi la giornata è molto limpida, il cielo sembra di porcellana, i contorni sono nettissimi. Il blu è sfrontato, aggressivo.
*
Serata difficile.
*
L’odore di salsedine che attraversa le strade, raschia i muri, assorbe polvere e vola verso la città alta, non è quello del mare aperto. È acre, fumoso, stantio. Come reti da pesca lasciate marcire.
*
Il trasporto di un grande mosaico pavimentale da un convento a un palazzo, e la sua ricostruzione, tessera dopo tessera, è stato l’argomento di conversazione di oggi fra il mio padrone e il suo anfitrione. Il mosaico raffigura animali e fra questi alcuni segni dello zodiaco.
*
Nel sogno di stanotte un vento forte sollevava parti del mosaico. Oscillavano, vorticavano, crollavano dentro un giardino: per un istante sembrava che formassero una figura.
Mi trovavo sotto un’arcata che dava sul giardino e vedevo il mio padrone trasportare dentro sacchi di iuta migliaia di tessere e rovesciarle in mare. Faceva sempre lo stesso percorso centinaia di volte: dal giardino al mare, dal mare al giardino. A poca distanza osservavo la scena. Mi chiedevo perché gettasse il mosaico in mare e che senso poteva avere visto che le onde lo avrebbero portato via, e perché quella penosa fatica. Cercavo di avvertirlo che in quel modo il mosaico sarebbe andato perduto, gridavo, ma un vento forte e ondate fragorose coprivano la mia voce. A un certo punto ho visto il mio padrone bloccarsi prima di raggiungere il mare: aveva un’espressione cupa, sembrava riflettere su quell’azione disperatamente inutile. Poi mi ha visto, ha gridato qualche parola, e si è messo a correre verso il mare. È entrato in acqua. Tentava disperatamente di raccogliere le tessere. Quando riusciva ad afferrarne una manciata correva verso la spiaggia e le gettava sulla sabbia.
*
Oggi ho visto facce dai lineamenti ripiegati, quasi inestricabili. Difficile trovare un’espressione, un movimento disteso. E forse è stato meglio così. Certi occhi è meglio non guardarli, bisogna lasciarli in pace.
*
Sono circa 700 i corsi d’acqua che attraversano il sottosuolo della città di C.
Durante piogge forti e persistenti, congiunte a mareggiate che penetrano all’interno, alcuni di questi corsi d’acqua s’ingrossano paurosamente. L’acqua spinge e fa tremare il selciato su cui si cammina. Trabocca dai tombini e allaga parti della città, scantinati, portici, seminterrati.
*
Durante una delle ultime epidemie di colera, la città di C. ha ignorato le regole di prevenzione per continuare i suoi commerci appoggiandosi a teorie che accusano l’aria malsana, la sporcizia e la cattiva alimentazione piuttosto che il contatto.
*
Per superare i cordoni marittimi le navi devono arrestarsi a distanza di sicurezza dal litorale, il responsabile dell’imbarcazione si avvicina alla costa con una scialuppa per esibire la patente sanitaria al ministro della sanità e per giurare solennemente che nessuno a bordo è infetto. La patente viene prelevata con una pinza e se ne verifica il contenuto: se il bastimento è ritenuto infetto o sospetto gli si vieta l’approdo pena la morte. Le lettere e i documenti vengono affumicati con un “suffumigio”, un fumo contenente zolfo, e poi immersi nell’aceto.
*
Il XX luglio XXXX il cordone fu rotto da qualche contrabbandiere e l’epidemia cominciò a diffondersi da *** verso *** e ***. Il 2 agosto il colera scoppiò nella città di C. Dalla città di C. si diffuse lungo il litorale tirrenico toccando ***. Alcuni *** scapparono a *** che fu contagiata e contemporaneamente furono infettate anche *** e ***. A settembre una barca di un mercante della città di C. percorse il *** per raggiungere *** e ***. Il colera invase così anche il Regno *** che non aveva steso alcun cordone, nonostante le proteste popolari. A ottobre arrivò a ***, a novembre a ***. Da qui si estese in *** e da *** verso ***, *** e ***. A novembre arrivò a *** e da qui nella primavera dell’XXXX si diffuse a ***, a ***, a ***, a *** e a ***. A luglio raggiunse *** e di nuovo il litorale *** compresa, ancora una volta, la città di C.
*
È una pozzanghera dopo l’altra, non si sa dove camminare, cade da ieri una pioggia fitta, scura. La conchiglia in cima alla fontana di Piazza C. si riempie di pioggia. Il popolo chiama questa fontana Il Barchile. Alla fontana si accosta una vettura. La sosta si prolunga. La pioggia batte furiosa sui cavalli. Cerco riparo sotto un portone e osservo la carrozza: il movimento rapido di una tendina. Qualche oscillazione che sembra provenire dall’interno, quasi impercettibile.
*
Ieri la vettura è rimasta ferma accanto al Barchile per molto tempo. La pioggia ha smesso di colpo, è uscito il sole, ma con poca luce e poco calore. Piazza C., come a un segnale convenuto, si è riempita di gente. Al frastuono della pioggia torrenziale si è sostituito un brusio sordo, voci e passi, richiami, rumori, imprecazioni: tutta l’animazione sonora di una piazza di modeste dimensioni, il risultato di un vicolo che si è allargato spingendo i palazzi ai suoi lati.
Dalla vettura non è sceso nessuno. Dalle criniere e dalle code dei cavalli cadevano gocce. La vettura sembrava asciugarsi con sorprendente rapidità nonostante il sole fosse debole. Si asciugava più in fretta di tutte le altre cose intorno, quasi assorbendo un calore intenso respinto dagli altri oggetti e negato alle persone. In pochi minuti, dalle ruote ai finimenti, dal telaio ai vetri, la vettura era completamente asciutta, quasi arida e polverosa. Per terra, sulle pietre sconnesse, pozze d’acqua, riflessi torbidi.
*
In Piazza C. sovrastante il Barchile, c’è un palazzo chiamato il palazzo del Melograno, perché quest’albero è cresciuto fra le spaccature della parete. In rapporto alle dimensioni del palazzo appare piccolo, quasi un arbusto insignificante. Dicono che non abbia mai dato frutti per non sporcare di rosso (un rosso troppo simile al sangue) il sottostante portale, portale di marmo con colonne, timpano, fregi – alto e arrogante.
*
Dalla vettura avrebbe potuto scendere qualcuno. Almeno quando la pioggia scura e fitta ha smesso di rovesciarsi sulla piccola piazza C.
Sotto il portone, attraverso una cupa trama di gocce, osservavo. Forse ho immaginato il rapido movimento di una tendina. Le cose si vedevano come attraverso un vetro ondulato: oblunghe, precarie, sporche. Più lontane o più vicine, più storte. Sembravano il riflesso delle cose dentro l’acqua. Quando la pioggia è cessata e la gente ha riempito piazza C., mi aspettavo che arrivasse il passeggero atteso e che le ruote avrebbero ripreso a muoversi nell’acqua, finimenti e briglie a oscillare, i cavalli a scuotere criniere e code bagnate, e forse avrei intravisto un volto, una mano, avrei sentito una voce che non sarebbe stata quella del conducente. E la vettura si sarebbe asciugata con lo stesso tempo delle cose che la circondavano e non con quella sbalorditiva, innaturale rapidità che aveva prosciugato in pochi minuti metallo e legno e cuoio e vetri.
*
I gabbiani sembrano sorretti dall’aria grigia, la gente è come schiacciata; le cose grigie si rafforzano, diventano profonde; i marmi risaltano; le facce si chiudono, guardano in basso.
Ieri da nord si è alzato un vento tagliente e oggi è più forte. In Piazza C. un gabbiano mi ha sfiorato urlando. La gente cammina in fretta come girata di schiena o di lato. Dai cantieri, dalle lastre di pietra, dai mucchi di terra volano frammenti. Nei portici di Via di C. s’ingolfa il vento, poi sbocca nei vicoli laterali: corridoi, imbuti che amplificano la forza dell’aria.
*
Guardo le creste aguzze delle onde nel porto. L’acqua è livida, verde-grigia.
Ieri il mio padrone è rientrato dopo una settimana trascorsa nella località di C. Sembrava turbato, quasi scosso. In genere conserva, in un volto espressivo, una certa gioviale serietà; ma ieri, mentre scaricavo i bagagli, ho colto nel suo sguardo un peso, una gravità che non gli avevo mai visto. I gesti erano più lenti, la voce meno sicura, il passo esitante.
So che è stato ospite del dottor C. nella villa C. il cui magnifico parco arriva fino al mare. Il dottor C. è uno specialista ma non ricordo di quale disciplina. La villa in cui abita è decorata, mi hanno detto, da splendidi affreschi. La notevole varietà di piante secolari, nella lieve ma costante inclinazione del parco verso sud, precipita lenta verso il mare sul quale si affaccia dalla sommità di scogliere vertiginose. Qui si tendono verso la luce tronchi, rami e fogliame aggrovigliati alla boscaglia e aggrappati alla roccia.
*
In piazza C., ma più che una piazza è uno slargo irregolare, c’è un bel palazzo in ardesia a strisce bianche e nere. Sulla facciata a sud fa bella mostra di sé un tabernacolo. In cima al tabernacolo, un piccolo busto del Padre Eterno, in un movimento di torsione, nella sinistra tiene il mondo: una sfera molto simile a una palla di cannone. La destra è sollevata in un gesto di benedizione sbriciolato dal polso in su. Dal polso spunta la sbarra di ferro del telaio.
In Vico C., piantata in un muro, si può vedere un’autentica palla di cannone simile alla sfera sorretta dalla sinistra del Padre Eterno.
*
Stanotte ho sognato un vicolo: era attraversato freneticamente da puttane grasse, orribili. Nonostante la mole, si muovevano quasi correndo, andavano e tornavano spinte da un’urgenza incomprensibile. Ridevano. A volte staccavano le lunghe ciglia posticce o le capigliature finte.
Intanto, da uno strettissimo vicolo laterale sbucavano figure: una sopra l’altra si sporgevano contorcendo il volto e il collo teso; avevano pelle scura e denti bianchissimi. Si sentivano dei latrati e non se ne capiva la provenienza. A un tratto uno di loro mi dice: “guarda quell’imposta, sta crollando; guarda quel soffitto intriso d’acqua, quei pali, vecchie alberature di vascelli, tarlate e ammuffite. Non durerà.” Poi mi ritrovavo a contare il numero di ceste allineate su un molo, forse la diga esterna del porto, come dovessi farne l’inventario. Erano larghe e profonde ceste di vimini, il mare in burrasca sbatteva contro la diga, a volte oltrepassandola. Le ceste, nonostante la leggerezza, sembravano inamovibili. Intorno, tutto era scosso dal vento.
*
Fra circa un mese sarà inverno. Il mio padrone aveva fissato una data di partenza e oggi l’ha annullata. Avevamo iniziato a preparare i bagagli quando il padrone ha dato ordine di non continuare ma, allo stesso tempo, di non rimettere tutto a posto. Così, ci ritroviamo fra bagagli che sembrano appartenere a qualcuno arrivato da pochi giorni o da qualcuno sul punto di andarsene: una specie di trasloco a metà.
Da parte mia non sento più l’urgenza di partire. Non appena arrivato avrei voluto scappare e, per mesi, ho sognato di risalire sul B.A. per salpare, lasciandomi alle spalle rapidamente la vertiginosa montagna, le palazzate a schiera, il porto della città di C., i suoi odori acri che afferrano alla gola, la sua sporcizia, il labirinto di corridoi, le minuscole piazze storte, le figure accovacciate negli angoli, le strade buie in pieno giorno, i selciati sconnessi, un cavaliere che trafigge una bestia centinaia di volte, una grande chiesa zoppa.
Adesso, mi sento preda di un torpore simile a quello degli animali che vanno in letargo.
Il mio padrone mi ha ordinato di recarmi al BA per alcuni lavori di manutenzione. Sono riuscito a mandare un altro servo poiché anche la sola idea di attraversare la banchina, adesso spazzata dal vento gelido, e di rivedere l’imbarcazione mi crea un malessere che fatico a comprendere. Un tempo il BA era la mia casa, e i mari attraversati, le coste, i porti e il cielo una specie di paese in movimento. I soggiorni sulla terraferma erano pause in attesa di ritornare sulla casa galleggiante a manovrare il timone, le vele, a fiutare i venti, le burrasche, a leggere carte e barometri, a stabilire col mio padrone questa o quella rotta.
Era euforia organizzata, febbrile disciplina di navigatori, scoperta.
*
Dopo la visita al dottor C. nella località di C. il mio padrone esce raramente e le visite che riceve sono altrettanto rare.
Il taciturno giardiniere lo ha visto mentre passeggia nel parco: è assorto, si muove lento, e lo sguardo è poco rivolto alle cose intorno.
Non avevo mai parlato con lui ma un giorno, incontrandolo in giardino, mi ha indicato il padrone e ha detto: “L’ho sentito parlare da solo; parlava di affreschi, di una certa villa e di un dottore. Ha un volto inquieto. E non sorride.”
*
Non guardo mai la posta del mio padrone che ho l’incarico di ritirare e consegnare. Tuttavia in questi giorni mi è capitato di notare un tipo di busta e una calligrafia che spiccavano in mezzo alle altre.
*
Quando entro nello studio del mio padrone per consegnare la corrispondenza di solito esco subito. Oggi, invece, ho indugiato mentre il mio padrone scorreva le buste. Ho notato un cambiamento di espressione quando ha preso in mano una certa lettera: lo sguardo si è fatto inquieto e grave. Ha posato la lettera accanto alle altre e sembrava che non riuscisse più a concentrarsi su niente e a non guardare nient’altro che quella busta. Si era anche dimenticato della mia presenza.
D’un tratto mi sono sentito un intruso, uno che viola un segreto, o quanto meno un importuno. Allora ho chiesto se potevo andarmene cercando un tono di voce rispettoso e comprensivo.
__________________________________________________________________
Da oggi importa poco se la città è quella di C., se il mio padrone si è ripiegato su sé stesso dopo la visita alla località di C., se il giardiniere prosegue coscienziosamente il suo lavoro e parla pochissimo, se il resto della servitù appare raramente, in fondo ai lunghi corridoi, nelle vaste sale, quasi sorpreso e imbarazzato quando vede altri domestici. Ciascuno continua nella propria occupazione, ma è come se il tempo non fosse scandito da niente: né orologi, né commissioni, né preparativi di pranzi, cene o partenze.
Il mio padrone si fa servire i pasti in studio, esce a orari imprevedibili, può passeggiare nel parco per ore o pochi minuti, rientrare bruscamente come per un dovere, (stavo per scrivere dolore) improvviso. Poche volte ha bisogno di me. In quelle rare occasioni l’incontro è rapido e le parole strettamente necessarie come i gesti. Solo qualche volta certe espressioni minime, come una lieve increspatura delle labbra o un movimento della testa, danno l’idea di qualcuno che vorrebbe parlare per ore, far saltare un tappo, spalancare una porta.
*
Poiché sbrigo le mie mansioni in poco tempo, di tempo adesso ne ho in abbondanza.
S’intende che resto sempre a disposizione del mio padrone, perché una parte del mio tempo è sua per contratto, e perché in me il senso del dovere è spiccato. I rapporti col mio padrone sono sempre stati corretti, sul filo di una forma e di un rispetto che non ha impedito, all’occasione, qualche abbandono più confidenziale e, soprattutto durante la navigazione, un rapporto quasi da compagni di viaggio, al confine tra amicizia e discrezione.
*
Ogni statua è rigata dallo sterco dei gabbiani; sul bronzo macchie bianche, strisce; sulle teste, con berretto o no, il guano abbonda. Il verde cupo del bronzo è puntinato di sterco. Le spalle e le teste sono trespoli.
*
Il vento gelido da nord ieri ubriacava i gabbiani e incupiva l’umore della gente infagottata, stipata sotto i portici.
Sulle cime è caduta la prima neve. Nei prossimi giorni sembra che nevicherà a bassa quota.
*
Nel parco ci sono due laghetti circolari al cui centro s’innalza un getto d’acqua che sale sottile per molti metri. Nei giorni senza vento, disegna una linea bianca, netta contro il cielo e in caduta si sfrangia.
Intorno ai laghetti, disposte a semicerchio, statue di divinità pagane con la testa o gli arti sbriciolati.
*
Oggi stavano rastrellando la fine ghiaia dei viali e il rumore era simile a quello di un frangente continuo, sommesso.
Il mio padrone ha dato ordine di smettere immediatamente. Si è rivolto ai giardinieri con un tono violento, per lui del tutto inusuale. Sembrava esasperato da quell’incessante rumore di ciottoli rimestati, da quelle linee ondulate bianche e grigie simili a certe correnti quando increspano il mare.
*
Ho sognato un giovane dal corpo atletico che portava per mano un bambino. Sembrava fuggire da una città in fiamme. A un certo punto lo vedevo drizzarsi sopra un piedistallo. Aveva l’aria costernata. Sentivo che diceva: “Adesso dove poso il piede, che movimento potrei fare, come proseguo la mia corsa? Se faccio un passo avanti, precipito. Potrei solo girare in tondo ma a che cosa servirebbe? Non salverei né il bambino né il carico prezioso che ho sulle spalle. Potrei solo ruotare come impazzito. Per saltare ho sotto di me troppi metri. E intorno vedo salire l’acqua e dietro sento crepitare le fiamme. Forse qualcuno mi sposterà con tutta questa altissima base portandomi in salvo. Non avrò bisogno dei miei muscoli né del mio coraggio. Sarò sollevato col bambino, il carico prezioso e fragile che il mio collo e la mia schiena sostengono, mi trasporteranno in aria e mi poseranno in un luogo sicuro da cui riprenderò a correre restando ben diritto e fiero.”
*
Stanotte ha cominciato a piovere e continua a piovere anche oggi; è una pioggia smorta e tenace, insistente e ottusa. La nebbia è scesa sul porto. Il dorso dei gabbiani si confonde col grigio uniforme del cielo identico al mare che ha il grigio murato di una parete. Il Faro sventaglia e si riflette sul grigio rinviando la propria luce a sé stesso.
*
In Vico C. il solito cavaliere, raffigurato in un sovrapporta, ammazza con la lancia il solito animale alato, stando ben saldo e al sicuro in groppa al suo mastodontico cavallo.
La porta del palazzo è quasi aperta e vedo un androne dalle dimensioni insospettate. Vasto, fitto di colonne simili ad alberi secolari e volte a crociera bianchissime. Sulle pietre grandi ceste a forma di culla scolpite nel marmo, ceste da giganti, vuote, bianchissime. Anche l’aria fra i colonnati appare bianca ma non trasparente, come un pulviscolo di calce.
*
Dentro palazzo C. Ercole è rozzo, gonfio. Sovrasta una vasca senza acqua, calpesta e strangola un mostro a più teste di cui una gli sporge sopra la spalla come un teschio affilato.
Tutto l’animale è come prosciugato, secco, anche la fatica sembra conclusa da molto tempo, ma Ercole resta in posa, rigido e tronfio.
*
Qui camminate sopra pietre scritte, marmi incisi. Qui i gendarmi, chiamati sbirri da sbura, cioè il brodo della trippa che bevevano per riscaldarsi, hanno tracciato con la punta del fucile una tela. Su questo gradino di marmo, in questo angolo di piazza C., potete vedere il classico quadrato del classico gioco. Ne vedrete altri sparsi per la città, una città dove iscrizioni, targhe, segni, emblemi vi assediano dall’alto e dal basso. Guardatevi intorno, chinatevi su quella buca: serve per l’elemosina, per il restauro di una Madonna, e quell’altra per imbucare l’anonima delazione a un magistrato.
*
Finito il mercato in piazza C, hanno accumulato i rifiuti sotto un’edicola votiva. Formano una volta che ne sfiora la base. Sono resti di verdura, pesci, carta sporca, stracci. L’edicola ha una specie di tetto spiovente in ardesia, è poggiata su un muro alto circa tre metri che si affaccia sopra una piazzetta premuta da palazzi altissimi, scrostati. Il fondo della nicchia è blu, la piazzetta è grigia.
*
Una figura regge nella destra il globo, è dipinta di giallo, guarda verso il mare, è dritta in piedi; accanto ha un cavallo bianco con le orbite sporgenti macchiate di rosso. Quei globi sono pieni di rabbia, di furore. La cavalca una figura con lo sguardo esangue, quasi distratto, con gli occhi di un verde scialbo e le labbra tumide; il cavaliere impugna una lancia e sta per vibrare un colpo sulla testa di un animale alato.
*
Qui potete vedere quel che resta della Tomba dei Giganti, costruzione enigmatica, poiché si racconta che a dispetto del nome fosse molto piccola. I resti, ormai quasi sabbia mischiata al terreno, non rivelano nulla. Laggiù potete vedere – è quel mucchio di ferro mangiato dalla ruggine – i Giochi Meccanici di cui restano enormi scaglie corrose, qualche accenno di struttura in cemento, e un oggetto che può ricordare un triangolo: il tutto indecifrabile come le spoglie della Tomba dei Giganti. Sotto quella frana, verso il mare, scorreva un fiume il cui percorso girava intorno al monte e scendeva al laghetto artificiale che fra poco vedremo.
L’architetto C., scenografo, ha radunato nel parco una sorta di bazar etnico stupefacente, accostando obelischi egiziani, templi greci, pagode cinesi, e tutto ciò che la sua balzana immaginazione gli suggeriva. La parte a monte del parco è abbandonata da secoli, e l’accesso fu proibito per un numero imprecisato di anni. Sì, è là che abbiamo appena visto La Tomba dei Giganti e I Giochi Meccanici. Lassù gli alberi sono crollati uno dopo l’altro, la zona è stata transennata, l’accesso, come dicevo, proibito.
*
In quella nicchia potete vedere un velivolo di carta simile a quelli ideati da Leonardo; più avanti, lungo vico C., vedremo una grande loggia in rovina, finestre sfondate; sempre in Vico C., una delle case più antiche del centro storico con una serie di archetti in mattoni, la casa dei C.; sull’angolo un grande fiore di carta, polveroso, dentro un vaso oblungo, dentro una nicchia col cielo stellato, la base di ardesia, due teste di angeli sbriciolate ma con le piccole ali intatte, e un’apertura a livello del selciato, il cui accesso è proibito, uno scantinato sbarrato da catene e lucchetti, sigillato col catrame. In cima a questa salita di mattoni non c’è più il palazzo dove abitò il poeta ***. Le sferzate di vento carico di vernici che vi solleticano il naso e vi fanno tossire arrivano dai cantieri, superano le mura della C., le vecchie mura di C., infilano Scalinata C., corrono verso Piazza C., aggirano ogni svolta, piombano sui tetti. L’odore di vernici e ferro e bitume è caratteristico della città di C. una cartolina olfattiva come l’odore di uova marce nei giorni di calura umida detta maccaia.
La città fu bombardata a tappeto, ferocemente, dal mare. Una cronaca andata perduta, la cui copia abbreviata si trova negli archivi di palazzo C., descrive incendi ovunque, massacri, impotenza difensiva.
*
Durante un altro conflitto una bomba penetrò nella cattedrale ma non esplose. Nacque il culto dell’obice inesploso per volontà divina: lo spazio sacro avrebbe annullato la carica mortale del proiettile che è esposto all’inizio della navata destra. Sono centinaia i fedeli che si recano a baciare l’obice nel giorno in cui neutralizzato cadde pacificato.
Un culto di fertilità è legato all’immagine di una Madonna con bambino custodita sempre nella cattedrale. Le donne sterili si recano a pregare la madonna e restano finalmente incinta. Ciascuna offre in voto un bavaglino. Alla colonna sui cui è affrescata la Madonna sono attaccati centinaia di bavaglini come l’albero di una nave decorato da bandierine.
La colonna non è lontana dall’ingresso: quando l’uscio resta aperto e soffia vento forte, i bavaglini oscillano, si scuotono, come volessero abbandonare la colonna e volare attraverso le navate, sugli altari, sopra i pulpiti, fino a raggiungere il vertice della cupola, le finestre, la luce, una possibile fuga.
*
Il mio padrone ha ridotto al minimo le mie mansioni come le sue uscite; e non parlo delle uscite fuori dalla proprietà, ma delle uscite dal suo studio. Riceve raramente il suo amico e anfitrione della città di C., so che ha lasciato crescere barba e baffi, peraltro curati, vedo la sua posta, e lo vedo, poche volte, camminare in giardino.
Ormai lo osservo come osservo il passaggio di una nuvola o di un gabbiano. Sono stanco di aspettare il giorno in cui deciderà di abbandonare questo borgo marinaro che ha tentato di essere una città, questo ammasso di palazzi schiacciato dalla sua stessa storia, un’ombra fitta e millenaria, un’eco interminabile come gridare dentro una cattedrale altissima.
*
Non servendo quasi più il mio padrone, avendo affidato la cura della nostra imbarcazione ad altri marinai, passo una parte delle mie giornate in una vineria, sotto i portici di Palazzo San ***, una mescita senza pretese che sbuca fra legni, calcinacci, botti sfondate. Sto quasi sempre in piedi sulla porta, bevo in mezzo ad altri di cui non conosco il nome ma di cui ho imparato presto a conoscere i volti, l’impronta dei volti. Sono anche loro impronte, come quelle nei muri, nelle pietre, come il marmo scavato per secoli da zoccoli di legno, incurvati come l’ardesia dei gradini. E il vino non è male, il passaggio dei carretti mi distrae, passano a centinaia con i carichi più diversi sistemati con grande perizia oppure barcollanti. Gli urli dei venditori mi esasperano, a volte. Le richieste di elemosina anche. Oggi, un mendicante mi ha scagliato contro una moneta mentre passavo in Via San ***. Lo incontro spesso: dorme sui gradini di una strada di mattoni un po’ nascosta, non lontano dalla chiesa di San ***, chiesa dalla facciata bianchissima sui cui gradini si apposta di giorno, rannicchiandosi in cima; a volte esplode in una risata beffarda e demente. È basso, il busto corto, come schiacciato, ha capelli lunghi e grigi e la barba sporca.
Una volta, mi hanno detto, si sdraiava davanti all’ingresso di una banca con i testicoli di fuori, li esibiva e sghignazzava.
*
Guardando verso terra vedrete centinaia di laccetti colorati, sfilacciati, come braccialetti fuori uso; o lamelle lunghe circa venti centimetri, molto sottili, residui di cantieri, si suppone. E bulloni, viti, scaglie di ferro. Pezzi di legno minutissimi, quasi segatura addensata fra le commessure delle pietre, impigliata fra le maglie delle grate, stracci agganciati a filo spinato nei luoghi dove passò la guerra, indicazioni graffiate sui muri, avvisi, divieti, oggi una stella filante avvolta al piede di una statua si annoda per un capo a un lampione.
Qui di fronte sorgeva un famoso albergo; i nomi degli ospiti illustri sono incisi su una targa poco visibile all’inizio di Vico *** vico strettissimo, sempre in ombra, male illuminato. L’albergo ospitò, fra gli altri, l’inventore di un gigantesco animale bianco, l’artefice di una creatura costruita con i pezzi di altre creature, uno scrittore che non amava la città di C., e altri notabili.
*
Accanto alla vineria martellano, demoliscono, gridano ordini, spostano scale, assi, pulegge, carriole. L’architetto *** sta ristrutturando Palazzo San ***, svuota il porticato. I colpi fanno tremare pareti, pavimenti, tavoli, bicchieri. Il vino ondeggia nelle caraffe e sul banco c’è un dito di polvere. L’oste impreca.
Si sta fuori sotto l’arcata, oltre l’arcata, sulla strada fra il palazzo e Via di ***. Il fotografo ufficiale documenta l’opera di ristrutturazione e scatta una foto anche a noi avventori, accalcati davanti all’obiettivo. Osservo gli altri. Qualcuno si toglie il cappello come entrasse in chiesa o seguisse un corteo funebre. Assume anche un’espressione compunta. Sono tutti rigidi come ha chiesto il fotografo. “Fate finta di essere statue!” ha urlato. Qualche ragazzino si mette in posa, sporge il torace, uno gonfia le guance, uno, serissimo, come una sbarra stende un braccio verso il cielo.
*
Sono a dieci metri l’uno dall’altro, quasi di fronte. In mezzo c’è una mattonata: Salita di S. M. ***. Uno è alto, magro, di pelle scura, mastica uno stuzzicadenti; non si capisce dove stia guardando, ha le pupille mobilissime, sembra guardare tutto e niente. Non ha più di trent’anni. Fra i due è raro che passi qualcuno. Più in alto, dove la salita svolta, sembra ci sia molta gente, perché arrivano voci chiassose, rumori come di una festa e d’improvviso vuoti, intervalli silenziosi, e poi ancora baccano, e tutto a folate imprevedibili.
Io sono seduto e osservo una torre che termina con una serie di piani ad archetti, archetti di mattoni. Una vera torre per civette, con ciuffi di erbacce agitate dal vento.
I due sono poco più in alto. Il giovane di pelle scura mette una mano in tasca e ne estrae un biglietto: lo guarda, lo capovolge, lo guarda ancora, lo stringe nel pugno, lentamente. Dietro ha una parete bianca macchiata di salnitro, i resti di un affresco che ha lasciato tracce di porpora, giallo, blu e quei toni inventati dal passare del tempo.
Lungo la mattonata sale un uomo anziano appoggiato a un bastone; sembra fare molta fatica, come se l’aria fosse troppo densa per lui. S’irrigidisce mentre passa in mezzo ai due, stringe le labbra, e fa una specie di scatto in avanti, accelera, per pochi metri. Deve aver trovato un punto meno resistente, un’aria più sottile, più adeguata alle sue forze. Così penso e sorrido, e guardo verso il basso l’acciottolato su cui poggio i piedi: forme tonde, verde scuro, pietre di fiume, probabilmente.
*
Solo nella città di C. vedrete pezzi di balconate murati in orizzontale, colonne di balaustre come inserti piantati nelle pareti, incastri bianchissimi, forme neoclassiche di provenienza incerta, spostate non si sa da dove, murate non si sa perché, né quando. Orizzontali; ad altezza d’uomo e anche più in basso, in sequenza, come una segnaletica, lungo le pareti di un vicolo che si schiaccia contro le case di Piazzetta dei ***, piazzetta lurida, le finestre con le imposte pencolanti, imbrattata, cupa, sozza di merda di piccione. Non c’è intonaco che non sia scrostato, spaccato, pareti come manifesti scollati, appesi nel vuoto.
*
Dietro queste sbarre altissime vedete i resti della chiesa di S. M. ***, in parte restaurata. Senza copertura centrale entrano aria, pioggia, sole, uccelli, polvere, foglie, carta, pulviscoli. Quasi un tempio pagano.
Oggi vediamo un gigantesco cavallo di cartapesta monocromo. Faceva parte di uno spettacolo sulla guerra di Troia che andò in scena nel *** al teatro del ***.
Fra qualche giorno sarà chiazzato di escrementi, sarà un trespolo per gabbiani, piccioni e altri volatili; lo consumeranno il vento, la pioggia, il sole, lo mangerà il salino. Torneremo a vederne i resti.
*
Ho fatto un sogno convulso, come in preda alla febbre. Camminavo da parecchi giorni eppure non ero stanco. Avevo visto molti paesaggi diversi, animali bizzarri, costruzioni strane, mezzi di trasporto inusuali, avevo sentito lingue, musiche incomprensibili, visto luci dai colori fantastici. Una voce afferma: “tu non hai mai camminato, era il mondo esterno a scorrere. Per questo non sei stanco.”
Poi mi ritrovavo in Piazza C., dove la giostra girava a velocità vertiginosa e intorno alla giostra ridevano uomini e donne indicando i loro bambini che urlavano, impazziti di paura, dentro la giostra, aggrappati ai cavalli, ai personaggi di Disney. Ogni tanto qualcuno raccoglieva un pezzo di giostra e gridava: Te lo tengo io! Ti tengo un occhio di Bambi! A dopo!
Poi qualcuno fumava tantissimo, gonfiandosi a ogni boccata, si espandeva sulla piazza tremolando, traboccando sui gradini, come un cartone animato. Era una palla vischiosa. Io correvo cercando di scansare quella lenta marea che si era allargata per un raggio considerevole.
Intanto il mio padrone scalava la statua di ***. Arrivato in cima si era messo a demolirla a colpi di piccone. Urlava che l’armatore mandava le navi a picco per riscuotere l’assicurazione facendo annegare quasi tutto l’equipaggio tranne i complici, gli ufficiali, e pochi altri. Meritava di crollare, di affondare nella sua polvere, di soffocare nei suoi pezzi, di provare l’orrore del naufragio.
Adesso il mio padrone era immobile, la faccia striata dagli escrementi dei gabbiani. Era altissimo, più alto della statua che aveva demolito, un po’ curvo, lo sguardo severo, il naso aquilino, le fedine lunghe, la mano appoggiata su un tavolino a tre piedi. Sembra davvero la statua che c’era prima, dice uno. Anche la posa è identica. Non è cambiato granché. Chissà se la gireranno a sud, a ovest, a nord, a est.
Io lo metterei a guardare i palazzi, schiena al mare, dice un altro. Poi qualcuno si metteva a fare ginnastica saltellando con un cartoccio in mano da cui traboccava uno strano liquido scuro. Mi accorgevo che erano molti a saltellare col cartoccio in mano, e ridevano tutti di una risata idiota e sinistra, succhiando fette di limone.
Poi cercavo un cartello, un’indicazione per tornare a casa. Pensavo: “in fondo non è affar mio. Le giostre girano, i bambini gridano, la gente fa ginnastica; e le statue crollano. Che c’è di strano? Succede da sempre e quindi…”
Ricordo che accadevano altre cose ma era tutto mischiato e velocissimo. Mi è rimasto impresso uno che prendeva a calci l’aria e sembrava divertirsi un mondo.
*
Il brusio delle ruote fasciate di stoffa, il grido di un cocchiere, lo schiocco di una frusta; mi scanso, tutti si fanno da parte, la carrozza lunga, nera, con scritte dorate indecifrabili, i cavalli bardati di nero, attraversa Piazza ***, lenta, cadenzata. Tutti si tolgono il cappello, le donne abbracciano i figli, i bottegai stanno immobili nella penombra, tutti sono silenziosi, riverenti, raccolti, nessuno piange. Il putto in cima alla fontana non getta più acqua. La carrozza compie una mezza curva, rallenta, sembra quasi immobile. Accosta il muro di Palazzo ***, la cui facciata è adorna di angeli enormi, trombe enormi, stucchi e dorature spesse, grossolane. Accosta il grande, alto portone a due ante chiodate simile a uno strumento di tortura. Qualcuno scende ma nessuno vede. Chi scende si ritrova di colpo dentro l’atrio di Palazzo ***. Nel silenzio generale un fruscio ripetuto, il gemito di un’asse della carrozza, il tintinnio debole di un campanello arriva da una finestra del secondo piano spalancata ma protetta da tende massicce, rosse, come un muro di mattoni spesso e ondulato.
Chi solleva quelle cortine? Quale vento può spostarle?
La carrozza sembra piegarsi su un lato, il predellino tocca quasi il selciato, il cocchiere annaspa, tutto il telaio trema. Solo i cavalli restano impassibili, alteri.
**









(Narrazioni, 1)