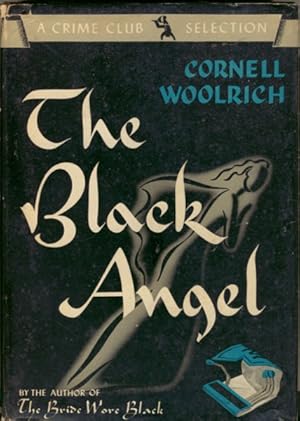(2022-2024)
La vita è come una leggenda. Non importa quanto sia lunga, ma quanto sia bene narrata (Seneca)

Fausto Melotti, La nave di Ulisse
**
In forma di lettera, di Angelo Lumelli
Caro Marco, leggendo il tuo poemetto Non tornare è la grazia – ho dovuto rileggere parecchie volte – finalmente m’è sembrato di capire, almeno un po’, che il ritorno del tuo Ulisse non fosse quello di cui si parla – Itaca – bensì questo, il poema della voce – una strada del ritorno – evitando il finale che lascia soli gli spettatori, quando si tira il sipario, ultimo tradimento della letteratura, del suo spettacolo – ed allora mi è venuta in mente una parola, in dialetto – nell’incrocio di ligure lombardo piemontese delle mie parti – la parola feitò – magnifica e sterminata – che non vuole dire esplicitamente fatato, bensì piuttosto, conciato, lavorato, trattato con arte, in modo da non sentire dolore, soprattutto il dolore qualunque, al modo con cui operano i calli nelle mani dei contadini, dotate di un tatto nuovo, idoneo ai bisogni – fatato perché capace di attraversare ogni tattilità in modo conveniente, spiritualmente allenato, un superamento del dolore in quanto disordine ed ingiuria, a fronte dell’attitudine alla compostezza, dell’agire destramente. Con ciò intendo, tra l’altro, il ritmo persuasivo, il tono drogato dell’eloquio, la malinconia senza sfoggio, la voce che mai lascia sole le parole, che le accompagna con il respiro, grande tema che attraversa i monologhi di Ulisse, il tuo. Ti comunico questo sentimento, ancora confuso, perché il tuo poema è, come si conviene – dopo l’Odissea – un racconto il cui tempo viene arricchito (interrotto?) da bolle di pensiero (la parte eleggibile, eletta?), da un presente ostinato che manda Itaca sullo sfondo – la pausa, nel viaggio, dura millenni. Sempre imminente è un colpo di mano – Sono un re che non smetterà di tornare. | Un re che non è mai ritornato – per cui il tema del ritorno nasconde – c’era da aspettarselo – un trojan – altro che l’infantile trucco di un cavallo di legno! – al punto che il tuo Ulisse scopre il proprio luogo nel raccontare e nella sua poetica – sfacciata fino alla lirica – per il tempo che dura questo mio narrare | la mano non trema più… Il tono fatato, anestetico, persuasivo del tuo poema, dichiara che questo è il luogo che fa del ritorno un ritornare, infinitamente – e che il luogo si è trasformato in questa musica, in quest’aria – sia pure intesa come aria d’opera, teatrale, lirica in modo supremo, come accade nel gran pezzo: Se l’aria che respiri fosse l’aria che respiro – mozartiano, da realizzare in duetto – e sarebbe memorabile.
Così Ulisse ha trovato la patria senza fondamento, perfettamente inventata, come la prima frase di un romanzo, che afferma qualcosa di inessenziale, senza pudore, un luogo qualunque – che si riscatterà soltanto se, per convenzione, diventerà un luogo assoluto o un non luogo, che è lo stesso. Così la letteratura mostra il proprio candore quando si presenta come tale, dichiarandosi, allo scoperto, non celando la miseria, l’impostura, lo scopo ingenuo. Infatti quando, finalmente, Ulisse deciderà di tornare, il luogo sarà senza più le memorie d’altri, sarà vuoto, un luogo diventato unico e qualsiasi, la perfetta astrazione – vana e poetica, necessaria.… come ha voluto il capriccio della nascita, il massimo pregiudizio, la fondazione che se la ride – tanto da essere fedele a una casualità, riscattata con la vita, come sempre dominata dalla gran maga dei particolari, dall’onore che bisogna riconoscere al luogo dove si sono aperti gli occhi, dove si è visto il primo cielo. Quell’ultimo luogo non è finale bensì perennemente iniziale, è un principio – strana ebrezza, spoglia, additata dalla poesia, letteralmente mostrata con il dito, non detta. Ciò che è detto limita il dire, la sua tremenda giustizia? Anche per ciò, quel luogo sarà senza testimoni oculari – né Penelope né altri, nessuno di quelli che aspettavano – e che, attraverso l’attesa, mettevano un’ipoteca sull’accadere.
Questo Ulisse, il tuo, non è nemmeno quello – ancora positivo e credente – del canto ventitreesimo dell’Odissea il quale, appena tornato, pensa di intraprendere un altro viaggio, come profetizzato da Tiresia. Quell’ultimo viaggio – che il tuo Ulisse si guarda dall’intraprendere – Non navigo più. Da me | non verrà il segnale di altre rotte. | Il mio viaggio è finito. – è un fulmineo trattato di poetica, omerica, con grandi conseguenze per il nostro stile occidentale: allorché un forestiero gli domanderà, ingenuamente: una pala è quella lì che porti sulla tua spalla | luminosa? – mentre era un remo – a quella domanda Ulisse comprende che il viaggio è finito perché è finito il linguaggio comune ed è finito lo scopo del racconto, perso il pubblico e il congresso degli dèi conosciuti. Lo scacco che subisce il linguaggio del tuo nuovo Ulisse è di altro tipo, intrinseco al mistero della frase, nel dire stesso, mai coincidente – destinato all’iperbole, quella che lascia soli ed immensi.
L’Ulisse che ha attraversato il novecento sa come sventare le false corrispondenze: il linguaggio subisce una torsione, un passaggio nel sonno – inversione dovuta agli dei dell’oscuro, da visitare spesso – visita che cambia le carte, trasforma le figure, le regole stesse della partita – Le parole inventano l’antro | e lo rendono vero…
Perché alla fine è lì che si arriva – dove arriva il tuo Ulisse, uomo che, da fermo, sospeso il viaggio, si dedica a parlare – per ritentare un viaggio che era stato accecato dai fatti, dalla loro ostruzione, parati davanti, onniscienti in primo piano – ora affidati alla voce, al suo tono mutevole, onorando ancora una volta il respiro, il suo spirare, forza mitica che aleggia per tutto il poema. Questo poema della voce non mette la propria voce al riparo, convenzionalmente destinata a dire, quindi fuori dal dire, garantita da un’altra legislazione, da un patto fidato: essa, la voce, è quella che rompe, forzatamente, forse illegalmente, il grande silenzio, come sembra accadere, in modo magistrale, nella grande sceneggiatura delle Sirene. Il tema delle Sirene mi sembra introdotto, con facilità e chiarezza, già prima, come un prossimamente al cinema:
Mentre la nave oscilla e il sonno si avvicina resto sveglio. | Le sirene potrebbero, invisibili, cantare…
[…]
Se dormissi anch’io, sentirei.
[…]
Dovrò essere sentinella | del canto futuro, | sentinella | del presente silenzio
…Dunque Ulisse ha capito come stanno le cose: le Sirene non cantano se non nel nostro sonno. Sono davvero loro? – è loro la voce che si alza nel fragore delle onde? – o è la nostra voce, il grido che emettiamo di fronte al loro silenzio? Ogni voce che renda conto di noi, del nostro sgomento, è soltanto nostra? Noi siamo il clamore di noi stessi, senza esiti ulteriori, senza portare aiuto o giustificazione? Mentre le scene si sovrappongono, caotiche, nel turbine del mare – ora sono Sirene, ora mostri rocciosi, forse già Scilla e Cariddi – nessuno dei naviganti, con le orecchie tappate con la cera, distingue più tra dentro e fuori – e il non udire – perversa mutilazione – solleva le grida interiori, fino alla follia:
Con le strida | ci uccideranno come accade da secoli. | Ecco le rocce fatali:è la leggenda, | la fine, l’inganno. | Ma nel cavo delle orecchie | è la cera, non sentirete le sirene. | Legatemi all’albero maestro, | legatemi ora, le corde alle ossa, | le sentirò io per voi, | idoli in mezzo alla schiuma, | uccelli maestosi con volti di donna.
Ma nessun marinaio smette di gridare: | a lui solo | appartiene il suo urlo |
come alla notte le rocce strette, | sua è la leggenda, | sprofondato nelle sue, non solo sue, | lacrime per le sirene mortali.
La voce è dunque la nostra resistenza e generosità? – come nostro più intimo simulacro, essa nasce a fronte dell’irrimediabile, magnifico e pauroso – essa è il nostro immediato che inverte la rotta, come il respiro, perennemente? Questa voce, mentre risuona nella grotta, dove vivono le immagini, i sensi che inventano le loro dita, le mani, è quella che non esige di giungere oltre la portata dei polmoni: essa rimane pronuncia, nel breve tempo, lealmente.
***
Non tornare è la grazia
Fra le ossa
una musica:
varca la sabbia
varca il mare…
Georgos Seferis
**
1
Vuotarono il pozzo. Cercarono. Niente. Soltanto pietre.
La piccola Persefone, si dice, portò tutto con sé sottoterra.
Giannis Ritsos
**
Non tornare è la grazia.
Navi naufragate, armi a picco, fine.
Ma io torno dove non è logico approdare.
Antro sacro, fitto di ombre, sulla volta sirene e ciclopi.
Non restano del mio viaggio che voci, ossa, rovine, tuoni.
Un fumo di nave, un’ansia di remi, il vento asciutto sui sassi.
Non diventerò il re che i nemici aspettano.
Non sarò il morto predestinato del regno di Itaca.
Approdo nell’antro.
Muschi anfore ulivi telai di pietra manti di porpora,
le due porte, Borea umana, Noto divina,
e lei mi guarda, nata ora, dall’aria
solo nostra, ovunque
odore di ulivi e di miele,
la accarezzo dove leggo
la sua estasi.
*
In sogno mi inseguivano, coltelli snudati, fiamme accese.
Poi tutto spariva.
Ero uno fra i tanti, nella piazza vuota e nera,
osservatore di ceneri spente, di architetture crollate.
Non tornare è l’unica grazia.
A Itaca sanno che sono arrivato.
Quindi non verrò, non ancora.
Hanno galoppato per giorni i messaggeri.
Avvisati, i nemici sorvegliano la reggia, affilano le lame.
Io studio la grotta come, prima di essere guerriero,
scrutavo il volo degli uccelli e osservo
code di sirene, prue di navi,
ninfe.
Quando regnavo spiavo segreti flebili, dimenticabili.
Ora il segreto è mio, inverosimile,
chiuso nella morbida pelle delle sue cosce.
*
Le cose normali sono simboli funebri.
Amo quelle imperfette e strane:
una forma di perfezione che esige amore.
Nessun pensiero è originale ma origina
metamorfosi,
acqua nel fiume,
mai identica, libera,
cerca i suoi argini,
non celle ma pietre ruvide o lisce.
Alla reggia non salirò.
I nemici non mi vedranno.
Lei, ninfa che sfioro, miele, dita, sospiri.
Da me non verrà il segnale di altre rotte.
Alla fine del mio viaggio
non ho né salvato né ucciso.
*
Sculture, disegni, pitture, il mondo fluttua da sempre, le pietre sono fluide, ogni pensiero trapassa un mondo mai chiuso, forato da buchi, crepe, terrazze, aperto ti incalza, ti avvolge, non guardi gli orrori, li senti presentii, sei loro da sempre, sfingi, minotauri, chimere, centauri, fra veglia e sonno, il dito premuto sulla soglia dell’antro, al centro del cieco rombo dell’acqua, non so per quanto tempo si potrà evitare il caos. Ma il tempo è fermo come l’affresco di un cielo. La reggia è lontana dalla grotta,come la morte da me. Non offrirò alla storia il racconto di un re giustiziato.
*
Dopo aver terminato le loro opere o compiuto i loro viaggi, lasciano il paesaggio: acque dense di cadaveri, rami divelti, carcasse di uccelli, navi fracassate. Cosa fa, chi viene dopo? Può distruggere ancora? Difficile, dopo il gesto che ha messo tutto a sconquasso. Eppure si deve. Si fa arte per come lo consente il mondo: si lavora a ciò che è dentro e fuori, attenti a ricucire strappi, seppellire morti, salvare esseri quasi sommersi.
Io sono un re di cui vorrei si dimenticasse il nome. Ma lo prometto: riordinerò il paesaggio infranto.
*
L’immagine più bella è alle nostre spalle.
La bellezza non è diamante fermo
ma fogliame che sfugge, luce che si dimentica,
specchio dove vedere un altro viso
come quando, rapiti per amore,
torniamo a un mistero nitido, senza dèi.
Non possiede illusioni, quel mistero,
ma la sua realtà, dove si rifrange.
Non ero l’unico, l’unico re.
Tutti i prìncipi dell’arcipelago sono partiti con me,
chi per possedere e depredare isole,
chi per salvare popoli.
Ma tutti dialogarono con dei simulacri,
pietre trasparenti infilate in chissà quale grotta,
da cui sempre si sentiranno gridare,
non consolati,
i naufraghi:
noi.
*
L’arte è l’eterna facoltà di nascere e rinascere. Ha un solo traguardo: essere anonima. Più è anonima più grande è l’artista che ha operato escludendosi, disponendo le pietre dei templi come un servo silenzioso. Chi riempie l’otre di tutto il suo vino non sarà mai ubriaco: è superbo e stupido, vittima del principio e della fine di se stesso. Si sazia guastando la sua opera. La presenza di sassi enormi da scolpire incute rispetto e paura, impedisce all’artista di dominare la scena. Se fossi uno scultore, mi piacerebbe che alla mia scultura restasse addosso il gusto del sonno, il sapore del buio, quel segreto sonnambulo che nessuno scalpello saprebbe mostrare. Non si possono mettere a fuoco tutte le figure. Occorre socchiudere gli occhi, se si tenta di trovarne il segreto.
Chi sente trema, non centra il bersaglio. Bisogna sentire dopo.
*
Se un uomo morisse mentre cerca di raggiungere delle terre nuove, troverei nuove parole per lui. Non sarei, con il mio silenzio, complice del suo. Chi narra una storia non dice cose né vere né false: racconta come un uccello che vola sopra un picco disegni la traiettoria del suo volo.
Ieri, in sogno, ho visto un’iscrizione in una lingua sconosciuta. Avrei voluto copiare quelle parole ma non avevo né papiro né inchiostro: poi, immaginandone il contenuto, ho pianto. Ogni vero sguardo non divaga, ma le vie sono raggi che non confluiscono.
Sono condannato a sedere in una grotta a guardare profili di sirene, semivivo. Vedo il mondo attraverso vite di marinai, principi e re, vite altrui che passano dentro il mio sonno come un soffio di correnti remote.
*
Cosa hanno lasciato gli altri eroi?
Di loro nessuno disse niente
perché nessuna voce testimoniò niente.
Qualcuno, al ritorno, ha trovato una morte violenta.
Chi nulla.
Chi è rimasto a metà viaggio, minacciato da orche e balene.
Io, approdato, non torno.
La mia famiglia è tutta qui:
l’aria nella pietra,
questo odore di mucosa e di pelle,
la mano nel suo miele morbido.
Chiude gli occhi.
Tramortita dall’estasi chiede le mie dita,
le sue braccia mi sfiorano la schiena.
E il resto del mondo, sogno greve di giorni,
scompare: a restare viva, senza passato e futuro,
è questa carezza, mia e sua, nel presente
così viva da essere non essere
il miraggio che è,
non mortale
ninfa.
*
Non essere morto: avere visto morire.
Gli uccelli, sopra la nave, mandavano strida?
Stavo ritornando, ma chi avrebbe voluto che accadesse?
Gli uccelli mi stormivano addosso,
bloccavano lo scafo con artigli potenti.
Poi arrivò un vento di ghiaccio, li disperse, bloccò le lacrime.
Ripresi la rotta ma non avrei voluto.
Se dentro la nube fitta si fosse rovesciata la nave
sarei stato felice.
Sognavo di ripartire smettendo di ritornare.
*
Tutte le stanze della reggia erano specchi, in sogno.
I miei nemici, annichiliti dal riflesso,
fuggivano via, vedendo mille simulacri di me.
Quando accadrà realmente
riprenderò possesso del mio regno.
Nessun nemico mi aspetterà: tutti, confusi,
seguiranno le mie ombre.
Ma non desidero quel momento.
Esistono altre immagini del ritorno.
Aspetto.
*
Non un pensiero errante
ma un viaggio non terminabile,
né un sopra né un sotto, né un alto né un basso,
tutto pura aria, vertigine senza fondo:
nell’impossibilità di ogni fondamento
continuiamo in sogno a fondare noi stessi.
Nella grotta non si vacilla: si guardano
i rami oscillare perché il vento esiste.
Dove manca il vento
è assente ogni vita: resta il sasso sordo,
la testa ribattuta sul muro,
la pietra
senza di noi.
*
Morire dentro le mura? Laggiù?
Questo il finale che mi attende?
E poi, che io sia il re è tutto da dimostrare.
Non esistono più regni ma solo favole
che tramandano destini di eroi.
Non tornare
ma potere tornare:
quel lungo brivido sottopelle.
La reggia di Itaca: nessun mondo ulteriore.
Tornerò, ma non sarò riconosciuto.
Tornerò, ma sarò l’unico senza maschera.
Che aspettino. La pausa, nel viaggio, dura millenni.
Io non sono più quel re. Scomparso, non voglio apparire.
Aspetto, a tornare, che tutti
non siano.
Che i volti dei nemici fissino la mia assenza
scrutando l’orizzonte, estenuati.
*
Potrei arrivare con un esercito che li sgominerà
potrei
non arrivare mai.
Ma lei mi accarezza ora,
miele, sospiri, albe.
Dentro le sue dita nulla esiste più,
nulla,
del mio lungo mondo oscuro.
*
Il pensiero esiste alla temperatura della sua creazione.Si è sempre detto che, se fossi tornato, loro mi avrebbero ucciso per regnare al mio posto:loro, così abituati alla mia assenza, dopo le mille notti e i mille giorni del mio lunghissimo viaggio; loro, ormai, così carichi d’odio da non volermi più vivo, nella reggia, a comandare e a disporre. Il pensiero esiste alla temperatura della sua distruzione.
Per me i mostri non erano isole o balene o naufragi, non le follie della eterna guerra per mare, ma quell’orrore che mi aspettava: loro, silenziosi, acquattati nell’ombra, le mani strette sui coltelli. Dovevo tornare solo perché avessero l’occasione di uccidermi? Mi ero salvato dagli squali e dai tifoni per morire in questo modo esatto, sanguinoso, veloce?
No. Arrivato, camminerò in silenzio. Mi salva la passeggiata segreta fra porto e casa, senza nessuno ad acclamarmi, quelle brevi ore gentili, il vicolo dove camminare solo e libero, senza armatura e senza regno, la morte fisicamente distante, per pochi giorni ancora re, ancora vivo e lontano, nelle narici l’odore dell’acqua, nelle dita il suo morbido pulsare, gioia rubata al destino tracciato, gioia labile e chiara.
*
Ci supplicò che non pronunciassimo più il suo nome
e si fermò sull’isola dove lo facemmo approdare.
Sarebbe vissuto lì, disse.
Non potevo sopportare i volti di chi mi avrebbe rivisto.
Li amavo tutti: non mi guardassero mai come un estraneo.
Preferivo diventare colui che non sarebbe tornato
colui che si piange morto.
Osservo ancora il mare sinistro.
Mi preparo.
Piccole meduse salgono dall’acqua.
L’antro mi possiede, l’odore mi avvolge, non torno.
*
So dove molti dei miei compagni sono approdati.
Nessuno verrà qui, dicevano,
o se verrà sarà vittima del sonno
e dormirà sapendo di essere ritornato,
sognando la terra prediletta
dove l’aria scorre felice.
So del sonno quando smetto di sapere
se il corpo che mi accarezza è reale
o se lì inizia il suo fantasma.
La testa si regge male sul collo.
Vorrei essere aria.
Con la luce del giorno
i nocchieri lasciano il timone alla deriva.
Guardando dal fondo della nostra forma
vedremo varianti del mare:
niente onde o coste o scie di uccelli sopra lo scoglio,
mentre naufraghiamo in un bianco senz’acqua,
non sapendo, amando
non sapere.
Ma io tornerò, un giorno, a Itaca.
*
E se uno degli altri prìncipi tornasse ora? Gli abiti fradici, guarda le porte senza nessuna maschera. Le porte si apriranno tutte insieme nella piazza abbagliata dove la luce lo attende e tutti gli uomini, in tutta la piazza, vorranno sapere perché non lo abbiamo sepolto (ma già lo sanno, già lo sappiamo: voleva soltanto il mare e così lo facemmo scivolare nei flutti mesi fa: il tonfo dell’acqua ci parlò in un attimo di tutta la sua vita, siderale e terrena).
Sapere quali dita mi sfiorano ha forse un senso? Se fosse solo un rifugio della mente, questa grotta sarebbe meno reale?L’aria lenta, il vento dolce, gli odori unici.
Come re, fui sospinto in mare armato di navi.Come naufrago, torno guardando mani rugose che sarebbe bello sentire mie. Almeno mi si sciogliesse il ghiaccio dalle unghie…
*
Le parole inventano l’antro.
Lo rendono vero.
La vera carezza separa dall’abisso,
l’odore dolce fugge per sempre la morte.
**
2
E gli uomini vanno generando statue.
Georgos Seferis
**
Sordi e muti a cantare, circondati da alberi
con statue arcaiche e sfingi sottili:
attendere il sole del buio,
l’ineluttabile luce fra le dita.
Ecco molti dei miei compagni,
persi in isole senza nome,
dove il vetro dei palazzi è arcipelago di specchi nel buio.
I superstiti torneranno, ma da quale regno?
E con quali correnti?
A picco, l’erba delle rive.
Ma dal ponte di una nave
potranno vedere le rive del fiume senza rischiare la vita?
Sono verdi i giunchi? E perché riflettono l’abisso?
È proprio questo il mare?
Nel mio sonno giungono dalle onde
messaggeri con vesti asciutte
e fra le loro dita crepita la sabbia di viaggi dissolti
nel fumo di altre onde…
*
Partiti per conquistare regni e città,
ricordiamo prìncipi insepolti.
Nuvole nel cielo? Nessuna.
Una scia rosso-oro saliva dai boschi.
Siamo tornati con i nostri volti.
Dal fondo della nostra ombra sono fango gli occhi.
Nere tele, i muri.
Ma un nuovo inizio socchiude porte sottili,
maschere mai esistite.
Ritrovo primitive carezze
fisso allibito il vello scuro:
Orfeo smette di fischiare ai vogatori.
*
Da re, resto nella grotta.
Resto dove desidero.
Qui non viaggio e non torno, né guerriero né principe.
Lascio che le parole mi arrivino alla bocca,
che le dita non cessino di sfiorarmi,
che la ninfa mi scorra fra le gambe.
L’aria ha movimenti segreti
l’odore dell’acqua mi inebria
come un suono.
*
Con le strida
ci uccideranno come accade da secoli.
Ecco le rocce fatali: è la leggenda,
la fine, l’inganno.
Ma nel cavo delle orecchie
è la cera, non sentirete le sirene.
Legatemi all’albero maestro,
legatemi ora, le corde alle ossa,
le sentirò io per voi,
idoli in mezzo alla schiuma,
uccelli maestosi con volti di donna.
Non temete.
*
Credono ancora che emettano canti
le sirene
ma sterminato è il silenzio:
chi grida sono le nostre voci,
come rasoi nelle gole,
la nave ancora una volta
oltrepassa il nodo di rocce.
Ci fingeremo salvi, liberi
dal canto dei mostri, libere le teste dalla cera,
io capitano che gioisce nell’inganno.
Ma nessun marinaio smette di gridare:
a lui solo
appartiene il suo urlo
come alla notte le rocce strette,
sua è la leggenda,
sprofondato nelle sue, non solo sue,
lacrime per le sirene mortali.
*
Mentre la nave oscilla e il sonno si avvicina resto sveglio.
Le sirene potrebbero, invisibili, cantare,
l’aria scossa da brevi sussulti.
Ma io non sento musica, non subisco sortilegi.
Meno che venti
questi sono fruscii,
una smorfia sulle bocche
dei marinai addormentati.
Se dormissi anch’io, sentirei.
Ma sono scie di suoni, abbasso le palpebre
senza dormire.
Dovrò essere sentinella
del canto futuro, del presente silenzio.
**
3.
Come chi nasconde un tizzone tra la cenere nera
ai confini d’un campo, non avendo altri vicini,
e serba il seme del fuoco, per non accendere altrove,
così Odisseo si coprì con le foglie…
Odissea, Libro quinto, versi 488-491
**
La grotta: mio luogo reale,
dopo interminabili rotte.
Ora sono dove voglio essere.
Non nella reggia, non in mare aperto.
Qui. Sotto una volta. Con questo odore
denso e lieve
di erbe e d’acqua,
desiderando muovere le dita
nel corpo che mi attende.
Il suo odore persiste in me. La ninfa
un giorno fuggirà, senza allontanarsi,
ma ora è, con respiro e dita,
con miele di voce,
me.
*
Nell’universo della paura ci sono re che tornano e re che sono uccisi.
Io, durante il viaggio, ero sereno. Di notte deliravo: il delirare non è solo uno smarrirsi ma un lento costruirsi, come quando si scavano strati su strati e per un attimo alcune voci sotterrate riemergono e quelle dominanti restano mute.
Oggi, al riparo nella grotta, parlo per le stesse ragioni per le quali il pellegrino cammina: gioia di essere in nuove terre, non desiderio di possederle. Per il tempo in cui dura questo mio narrare la mano non trema più, gli elementi si calmano, il mondo smette di franare. Vivo scavando buio, disimparando regole vuote. Parlo non come un cieco ma come un quasi cieco potrebbe parlare della luce vista. Prima trovo le parole, poi comincio a sognarle: i sogni sono la memoria del futuro. Detesto che siano interpretabili da persone sane e sicure. Mi sono voluto sognatore inguaribile: chi mi parlava della vita comune, della caccia, dei viaggi per mare, mi annoiava, mi lasciava confuso.
Però, essendo re, in quella spedizione di re sono dovuto partire.
*
Perché siamo partiti? Cosa volevano davvero i re e gli equipaggi dei re? Depredare popoli, occupare terre? In nome di quale volontà ci siamo mossi con le nostre navi?
Ma ormai sono tornato e intendo vivere solo. Vivere soli tutta la vita è coraggioso e saggio, anche se il prezzo da pagare causa dolore. Ma il dolore trasforma la mente in teatro e ciò che sembra una catastrofe diventa una delicata architettura ritmica, una forma speciale di danza. Qui, dentro questa grotta, so di essere uno spettatore a margine dello spettacolo, uno che sta in teatro con gli occhi bendati: qualche volta mi arriva il significato secondario di qualche parola, di qualche musica, e divento ansioso perché capisco che era proprio questo il significato principale: partire, causare morti, naufragi, tempeste, e poi tornare, felici di essere soli.
Oggi sono più consapevole di ieri di essere vicino al centro del mondo, all’asse potente della ruota, ma quella continua a girare e la mia vicinanza non aggiunge e non toglie niente, è un attimo tantalico che neppure ha più la qualità del supplizio.
*
Sono un re che non smetterà di tornare.
Un re che non è mai ritornato.
Viaggiando per vedere terre ulteriori
ho sentito un vento dal mare, un suono di vele.
Vele, non sudari. Nave viva.
Ora sono qui, questo antro è la mia nave, qui
tutto è possibile.
Nella grotta temperata convoco gli spiriti:
devo tornare alla reggia o riprendere il mare?
Insonnia e carezza:
pareti opposte del mio unico specchio.
**
4.
Non abbellirmi, Odisseo, la morte!
Vorrei da bracciante servire un altro uomo,
un uomo senza podere che non ha molta roba,
piuttosto che dominare tra tutti i morti defunti.
Odissea, Libro XII, versi 488-491
**
«L’aria? Ma non capisci?
È l’aria che manca.
Qui spettri, vesti, voci, ricordi.
Qui, buio.
Ma l’aria?
La respirerai ancora risalendo dagli inferi
e noi ti penseremo e vorremmo un minuto
per vedere fra gli asfodeli la luce, il vento, l’attimo
nell’erba, la terra calda nel podere.
Poi, di nuovo, buio.
Non si cambia il destino. Ma di quell’attimo,
le dita strette dall’aria, puoi farcene dono?
Sei un re. Potresti.
Non si è re per caso.
Se capita un mistero, chi regna ne è complice e creatore.
Il lavoro dell’inatteso non è forse il tuo?
Questo è il cerchio
secco degli inferi.
Se tu potessi, solo un secondo d‘aria. Ti prega
Achille, ma non solo: una fitta moltitudine
ti sospinge, non solo io.
Prometti un secondo soltanto
di sollievo alle ombre».
*
«Io, Elpenore, la vertebra del collo spezzata.
Caddi ubriaco dalla casa di Circe,
non mi cercò nessuno.
Partiste.
Per me non c’era speranza.
Ma partiste,
cancellando il mio nome dai vostri ricordi.
Ora che ti vedo
vorrei chiederti: ricòrdami
con un tumulo. Si sappia dove morii.
Ma ora ti vedo, ora sputo per terra.
Da morto, sputo.
Nessun cancellato deve dare segni.
La pietà, o esiste o non è.
Addio. Proseguite.
Io non sono mai partito con voi.
Io non mi sono mai ubriacato.
Io non sono mai caduto dalla casa.
Io non sono mai morto.
Sparite voi al prossimo naufragio,
senza rivedere Itaca,
senza che un segno dica dove siete,
neppure l’orma dell’orso che vi uccise».
*
Chi?
Lestrigoni, Feaci, Ciclope, Circe, Nausicaa?
Mi piacerebbe ricordare.
Ma qui nell’antro i nomi vengono e vanno.
Mormoro
Ifigenia.
Sussurro
cavallo.
E il cuore mi si stringe
della pena che provano i fantasmi
per l’aria mai più respirata.
Ma qui, prima del mio ritorno come re,
fra ombre e odori, nel fresco delle pietre,
un vento segreto
mi carezza la pelle, inatteso universo.
Se arrivassi dove mi aspettano
morrebbe questo vento.
*
Quando ero in mare, lasciavo liberi i pensieri
perché domani potevo non esistere più.
Ma qui odori dolci, aria morbida, anfore colme:
sono quasi felice.
Non avrei voglia che nulla accadesse ancora.
Solo respirare,
l’atto intimo e unico.
Quando l’aria scorre liberamente nelle narici
contagia tutto il corpo che, leggero,
non distingue fra veglia e sonno.
Parlarmi oggi di guerre o congiure
sarebbe offendere le mie orecchie
con una lingua barbara e vuota.
Molti i morti che ricordo, alcuni uccisi da me.
Mi resta addosso un greve odore di sangue.
Nessuna acqua lo lava.
Nudo, sento quell’odore nella pelle e nei muscoli,
come se nulla di me mai lasciasse
i luoghi dove in qualche inutile guerra
è stato versato.
Io, in quelle battaglie,
c’ero.
*
La reggia no.
Preparino l’ennesimo tradimento senza di me.
Otto mesi fa sette guerrieri mi spinsero a partire.
Ricordo le loro ombre sulla testa di lei.
La regina non voleva, osava appena guardarmi.
Non ricordo che quelle ombre.
Lei ha perso nome e senso.
I re sono maschere.
In ogni ora del viaggio,
secondo il suono del vento e la forma delle isole,
mi sono dissolto, mi sono plasmato.
*
Se l’aria che respiro fosse l’aria che respiri
nel folto del bosco non ci sarebbe
universo più vasto e felice
nessun vento sarebbe così alto
fra le erbe della terra nessun soffio
così fresco da invocare labbra e mani vive
le parole come cera calda
modellata nella lingua arcaica dalla pietra fuggita
nuova musica nel palmo delle mani
musica salda nell’antro
se l’aria che respiro fosse l’aria che respiri
armonia tornerebbe, aria celeste
sopra il precipizio,
aria in cui muoversi insieme,
i corpi liberi da inutili vesti,
la mia mano lenta
fra le tue cosce,
Itaca laggiù,
un’ombra.
*
Gettare grida di sgomento: descrivere
le grida, lo sgomento:
essere l’ombra del sole sul muro.
Oggi esserci,
domani tornare ombra o luce o muro.
Ma mentre andavo, isola dopo isola, inutilmente re,
c’era solo mare opaco, nei miei occhi, e niente a dirmi
se la via fosse giusta, se da quelle onde
passasse il mio giusto sapere.
Le nuvole mutano sempre,
non come le pietre, troppo lente a cambiare,
o gli immutabili destini.
Descrivere la vita in piena luce:
noia, sonno, andature.
I paesaggi, nascosti dalla densa e costante nebbia,
rifulgono.
Anche ora, a pochi metri dalla stretta fessura rocciosa,
nell’acqua non vedo mai le onde
ma le mani dei compagni.
*
Mentre ero nella nave
la più interna delle voci
assentiva, vagamente
al mare illimitato.
E io mi chiedevo:
sono strumento dell’acqua?
sono portavoce?
E mi chiedevo ancora:
come trattenre un uomo qui
se non conficcando nelle rocce il suo destino,
limite oscuro di quell’illimitato mare?
*
Per l’ultima volta.
La terra, vicinissima, chiama.
Fine della nave, remi dissolti.
Fine delle rovine.
Erba dell’antro
dove giacerò innominato e muto,
servo delle sue carezze.
Mi respira mi spalanca
chiude fuori dalla grotta
i morti:
siamo nudi, immortali.
*
L’antro, ancora.
Il miele, gli ulivi, un’eco
di navi lontane.
L’abisso si è plasmato
carezza.
Il nero si è fatto
mano viva.
Cosa importa tornare? vendicarsi,
volere cosa? che l’astuto stratega
con la sua lama uccida il nemico
e restauri l’ingiusto universo dove trionfava il suo io?
Meglio il vortice imminente o i profumi dell’antro.
Meglio tornare disarmati,
a mondo dissolto.
*
Tornerò quando ad aspettarmi
non ci saranno sette guerrieri
ma sette ombre e nessuna regina
potrà ricordarmi
o lama di nemico trafiggermi.
Il tempo lentamente toglie terra alla terra,
finché resteranno solo precipizi.
Nessuna nave nel porto.
Nessuna sirena fra le rocce.
Un’aria dolce, rovine di colonne.
Armi sotterrate, ossa, Cariddi.
Tornerò a Itaca
senza dèi senza scie,
senza le dita della ninfa,
senza le sue mani di miele.
Allora regnerò.
Se i vivi varcano la porta dei morti
i morti, varcata quella dei vivi,
sorridono felici.
**
Non voler tornare è la grazia, di Isabella Bignozzi
Sentire il nostro essere che diffonde nelle membra, fino ad allora vertigine inascoltata. Non voler essere determinati, scolpiti nel destino che altri vorrebbero disegnare per noi. Ognuno di noi, se cede, è un morto predestinato.
Nella volta della grotta c’è tutto, dèi e creature mostruose, l’essenza della distillata feroce bellezza. C’è un nuovo cielo di pietra, che tutto conosce e racconta. Che è verità propria e personale. È la vita esterna a essere inverosimile. Movimento nel sogno ovattato, irrealtà che penetra, che modella e soffoca. Ritrovare il proprio segreto e custodirlo, è esattamente questo che c’è nella grotta, e che provoca negli altri concitata ricerca, rabbia, istinto di coercizione. Amare è rispettare il segreto. Lasciar respirare la rosa nella rugiada, non calpestarla, non coglierla. La cosa imperfetta cerca solo definizione nell’amore, questa cosa la penso sempre anch’io. Si diventa belli, negli anni, gli occhi come perle direbbe Wallace Stevens, o Thomas Stearns Eliot, scolpiti dallo sguardo di chi ci ama. O di chi ci lascia respirare, osservando il costato che si solleva, al ritmo del vento. Il mondo è forato, ovunque trafigge e spinge il caos, alle porte dell’antro. Ma nessuno salvare, nessuno uccidere, è il fiore lasciato crescere, non colto, è il sermone del fuoco, è la grazia del vuoto d’intenzione che illumina.
“L’aria marina mi brucerà i polmoni, i climi perduti mi imbruniranno…” diceva Rimbaud, e ogni nostra stagione all’inferno, se ascoltata, ci conduce alla grotta. Sanguinario incanto del ritorno, ognuno a suo modo. Non quello di Agamennone, no. Non ho ucciso né salvato, torno trasparente, torno a me. “Non nella reggia, non in mare aperto. Qui. Sotto una volta. Con questo odore denso e lieve di erbe e d’acqua”. “Vivo scavando buio, disimparando regole vuote”. “Se l’aria che respiro fosse l’aria che respiri…” in fondo l’amore, ombra tra le mani, verità precisissima e assente di tutta la vita, è esattamente questo. La ninfa c’è, poi andrà, mai lontana, mai presente. È così per ognuno, solo le carezze, vere o sognate, risalgono l’istante, sono realtà pulsante, nel punto geometrico dell’estasi, che non ha luogo né dimensione. Inutilmente re, inutilmente regina, così siamo tutti. L’unica verità è nei sussurri di Cassandra, nella stanza in penombra, lontano dagli altari, dai cerchi di fiamme del mègaron. Lontano dalla piana, dalle mura, dalle porte Scee. Nella penombra dei bisbigli, che spolpano le ossa, come Phlebas il fenicio, che dimenticò il profitto e la perdita e fu di nuovo in sé, nelle sottomarine correnti. “Tornerò a Itaca / senza dèi senza scie / senza le dita della ninfa / senza le sue mani di miele, / e allora regnerò”. Questo, per sottrazione, per assenza, il senso della vita.