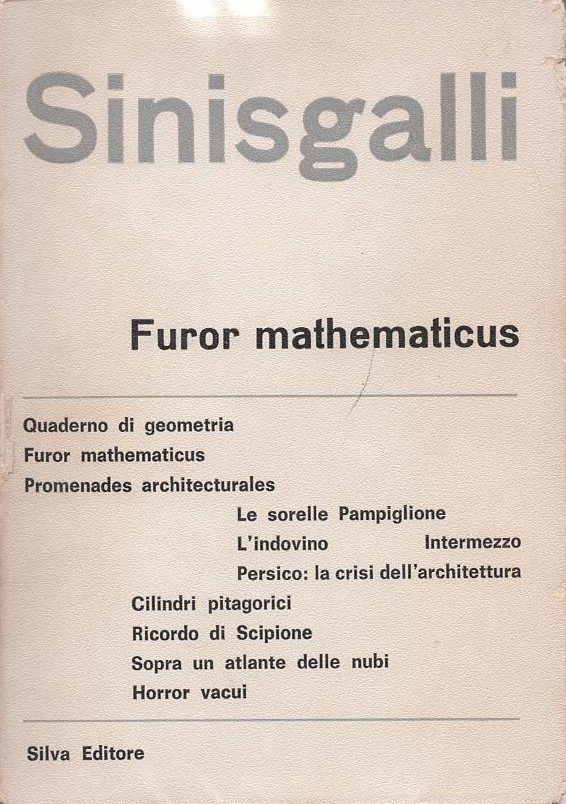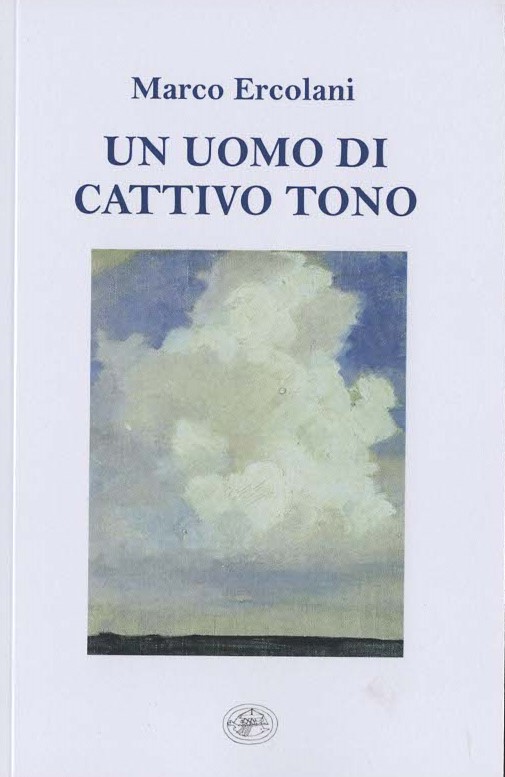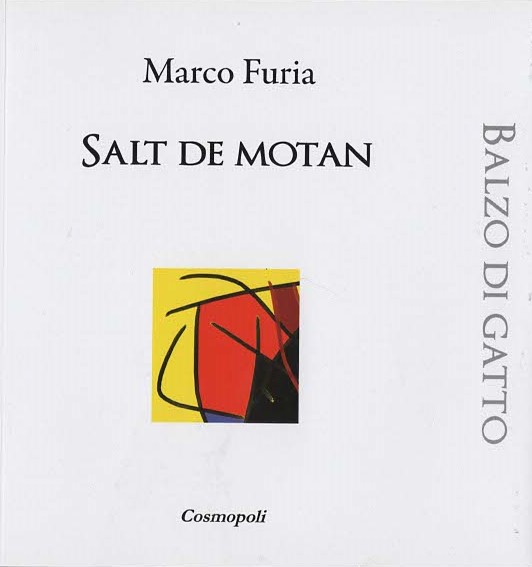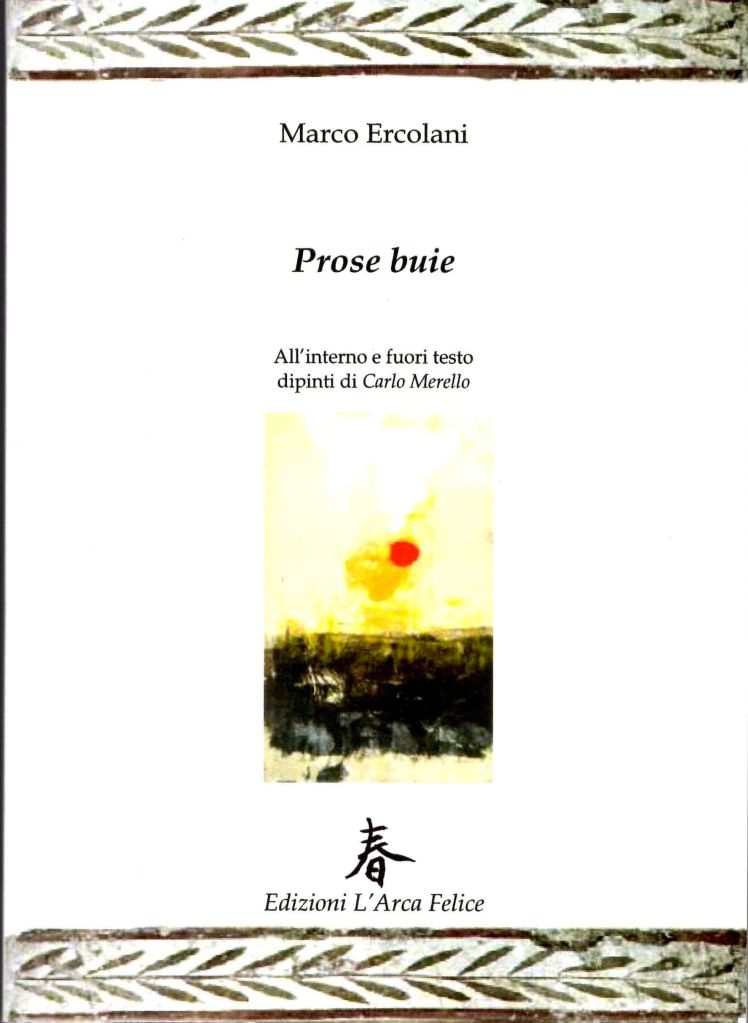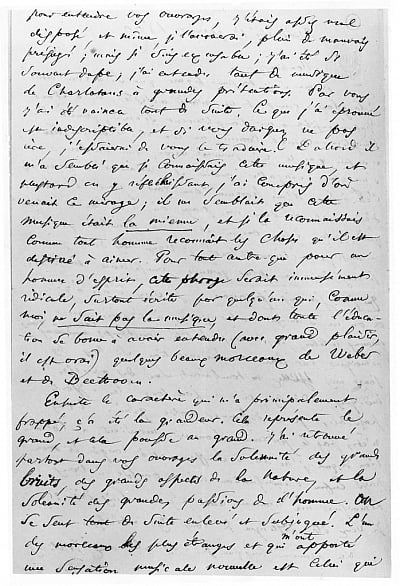*da “Madre della violenza”, La parte arida della pianura, inedito
Ruth
L’esecuzione di Ruth Snyder nel carcere di Sing Sing, 1928, fu ritratta per sempre in una foto in bianco e nero. L’orrore della pena di morte accentuato dall’effetto mosso. La morte ritratta e sbattuta in prima pagina sui giornali il giorno successivo all’esecuzione. Per Robert Green Elliot, boia della sedia elettrica, fu la prima esecuzione di una donna attraverso il congegno che aveva inventato.
Ruth Snyder insieme al suo amante uccise il marito con il quale condivideva un matrimonio infelice. Ruth ebbe un’infanzia difficile, dove la difficoltà di essere figli di una coppia di recente immigrazione negli Usa si incrocia con una salute tormentata dalle malattie e dai ricoveri ospedalieri. Ma è la sua bellezza a fare da contraltare alle sue difficoltà. Così come l’attrazione fatale verso la mondanità degli anni ruggenti, irresistibile ai più affamati di vita e di riscatto sociale.

**
Robert
Vivo i giorni nella pace del mio giardino,
lo sguardo a ritroso,
le stimmate nei palmi della mia storia
Godo di buona salute, non prendo peso
malgrado il carico che mi porto alle spalle
Mi si rinfaccia di essere stato un boia,
un’accusa infame per un elettricista
che ha avuto un compito ingrato:
inventare un modo nuovo
per far morire
Sono sempre stato un uomo mite,
rispettoso della vita, ho ossequiato
le esecuzioni con l’umiltà dell’argine
che opera solo quando il fiume straripa
Tutti sappiamo che dal giardino di Dio
nessuno può cogliere la mela
senza cambiarne il nesso,
il sapore della parola, e nessuno
si sorprenda se dentro le viscere
il frutto poi diventi il male
**
Ruth
Sono nata a New York il 27 marzo del 1895
e morta sulla sedia elettrica il 12 gennaio del 1928,
a 33 anni come ogni cristo sulla croce
È vero che ho ucciso, ma la vita chiamava
la bellezza sacrificata sull’altare
di una unione fallita,
e io amavo quegli anni di possibilità
e spensieratezza, carezze lenitive
sul mio corpo pieno di ferite,
la notte curate a jazz, a charleston
e amore carnale, ultimo baluardo
di un mondo proibito
Ho cercato di sfuggire alla stretta di un destino,
ma non ho saputo assaporarne la colpa,
la misura di un gusto che ubriaca e uccide
Ho dato al mondo una figlia,
trascinato un altro uomo nel delitto,
non ho saputo tenere il tempo
di un ballo che accelerava
in frenesia i passi
**
Robert Green Elliott ha eseguito 387 condanne a morte tra le quali quella di Sacco e Vanzetti, quest’ultimo un pescivendolo analfabeta che nei sette anni di carcere aveva letto e studiato. Prima dell’esecuzione aveva lasciato detto al cappellano del carcere che no, non era giusto mettere allo stesso piano Cristo e due poveri immigrati anarchici italiani.
“La vita di un buon calzolaio e di un povero pescivendolo sono poca cosa, togliercela è tutto ciò che questa società ingiusta può fare. Quest’ultimo momento appartiene a noi, padre, soltanto a noi due. Quest’agonia è il nostro trionfo”.
*
Robert
2000 volt per 3 secondi
500 per il resto del primo minuto
ripetere l’operazione per tre volte
e poi più niente
Alto voltaggio e basso voltaggio
una sequenza necessaria per rendere
la vittima incosciente
e poi bruciarla dentro, senza ustioni,
un lavoro pulito
Porto sempre con me gli elettrodi
e il casco da football
da far indossare al condannato
L’estetica della morte
è un dettaglio che poco importa
per un semplice artigiano
La sera tornavo a casa,
nell’altrove del giardino
*
Robert
Mentre due guardie si occupavano di legarla e un’altra le collocava l’elettrodo sulla caviglia destra, io stesso, dopo averle sistemato delicatamente i capelli dietro al collo, le applicai in modo corretto spugna e calotta metallica sulla fronte. Impegnato in quell’operazione, la sentii sussurrare:
– Sono innocente – poi, con voce più chiara e distinta:
– Padre, perdona loro, perché non sanno cosa fanno.
Collocandole per ultimo la maschera sul viso, udii un’ultima, toccante supplica:
– Gesù, abbi pietà – continuando a singhiozzare.
Forse senza rendermene conto, le bisbigliai qualcosa:
– Tranquilla Ruth, ci vorrà un attimo. Perdonami anche tu. Addio.
Da Agent of Death New York – E. P. Dutton & Co. Inc. 1940
**
Ruth
Adesso toccami Dio, nel perdono
con l’energia della luce
che attraversi il mio corpo,
schiantando le vene
Guardami Gesù sulla tua croce,
mentre tremo prima che la tensione
elettrica fluisca nel sangue
Guarda la mia schiena, un sussulto
m’inarca sulla sedia nel distacco
atroce tra corpo e anima
Torno a voi, bambina indocile
che a piedi nudi ha lasciato
impronte lievi
sulla neve del tempo
C’è questo calore da restituirvi,
la materia morta, questo sole interno
che ora non pulsa, destino di una stella
che tutto illumina e brucia
**
Nino Iacovella è nato a Guardiagrele nel 1968.. La sua ultima opera in versi è “La linea Gustav”, Il Leggio Editore, 2019. È tra gli ideatori e redattori del litblog “Perigeion – un atto di poesia”.