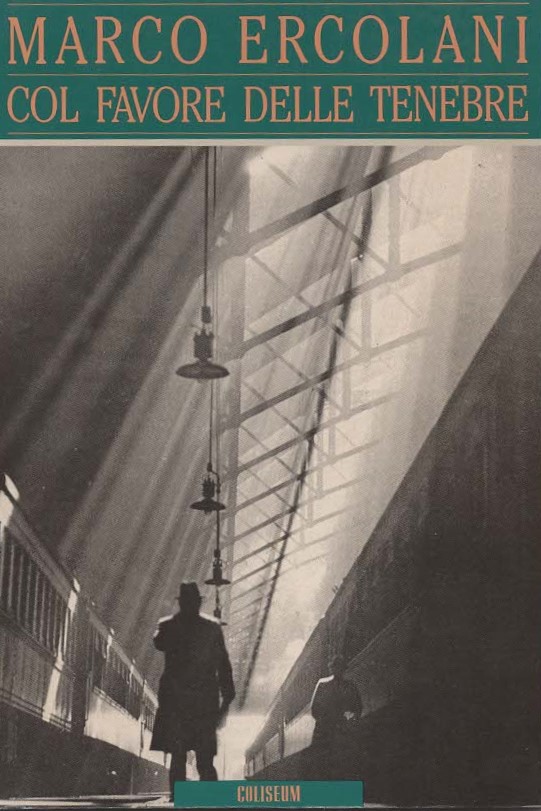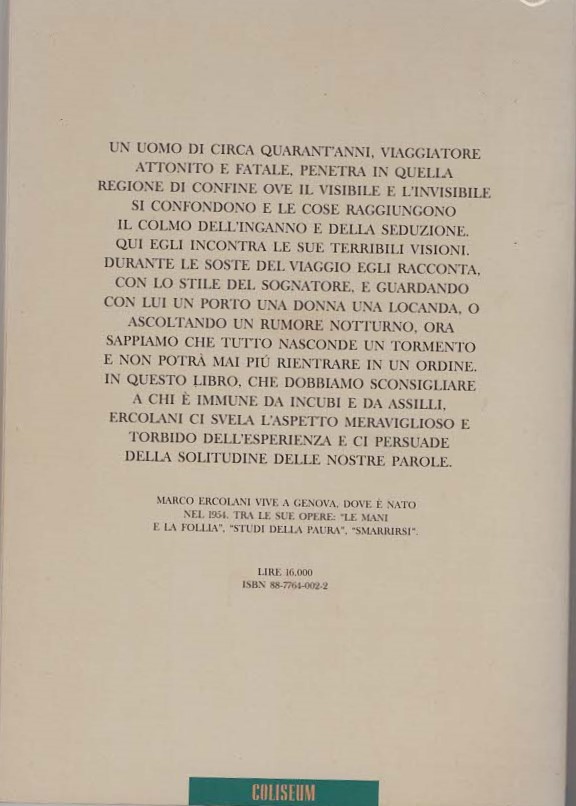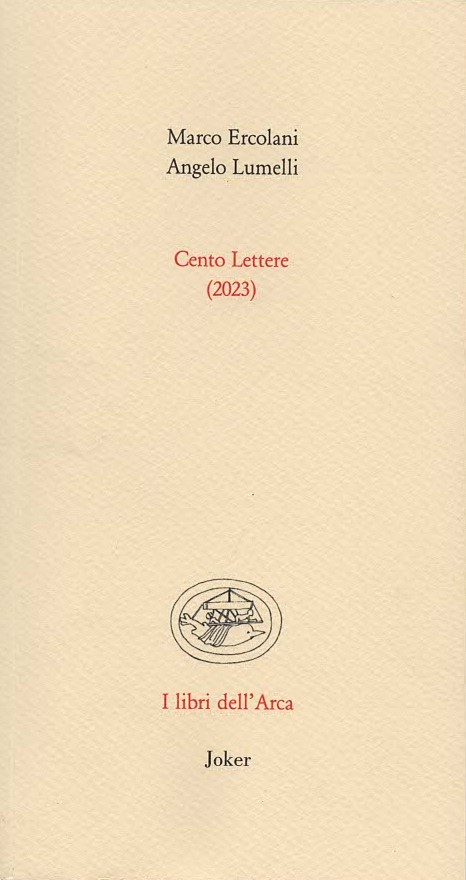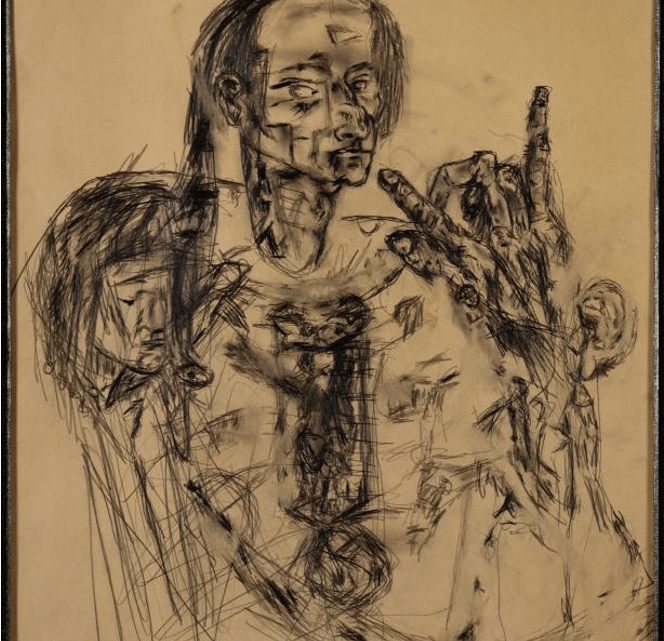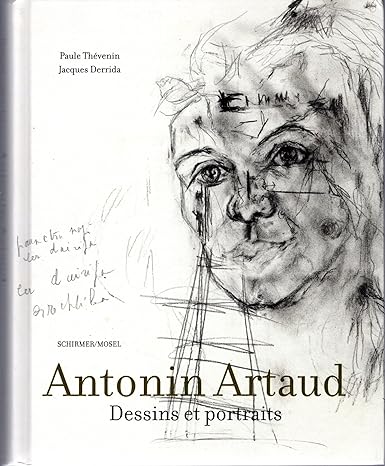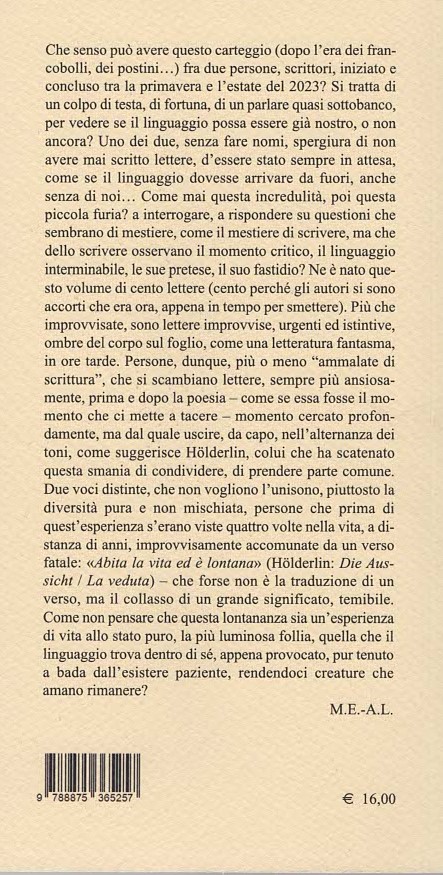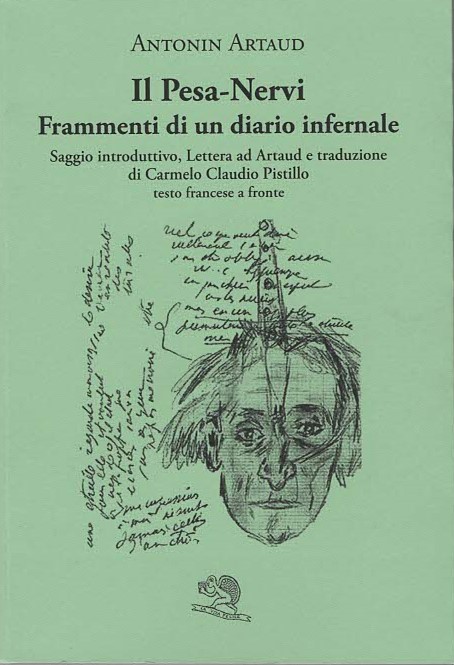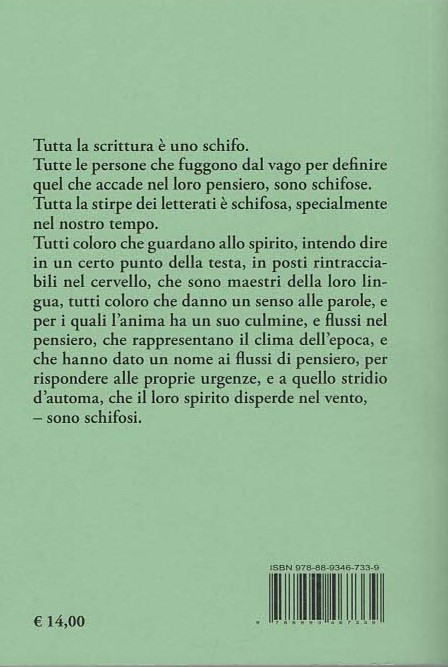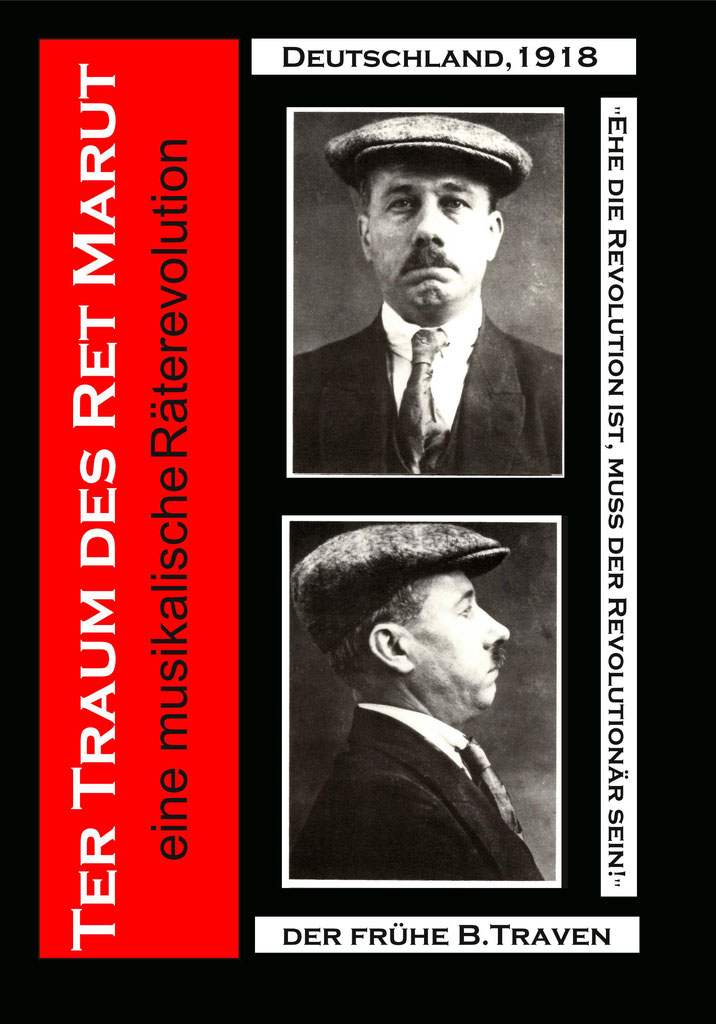6.
la lengua barbaglia e no sa che parlare
Sulla questione della povertà e dell’insufficienza del linguaggio quando si tratta d’amore, mi ero rassegato a non farci caso. Qualche volta ho pensato che fosse un omaggio alla donna amata: essendo lei senza confronto, indicibile, ancor più in caso d’abbandono, quando si portò via tutto il linguaggio in una volta sola. Il misero che ritrova il linguaggio dopo quella disfatta o si accontenta degli avanzi o li trasforma, alchemicamente, in gioielli rutilanti. Jacopo da Lentini l’aveva fatto, Guido Cavalcanti ancora di più – una cupa, scintillante gioielleria, la suprema vestizione dell’anima dolorosa, fodere di luce, cangianti diminutivi.
Io, in quegli anni, pensavo che il linguaggio dovesse bastare e che la poesia, novecentesca, dovesse stare con le spalle al muro, onde non rivolgersi, non voltarsi. E la ragazza con gli occhi obliqui della seduzione? – sarà presente nel non detto!
Poi arrivò Jacopone e il gioco cambiò, complicandosi. Non si trattava del linguaggio debole, ma del linguaggio troppo forte, che non lasciava andare via. In quella estensione senza fine, che più s’attraversava, più ingigantiva, dio era sempre più lontano.
Implorato attraverso il linguaggio, dio aveva preso Jacopone in parola: gli aveva fatto capire che quello era il suo posto, in esilio tra le laude – e che il linguaggio era una porta dipinta, non la porta del paradiso. Il linguaggio, non soddisfatto da alcuno, era dunque, esso, di per sé, la grande insoddisfazione? Jacopone continuerà a stupirsi che dio non sia parola – si lamenterà, griderà: quando iubel è acceso | sì fa l’omo clamare | […] | stridemmo el fa gridare…
La sua dismisura mi toccava direttamente, come l’errore ingenuo, come l’uomo compromesso – ma io avevo deciso di non esclamare, se non sopra un vassoio d’argento, dove la poesia porta il dire ad essere detto – un alto concetto della servitù.
7.
amor, amor, fammi in te transire
Ho sempre pensato, allora – ma perché dovrei cambiare idea proprio adesso’ – che tra parola e silenzio ci fosse una vicinanza indispensabile, un affiorare dell’uno nell’altra, un respirarsi senza timori, infine un oblio benefico, la conservazione della memoria sotto le palpebre, richiamabile, aprendo gli occhi – tutto questo nei tempi felici.
Questo apologo, pudicamente interrotto, segnala la mia difficoltà di allora a riflettere su mistica e linguaggio. La questione si aggravava quando il mistico era anche un poeta, come Jacopone. Non mi angustiava quando parlava per interposte figure – scalcagnate, deturpate dalla vita – né m’impressionava la sua invettiva politica – il linguaggio collerico e forsennato – quelle sue parole corpulente vestite di lana grezza. Mi commuoveva invece – e ancora adesso – il modo con cui Maria apprende, con dettagli sempre più crudeli, ciò che sta accadendo a suo figlio – Donna de Paradiso, |lo tuo figliolo è preso, | Iesù Cristo beato. – esempio ineguagliato di teatro del dolore.
Ne ho avuto prova, all’uscita del cimitero – mia madre si svincolò dal mio braccio, si voltò e corse indietro, terribilmente, verso mio fratello appena sepolto. Ciò che in Jacopone mi causò problemi irrisolti, fu il silenzio mistico, che non andò a buon fine. A un passo da dio, nel momento del grande incontro, invece di “transire” in quell’unione, ecco che l’incontro è rimandato, alzandosi una sconvolta preghiera che, in pratica dice: è troppo presto, non adesso!
Il linguaggio era l’arte di differire, come se fosse una protesta – vanto dell’umanità – contro l’accadere irrevocabile? L’uomo si è tanto spaurito della perfetta attualità, da inventare un giro a vuoto, un finto niente? Come dire che noi abbiamo soprattutto bisogno di mancanza? O declamare il silenzio? – la prima avvisaglia della poesia barocca, ma scritta da colpevoli? Fu allora che mi sembrò di imparare come lingua possa guardare avanti, al di là – retrocedendo.
8.
appresso gir ne lo vedea piangendo
Mentre stavo dalla parte di Guido Cavalcanti, Dante Alighieri cercava di convincermi che la “scuritate” poteva essere illuminata, che l’amore a tu per tu, finale, propagava cerchi nell’universo come un sasso nell’acqua – che la scenografia non avviliva i primi piani, che la poesia non è la fine del linguaggio ma il suo naturale inizio – che per fare poesia ci vuole la non poesia.
Sentivo una tale forza e generosità in questo invito, che a lungo meditai di seguire il consiglio – fantasticamente, avrei voluto mandargli a dire – onde non sembrasse un tradimento, seppure a un suo ex amico.
Con tali pensieri, alternanti, cominciai a pensare ad Amore che piange, più di una volta nel corso della Vita Nuova – perché? La prima volta piange nel sonetto del capitolo III – A ciascun’alma presa e gentil core. Le antologie assicuravano che Amore avesse pianto perché Beatrice sarebbe morta di lì a poco. Se era così, sarei stato fermamente con Cavalcanti.
Le lacrime di Amore, per essere degne, non potevano dipendere da un inconveniente, estraneo, come la morte: doveva essere la presenza a far piangere, non la scomparsa. Le gentili donne di Firenze, con delicata impudenza, avrebbero chiesto a Dante (Cap. XVIII).: “A che fine ami tu questa Donna, poi che tu non puoi sostenere la sua presenza?” – osservazione sbrigativa e maliziosa, molto convincente – brave fiorentine!
La scena del sogno è nota: è il giorno del primo saluto con Beatrice, ella è nuda avvolta in un lenzuolo rosso in braccio ad Amore, che le offre il cuore, vero e carnale, del poeta. Lei lo mangia. Amore appresso gir ne lo vedea piangendo.
È cominciato il viaggio doloroso e ambiguo di trasformazione del desiderio? La Beatrice carnale, nuda, è parte di un disegno misterioso, sconosciuto a noi – ma noto ad Amore – che per questo piange?Amore piange perché sta per trasformare la gioia in giustizia – misericordiosa, come il pensiero di niente?
9.
tu autem non sic | ma tu no
Per fortuna nella Vita Nova, Amore piange una seconda volta, forse la volta buona per estorcere un’interpretazione. Siamo nel capitolo XII e Amore, in sogno e con “bianchissime vestimenta”, parla in latino. Dice, praticamente, è ora che ci togliamo la maschera, riferendosi alle donne dello schermo (“Fili mi, tempus est ut praetermictantur simulacra nostra”). Perché piangi? chiede invece Dante. La risposta di Amore è complicata: io sono come il centro del cerchio e ogni punto della circonferenza è situato ad uguale distanza, ma tu no. | Ego tamquam centrum circuli, cui simili modo se habent circunferentiae partes, tu autem non sic.
La storia del cerchio non è una novità. Jacopone scrive: Amore amor, tu se’ cerchio rotondo (Amor de caritate, perché m’hai sì ferito? – XL). Dante fa finta di non capire, e il pianto di Amore non trova altre spiegazioni. Può mai essere che Amore sia così fragile di nervi da piangere perché Dante non è ancora perfetto come una ruota di bicicletta? Quel pianto, ancora una volta, sembra essere, invece, un pianto di compassione su di sé e sull’universo intero, in quanto il compito della perfetta equidistanza lo priva della precipitazione che lui, Amore, conosce benissimo, un’unità asimmetrica con l’altra creatura, asimmetria che in cielo non è ben vista, gioia specifica e clandestina degli uomini.
Amore piange perché il dono che offre a Dante sarà l’oblio, seppur imperfetto, di una gioia pericolosa, la quale, per diventare salvezza, dovrà trasformare le dense meraviglie, centimetro per centimetro, del corpo amato, in una luce senza tatto. Questo accade nel Paradiso, quando è troppo tardi – quando la luce cancella il corpo, il quale sarà amato di nascosto – nel doppio senso. Speravo – lo spero ancora – che Amore piangesse per questa ragione, che Dante non poteva sottoscrivere in modo esplicito, ma che avrebbe portato nella Vita Nuova uno sconcerto e una nostalgia degni del suo ancora migliore amico Guido Cavalcanti.
10.
amat autem quae osculum petit
A fior di labbra, come il bacio secondo Bernardo da Chiaravalle – non soltanto corpo, non del tutto parola – la poesia affiora, come uno svenimento, un’allucinazione – estasi laica, una bianca pastiglia? La più smaliziata, già matrona, nasconde il silenzio dentro ai gusci di parole… come chi ha imparato il mestiere – noi principianti ci mettevamo le parole in tasca come biglie di vetro colorato, le facevamo passare con la mano, sonanti, cascatelle di suoni, guscio con guscio…
La poesia, in quanto osculum|bacio, attira i mistici e li inganna. La poesia, che fa credere di essere alleata del silenzio, è sempre al di qua di qualcosa – essendo alla fine un atto positivo. Grandi sono i pericoli del linguaggio per un mistico. Colui che. meglio di chiunque ha visto il trucco è stato Meister Eckhart: “…prima che le creature fossero, Dio non era Dio, ma era quello che era” – questo si chiama parlare! – addossarsi alle parole, come in trincea – il silenzio oltre il terrapieno.
Dante ha ideato l’immensità della Divina Commedia per avere un margine? un vasto al di qua? – in pratica una scenografia? – dove il silenzio è parte costituente e controllata, in quanto seme originario della finzione? – era questo lo scopo ultimo dell’arte, controllare il silenzio, avvicinandosi?La massima visione del linguaggio non è una visione mancata? Non era cominciata così con Beatrice? – il giorno del primo incontro, lei nuda sul drappo rosso?
Dante sta sulla parola – addita, puntando il dito – e non so se questo gesto sia l’inizio di tutte le allegorie – allegoria dello stesso additare. La sua attraversata del linguaggio, tuttavia, mi sembrava ispirata dall’osculum|bacio di San Bernardo – così simile a parola, affiorante, contatto di labbra, richiedente un corpo, portato fino in vista del paradiso. Quel bacio è praticato con gli occhi, come tutto ciò che penetra senza toccare – …com’acqua recepe | raggio di luce permanendo unita.
Con il linguaggio si può arrivare fino lì.
11.
quoniam bona ubera tua super vinum
Il bacio delle labbra, ingegnosa unione di corpo e respiro, imminente parola sospesa, non è immagine che esiga il rimedio di un’interpretazione – al culmine del corpo, esso è, pur nostalgicamente, superficie, aspirazione alla beatitudine, contatto senza sottomissione.
I padri della chiesa, allegorizzando, non hanno dovuto inventare granché, come infatti San Bernardo. Non così accade con “i tuoi seni più amabili del vino”, immagine che, d’urgenza, viene interpretata allegoricamente, da Origene in primis, che allora avevo conosciuto soltanto di nome.
L’urgenza dell’allegoria mi lasciava perplesso, essendo essa, palesemente, attivata per disfarsi di quell’immagine, carnale, che lega e trattiene… L’allegoria serve ad allargare la scena del senso, a lasciarlo correre, potremmo dire – come se la caratteristica del senso fosse quella di ricominciare, di allontanarsi, ogni volta.
Alcuni parlano di sviluppo, come del pil – ma io intendevo un senso bisognoso, una figura errante. L’allegoria, patrimonio delle sacre scritture, è in realtà un linguaggio in fuga – dai propri misfatti, dall’insoddisfazione? – linguaggio che, prima o poi, da migrante, capiterà in un’altra patria, dove il senso di partenza si trasforma – come Ulisse nel suo ultimo viaggio, quando i remi verranno interpretati come pale da grano.
Nel mio sincero pensiero di allora, osservavo che l’ampliamento del senso portava, allegoricamente, in una direzione obbligata – che il gioco si stringeva invece di allargarsi, per cui stavo cauto, a volte spazientito e basta! Dante, avevo notato, stava troppo a lungo sulle immagini, troppo vicino, per trascinarle in allegorie, a bella posta e a loro insaputa. Notavo che tutto era di più, grazie a uno stupore costante, a uno sforzo immane – ma non era un altro pensiero: era il suo fallimento dell’ultimo minuto.
A me bastava.
12.
non però qui si pente, ma si ride
Queste parole sono di Folquet, l’unico poeta che Dante mette in paradiso, non si capisce perché. Non mi sono piaciute – cosa c’era da ridere? Dante aveva bisogno di un pentito? di uno guarito dalla poesia? Folquet mi piaceva di più quand’era malato – ai tempi di A vos, midonts – origine della canzone di Jacopo da Lentini. Quella sua antica malattia mi turbò, mi consolò, mi offrì una speranza, non di guarire, ma di ammalarmi esclusivamente, lontano dall’essere positivo, sano per definizione. Folquet, in Paradiso, aveva dimenticato i suoi peccati?
Non così in questo frammento di canzone, tradotto da Luigi Pirandello:
“E pur cantando m’avvien di pensare | quel che m’ingegno cantando obliare; | e per ciò canto, che scordi il dolore | e il mal d’amore; | ma ahimè, più canto e più me ne sovviene, | però che al labro null’altro mi viene | che suon di pene”
In paradiso c’è lui solo – gli altri poeti sono tutti in Purgatorio, legalmente, a causa di peccati generici e tradizionali, pur essendo il loro vero peccato la poesia, come accade a chi viene fermato per eccesso di velocità e si scopre che il bagagliaio è pieno di refurtiva.
Chi non è sistemato in Purgatorio è al Limbo o lasciato perdere. Il poeta è uno che ha trovato una scorciatoia per il perfetto sentire? – uno che gode dei finti arrivi? – un po’ baro? – quasi pro truffis, come direbbe Angela da Foligno? A me piaceva che i poeti non fossero in paradiso, luogo senza significanti, a sentire i raffinati. E Guido Cavalcanti?Non tira un’aria favorevole per lui, dopo della storica lite.
Ai tempi del cuore mangiato e del famoso sonetto le cose stavano così: “A questo sonetto fue risposto da molti…; tra li quali fue risponditore quello che io chiamo primo de li miei amici…E questo fue quasi lo principio de l’amistà tra lui e me…”
Quando Dante scrive la Divina Commedia, Guido Cavalcanti è già morto. Non lo troviamo da nessuna parte – un silenzio che mi sembrava solenne, mai trasformato in una pace da poco.
13.
e sfrigola per fiato che va via
Avevo trovato una nota dalla quale mi sembrava che Dante, in De vulgari eloquentia, a proposito della natura dei versi, usasse il termine “diesis”. La cosa mi incuriosì, come fosse una speranza per qualcosa, essendo il “diesis” un’alterazione, un’anomalia, non si sa mai…
Così cercai il De vulgari eloquentia, in latino con sotto la traduzione. Non trovai ciò che speravo – trovai altro: per esempio che i versi dispari sarebbero più seri dei versi pari, che esistono parole irsute e parole pettinate, che la canzone era il gremium|grembo di ciò che essa dirà – trovai citato due volte Guido Cavalcanti, quando non ci speravo più.
Come succede in gioventù m’innamorai della complessità della canzone, come fosse una difesa contro la libertà chiacchierona. Mi proposi di scrivere canzoni con obblighi tremendi, così che la libertà si rifugiasse, faccia al muro, in un angolo. Ma ciò che più di tutto mi colpì è incredibile: Dante aveva visto come si legano le fascine di legna, preparando prima le torte (con salici flessuosi, con i rami giovani delle lantane…): ”Preparate la legna e le torte, perché è ora di legare le fascine. |” Preparatis fustibus torquibusque ad fascem, nunc fasciandi tempus incumbit. (Cap.VIII)
Mi sono sentito pieno di grazia, di abbondanza e d’infelicità: io avevo un sapere esclusivo e personale, conoscevo come si fanno le torte per legare le fascine, come torcere i rami morbidi, come fare le asole… Ogni parola era individuale come un’esperienza – non sapevo se gioire, se disperare…Fu allora che, per la prima ed ultima volta davanti a una poesia, mi venne una tale emozione da avere voglia di piangere: Dante aveva visto bruciare la legna verde, come me d’inverno, tralci di vite appena potati:
Come d’un stizzo verde c’arso sia | da l’un de’ capi, che dall’altro geme | e cigola per vento che va via. (Inferno, XIII).
Le parole erano persone – erano nate in un posto solo, parole grembo, parole luogo – così felici, disperate.