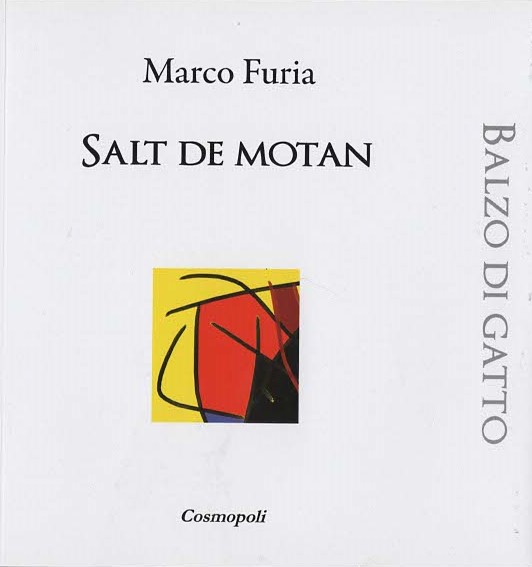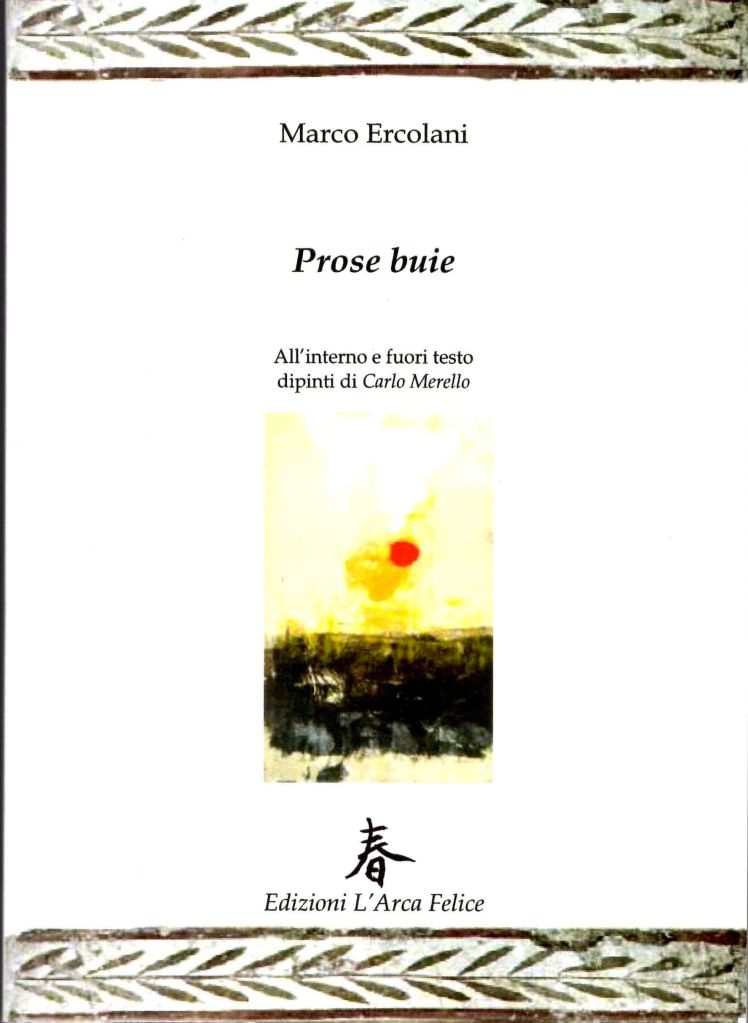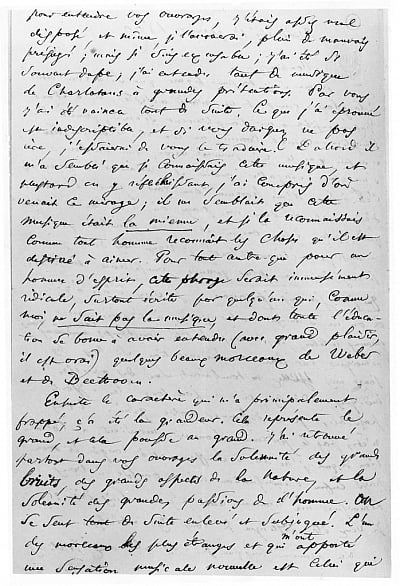Su Marco Ercolani Un uomo di cattivo tono, 2020.
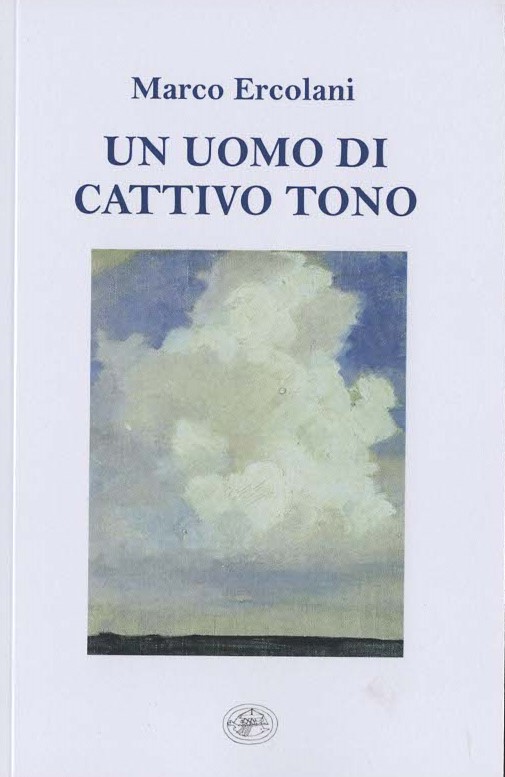
**
Aduso alle riscritture, Marco Ercolani affronta questa volta I quaderni del dottor Čechov. Appunti di vita e letteratura 1891-1904, pubblicati a Mosca nel 1950. Dalle stesse parole di Ercolani scopriamo che ciò che lo ha attratto, nel paradigma della scrittura relativa agli ultimi anni della vita di Čechov, è il suo essere “antisentimentale, crudele, aforistica — pronta a resistere nel nostro tempo come cantiere inattuale e scandaloso di libertà, se per libertà si intende l’inflessibile audacia del pensiero e del cuore”. Il titolo si riferisce al cattivo tono di un Čechov “che non ammette consolazioni ma solo illusioni”. Illudersi è la capacità che ha il sognatore, é un talento prezioso che dispiega il mondo.
Ercolani fa di Čechov il suo progetto di scrittura. E circoscrive una precisa visione della letteratura, come patrimonio comune da cui tutti gli scrittori non si può dire che prendano, quanto effettuino un deposito; letteralmente seminano, poiché l’uguaglianza diviene differenza, rigenerazione. Il nostro autore ripercorre le orme di Čechov; gli sta addosso; vuole penetrare i segreti della sua personalità, quegli stati interni che sono preclusi persino al suo proprietario; spia le sue pagine, mentre lo scrittore russo scrive; tuttavia, è altro quello che ha in mente. Far emergere le secche del silenzio, le cancellature, le possibili cose che eppure non sono state dette. Non sarà un completare l’affresco, né mettere le tessere di un puzzle al loro posto. La questione è che un autore non è mai ciò che è, ma diviene ciò che è grazie a qualcos’altro, a qualcun altro. La differenza pone l’identità di sé con sé tramite uno scarto, uno sdoppiamento: “Ricopiando certe parole altrui renderle nostre per la prima volta”.
Lo stato interno é quella matassa i cui fili indistinguibili sono quegli impulsi, passioni, inclinazioni, intuizioni, i quali formano un fondo indeterminato che è l’inconscio nella sua identità e unità. Con lo stato interno il soggetto costruisce il mondo oggettivo che s’invera nei doveri giuridici e morali tramite la ragione. Per Hegel ragione e pulsione non si oppongono, ma si totalizzano informandosi nell’individualità. In questo senso, l’audacia del pensiero e del cuore che Ercolani riscontra in Čechov sembra collimare con la visione filosofica hegeliana che vuole lo spirito soggettivo, immerso nella finitezza, in balia di altro, ma che ciò nonostante possiede un movimento di inveramento per mezzo dell’inconscio, che è psichico e pulsionale ma anche sociale e storico. Per contro, questa totalità organica si esprime sempre frammentariamente: non tutto emerge. In tali lacune, s’inserisce, appunto, Ercolani, il quale aggiunge il suo tessuto smagliato a quello dello scrittore russo. Non si perde trasparenza in questa sovrapposizione, ma si estende la parte di copertura, l’estensione dell’emerso.
Il rapporto con la verità è sempre presente, ma mai raggiunto; sicuramente intravisto: “Vorrei imporre silenzio al mio cuore. Ho sempre paura di non aver scritto altro che un sospiro mentre cercavo una verità”. D’altronde solo un’idea assoluta è vera, mentre l’arte ne è la presentazione nel sensibile. Se Ercolani afferma che “La bellezza e l’eternità esistono, ma forse non per noi” credo che alluda appunto all’assoluto non raggiungibile, di cui si vedono, però, le ombre sulle pareti della caverna.
Quel movimento incessante, che si svolge in siffatta scrittura, attesta di questa unione sempre differita. Il corpo ha una valenza possente nel testo, con i colpi di tosse, la febbre, le emozioni; chiede continuamente attenzione. Ercolani lo ausculta con grandissima cura e ne registra i sommovimenti, effettuando la stesura di “un racconto ineluttabile. Che sembra non essere stato scritto da nessuno, ma che doveva essere scritto. “Ineluttabile”. Nel dialogo a distanza fra scrittori, la lontananza non diviene estraneità ma annuncia l’impersonalità del soggetto.
Naturalmente la riflessione sulle parole altrui, che attraversando l’autore lo fanno passare da uno stato passivo ad uno attivo (ma questa suddivisione la tengo solo perché utile a comprendere il processo che avviene nel passaggio dal primo al secondo autore, cioè dalla lettura alla scrittura), gli apre, al contempo, le porte sul dominio della dimensione stilistica: “Alcuni capolavori, se irrealizzati, sconvolgono. Immagino gli appunti preparatori, le frasi accennate, gli schizzi, e non riesco a capire cosa sarebbe potuto accadere. In quel non capire comincio lentamente, attraverso mille dubbi, a ripensare forme e stili”. È in gioco la flessibilità del dire, che non deve mai irrigidirsi in concetto isolato, slegato. Deve piuttosto come fuggire di lato, restare in sospeso. Aperto.
(2020)