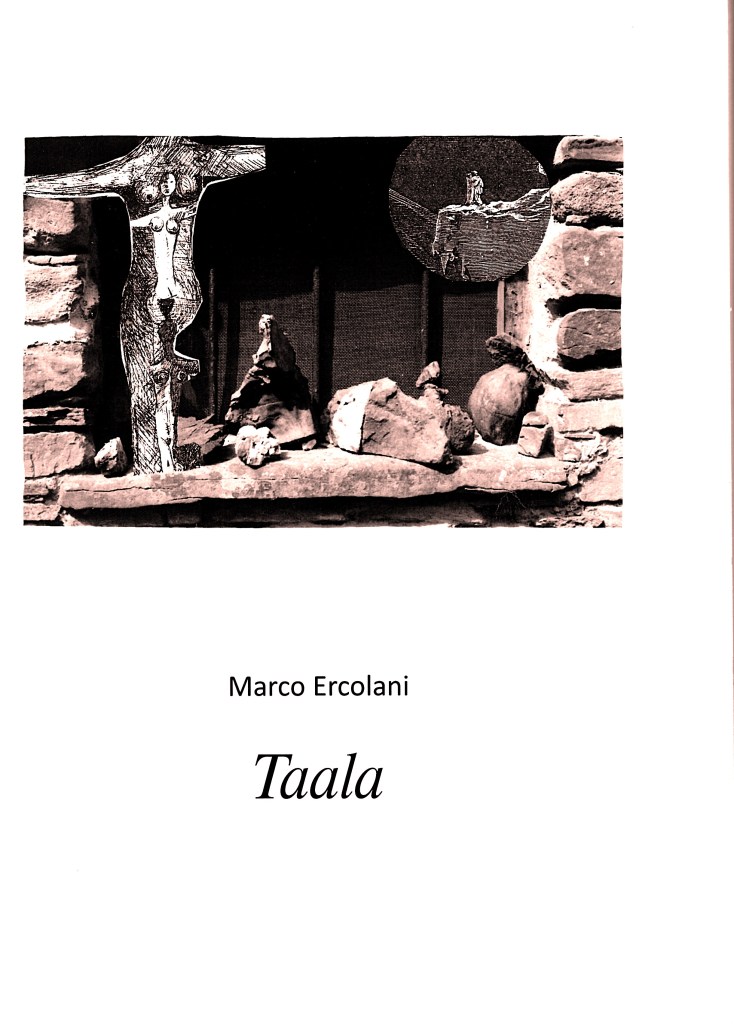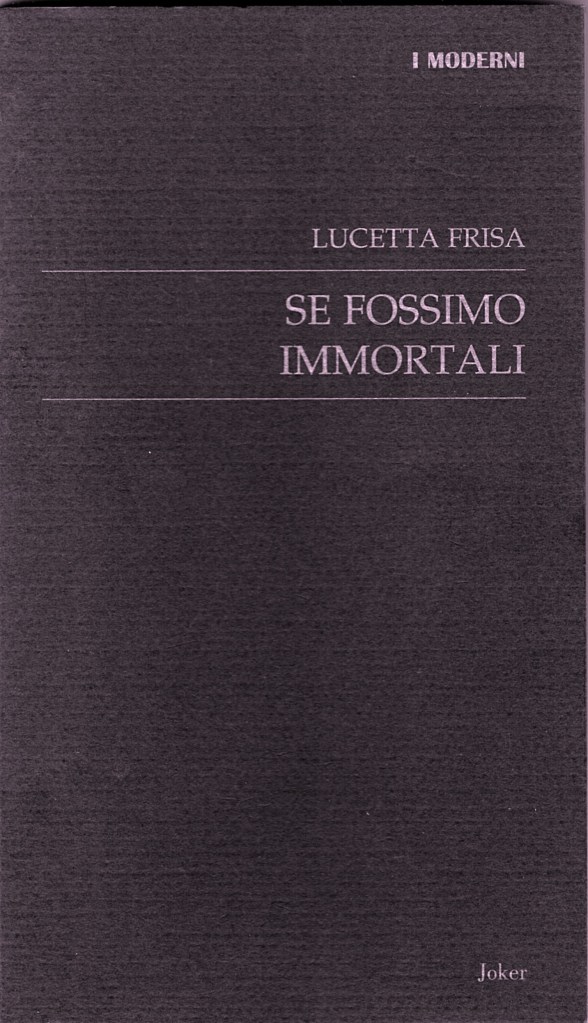Note su Strange way of life di Almodòvar

Ethan Hawke e Pedro Pascal in Strange way of life di Pedro Almodovàr
**
Lo sgangherato cortometraggio western di Pedro Almodòvar racchiude in mezz’ora la poetica del grande regista, il cui cinema è da decenni elevazione del dialogo (financo nell’ultimo La stanza accanto) a cuore pulsante del testo filmico, in quanto detonatore e deterrente di emozioni. In Tutto su mia madre,lo scavo nel passato della luttuosa protagonista avveniva tramite gli scambi di battute con le donne che ne avevano segnato l’esistenza. Lo stesso accadeva nel felliniano Dolor y gloria, dove il rapporto tra Banderas e l’ex attore feticcio avveniva tramite la rievocazione verbale, così come quello tra il protagonista e la vecchia fiamma. Un altro racconto di vecchie fiamme è il corto Strange way of life. Vecchie fiamme, ritorni, nostalgie e futuri possibili esautorati dal tempo.
È di verbo e fragilità maschile che Almodòvar connota il western, un genere che più che mai oggigiorno può avere qualcosa da dire. L’evirazione simbolica, la diseducazione che porta alle tragedie e il turbamento del maschio erano al centro anche dell’altro western atipico, quello di Jacques Audiard, I fratelli Sisters. Almodòvar compie un’operazione simile a quella del francese. Raccoglie le ceneri del western classico e, capovolgendo gli archetipi, immette nella cornice, appunto, del western un dramma del sentimento, quasi da camera per via dei pochi interni utilizzati e dell’indugio sui suddetti.
Il maschio à la Clint Eastwood è una chimera. Gli occhi stretti, i delta di rughe, la prontezza nello sfoderare la pistola. Sono, queste, caratteristiche di un maschio mummificato. Il maschio di Almodòvar è franto fin dal primo respiro del testo, quando vediamo Pedro Pascal che, per – scopriremo – acciacchi alla schiena, arranca col suo cavallo in una prateria dove la profondità di campo è mantenuta quasi sempre altissima, sicché gli sfondi sono tutti perfettamente a fuoco. Il maschio che il regista ci presenta si affatica – ironia e visione autoriale – nell’agito che più dovrebbe essere suo proprio: il cavalcare. Cos’altro fa un cowboy?
Padro Pascal interpreta Silva, che dopo venticinque anni si presenta in una cittadina presso la frontiera col Messico nella quale lo sceriffo, un altrettanto distrutto Ethan Hawke, si sta occupando dell’omicidio di una donna.
Pascal e Hawke sono stati amanti, venticinque anni fa, per soli due mesi. Ma ricordano il tempo trascorso a godere l’uno dell’altro. Più Pascal che Hawke, il quale spesso è inquisitorio e chiede al primo se non stia mentendo, quale sia il vero motivo della visita. La genialità narrativa di Almodòvar si coglie retrospettivamente, in Strange way of life. Perché nel momento in cui, al tavolo riccamente imbandito dello sceriffo Jake, i due vecchi amanti consumano una cena con “stoviglie color nostalgia”, entrambi sanno la verità, il motivo vero della visita di Silva dopo un quarto di secolo. Eppure, Almodòvar differisce il disvelamento per indugiare sui due corpi che, ritrovandosi, ritrovano l’uno la carne dell’altro. (Strepitosa idea di regia quella di inquadrare il didietro di Pedro Pascal, coperto dai pantaloni, per poi, con un morbido stacco di montaggio, riproporre la stessa figura ma nuda, momento postcoitale.)
Silva è tenero; Jake è diffidente. Silva parla di quei due mesi come se fossero stati gli unici due mesi che abbia veramente vissuto; Jake dice di essi che sono stati follia di due ventenni, qualcosa da dimenticare, qualcosa di irrilevante. E si scosta scontroso, Jake, quando Silva gli avvolge attorno al corpo l’asciugamano dopo che è riemerso dalla vasca da bagno.
Il primo quarto d’ora del cortometraggio presenta la svolta: la donna assassinata è la vedova del fratello di Jake, che aveva un rapporto violento con il figlio di Silva. Ecco perché Silva è lì. I due vecchi amanti litigano: Silva è accorso proprio ora, nonostante abbia avuto venticinque anni per porgere visita a Jake; è chiaro che sia lì per perorare la causa del criminale suo figlio. Nega, Silva, che dice: Volevo vederti. Ma Jake è senza cuore, ha sempre voluto solo scopare. Quando Silva gli rimprovera di non aver mai amato nessuno, Jake, in un raptus, punta la pistola addosso a Pedro Pascal.
La domanda si radica nello spettatore; sempre più ambiguo è Silva. Che poi vediamo raggiungere la casa dove alloggia il figlio Joe. Gli dà dei soldi, che scappi, prenda il suo cavallo, non c’è tempo, Jake sta arrivando. E arriva in tempo per uno stallo. Jake punta la pistola contro Joe, e viceversa, mentre Silva, che ha imbracciato il fucile, dirige la mira su Ethan Hawke. Joe viene fatto montare in sella, ma lo sceriffo Jake non ci sta, carica il colpo ma viene ferito da un proiettile proveniente dal fucile di Silva.
È la sola scena d’azione del corto. Ma, di nuovo, non è il western che avrebbe girato Leone o la citazione di violenza estetizzata di Tarantino; è la tragedia melodrammatica, e lo stallo è quello dei sentimenti, non delle azioni. La pistola, la fondina, il cavallo, la sabbia e la stella da sceriffo sono le maschere mortuarie di un genere che sta venendo resuscitato, ma con una necessaria trasvalutazione.
E viene confermato l’impegno (anche politico) nelle ultime scene, quando Silva si prende cura del caro Jake, medicando la ferita, bendandolo. Il figlio, Silva l’ha messo in salvo, e nessuno darà credito a una denuncia di Jake: chi crederebbe che Silva gli abbia sparato solo per poi curarlo? Il proiettile, fortunatamente, è passato da parte a parte; andrà tutto bene.
Ci sono due momenti in cui il western sentimentale di Almodòvar raggiunge perfetta sintesi formale. Il primo, collocato circa a metà, è il flashback. Ethan Hawke e Pedro Pascal vengono mostrati accanto ai loro cavalli, con il fuoco acceso. Lo spazio è lo stesso, sembrano vicini, ma la logica narrativa ci dice che, in realtà, li separano miglia. Ma le analogie spaziali, i dettagli similari e il flashback dei due giovani nella loro prima esperienza sessuale ci parla di una connessione, ora turbata ora riattivata. Tutto nel silenzio, fatta eccezione per il crepitio del breve falò, e per i gemiti dei due giovani amanti.
L’altro momento è il finale. Jake è ormai guarito e Silva ricorda che Jake, all’epoca, prima di lasciarlo per prendersi cura di suo padre, rompendo la relazione, domandò, ironicamente, che mai potessero fare due uomini in un ranch, cosa che Silva sognava per entrambi. E Silva, dice, ora sa rispondere: Prendersi cura l’uno dell’altro, proteggersi, farsi compagnia.
E il cortometraggio si conclude con la nostalgia e con la consapevolezza che la vita è stata, tutto sommato, un fallimento, durante il quale le varie circostanze contingenti, le cose della vita, ciò che è accaduto loro come a tutti gli altri (i figli, lo status sociale, il tempo), ha fatto sbiadire la purezza della scultura che solo in un momento non inscritto nella catena cronologica, ma evenemenziale, quasi aiòn stoico, erano stati in grado di costruire: un pulito amore che i cavalli, nelle loro corse, hanno spazzato via come polvere.
*Marco Sbrana (26/03/2003) studia scrittura creativa presso la scuola Mohole, a Milano, dov’è nato. È nella redazione di Zona di disagio e Evidenzialibri. Ha scritto alcuni articoli per il blog “Scritture” di Marco Ercolani. Tiene la rubrica domenicale sul cinema per Odissea di Angelo Gaccione. Ha scritto un romanzo e una raccolta di poesie, finora inediti. Cura il blog di critica e cultura cinematografica Carrello a seguire (carrelloaseguire.com)