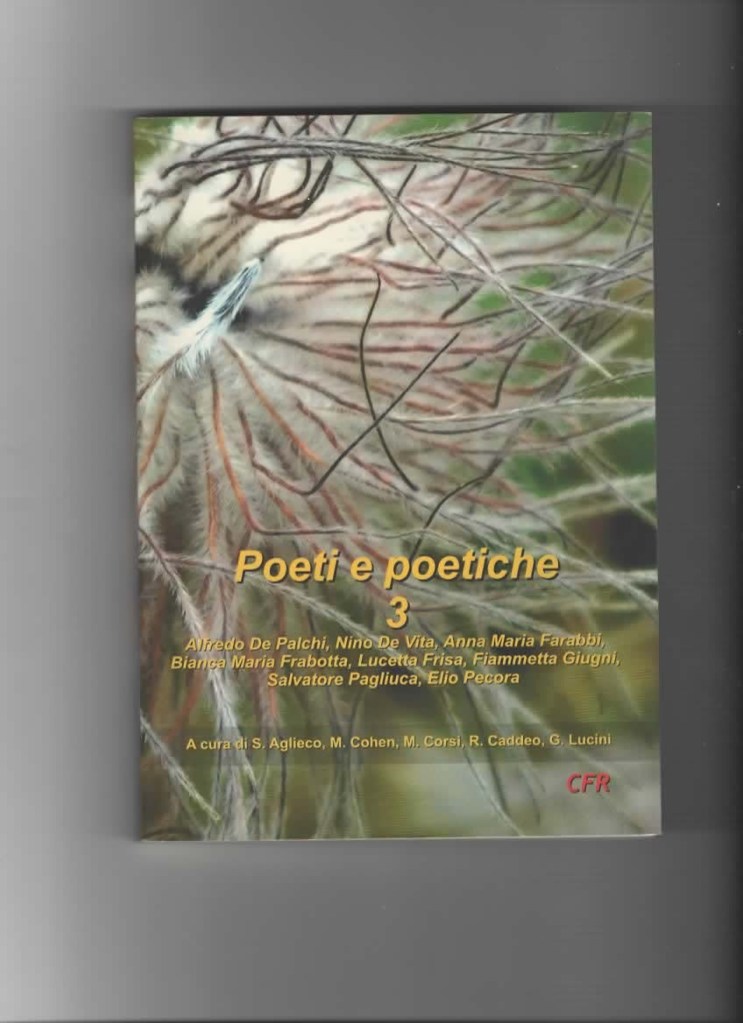Sulla riva di mondi senza fine
i bambini giocano. Tagore
*
Là dove guardano i bambini è sepolto un segreto. Walter Benjamin
*

Nicolas De Staël
**
1.
Le mie parole verso di te vanno verso il giorno
non so cosa vogliono né cosa diranno
ma qualcosa in fondo alla notte trema:
dal sangue alla voce, dalla voce a te. L.F.
2.
Il mio giorno non è luminoso: si compone di frammenti di tenebre che cercano forma di parole – frasi che salgono dal buio, vocali, consonanti, sillabe di nulla; e con te, di te, respirano progettano risuonano… M.E.
3.
Sono la tua illusione: esisti con me.
Sei la mia illusione: con te so di esistere.
Il corpo delle parole è fragile ma tenace,
il mio corpo si inombra mentre la parola schiarisce.
Sogno perché qualcosa resti del mio respiro –
il mio con il tuo, qui, ora,
e nell’assenza.
4.
Parli di respiro e di sogni a un malinconico; a chi, in questo momento, vorrebbe ritrarsi, nascondersi, tacere. Non avere più nessuna forza, nessuna forma. È faticoso amare ed essere amati quando il mondo rispecchia stupidità, corruzioni, menzogne. Non resta che una salvezza: immaginare la terra come il cortile polveroso dove il bambino, ignaro di lutti e abbandoni, lancia la palla con gioia alla compagna stupita.
5.
Se giocare è vivere giocare è cosa seria
se parlare è giocare giochiamo con la vita
il gioco si fa di giorno su ciò che la notte insegna
e nella notte l’amore trova per la luce sillabe
e atti interi, in un solo discorso.
6.
Ma, mentre parliamo, la frase si spezza nei timbri delle nostre voci. La parola esiste nel palato, nella gola, nelle corde vocali, nelle labbra che la articolano. Solo gli sciocchi inventano teorie: la parola è mucosa, carne, tessuto, anche quando è segno astratto nelle pagine di un libro, anche quando diventa scrittura,
7.
Teoria, teorein, vedere: gli sciocchi sanno vedere?
Dopo il suono la vista è seconda finzione?
Tutto ciò che viene dopo la carne inventa
teorie e follie per essere.
8.
Come se il poeta, dopo aver amato la sonorità dei nomi e le lusinghe del linguaggio, diventasse all’improvviso sordo e cieco – puro gesto, puro nulla, al di sotto della lingua, nell’angoscia fisica della mancanza di sé, né corpo né spirito né carne né aria…
9.
Incerti tra due parole:
una va verso l’altro, illusa di fuggire;
l’altra scende tornando, alla madre.
Due abissi: tellurico e celeste.
Dove siamo noi?
10.
Nell’onda incessante, che sulla riva crea rocce porti parole…
11.
Incerti fra due suoni:
di animale nel buio ignaro di abissi e sogni,
dell’angelo senza radici che crede di cantare,
ebbro di sé e di nuvole.
12.
Torna dal suono all’immagine, dalla parola che scorre nell’aria al segno impresso nella terra. Fuggi la gioia del nome per andare nel luogo dove i contrari convivono, assente l’uomo. Leggere e scrivere, allora, diventano avventure del futuro.
13
Leggere nei libri come dentro anime
-viaggia e pellegrinaggi tra una virgola e l’altra-
tornando ogni volta al silenzio
dove oriente e occidente si raggiungono-
pronti ancora a perdere e ritrovare il senso.
14.
Troppe volte, leggendo, sono stato più vivo che nei volti, nei silenzi, nei rumori che mi circondano. La realtà, fuori di me, è solida e fredda. Ma ferita, nutrita, svelata dai suoni della parola, ricomincia a bruciare.
15.
Una parola – ed ecco tornato il senno
e il senso, l’unico, e intorno il freddo.
Una parola: cerchiamola tutta la vita –
quel soffio è mio e tuo
figlio fuori dalla bocca.
16.
Mancare alla casa, essere fuori dal porto, respirare insieme: è questa la lingua, la parola che sgorga dalle labbra. Ma se esitasse a nascere?
17.
Si costruiscono navi in terraferma.
Il tempo fa il resto – fluttuano
colano a picco non tornano più.
Dal fondo dei mari riaffiorano
in forme più dissolte, ignote
a chi guarda.
18.
La casa non nutre sempre il cieco che vi si nasconde. Un giorno egli esce e guarda il sole: in quel momento sa che la sua veggenza e la sua solitudine erano solo maschere per allontanare quella luce, quel cibo.
19.
questo pane da masticare coi denti della scrittura
è aspro ma impedisce di soffocare
se parli e scrivi ti ascolto e ti leggo
–abisso e infinito spingono, violenti, la porta–
apriamo e chiudiamo poco e piano
misurando il vortice.
20.
Ogni naufragio è essere naufraghi. Il punto della nave che scegliamo è il nostro vortice. Scafo fragile, onda forte. Si inabisserà, al prossimo scoglio, ma sarà quello scoglio il luogo della voce, il seme della parola, gli occhi che si guardano, prima di colare a picco con mani, corpo, terrore…
21.
La tua malinconia mi insegna la realtà-
armi spuntate, vanità degli atti-
incrina l’urlo ingenuo fra me e le stelle
fra me e gli altri e il dolore:
insegna pazienza per il mio nulla.
22.
Scrivere, ma perché? Nessun occhio ci vede. Siamo noi a fare arte. Il tempo scorre accanto a noi, non si cura di noi. Perché queste parole imperfette vogliono che le annodiamo con perfetta passione? Ma basterebbe uno sguardo casuale, un’occasione, un incidente, e saremo letti, ascoltati, voluti. Resisteremo, anche se non sappiamo quando e dove.
23.
Parli per te per me – non importano gli altri
tu il mio visibile io il tuo limpido specchio:
gli altri appartengono a un tempo offuscato
patinato rumoroso: gli altri sono fuori tempo.
24.
La sensazione più forte da cui sono stato sempre assalito è quella di vivere lontano dalla terra, nemico del tempo umano, perso in una mite follia. Tu mi restituisci alla gioia di questa follia: me la confermi necessaria e giusta; fai, di me, un essere che crea il suo tempo ogni giorno, con dolcezza e con pietà, tra equilibri e tempeste.
25.
Con te posso restare in silenzio
leggere senza perdermi nel deserto delle frasi
nominare i confini e il doppio delle immagini
scrivere lasciando il mio corpo a conficcarsi in te:
mi rendi sempre ciò che è mio
tornando a parlare.
26.
Il fiore, chiuso da petali visibili, nasconde il suo segreto; la chiarezza del canto, invece, irrompe, manifesta, tradisce. Dentro di noi c’è, prima della lingua, la parola possibile, che inventa la profondità del mondo e la notte delle cose. Silenzio e voce si guardano, non si confondono.
27.
Giochiamo sulla riva
nella luce che muta nel discorso che avanza.
Parole e lacrime scorrono avanti.
Non voltiamoci: sabbia, qualche sasso tra mani e fogli
trattengono ancora dolore e ombre.
Con i nostri giochi d’acqua e d’aria
restiamo bambini parlando fino a notte.
30/11/1990-7/12/1990

Henri Michaux