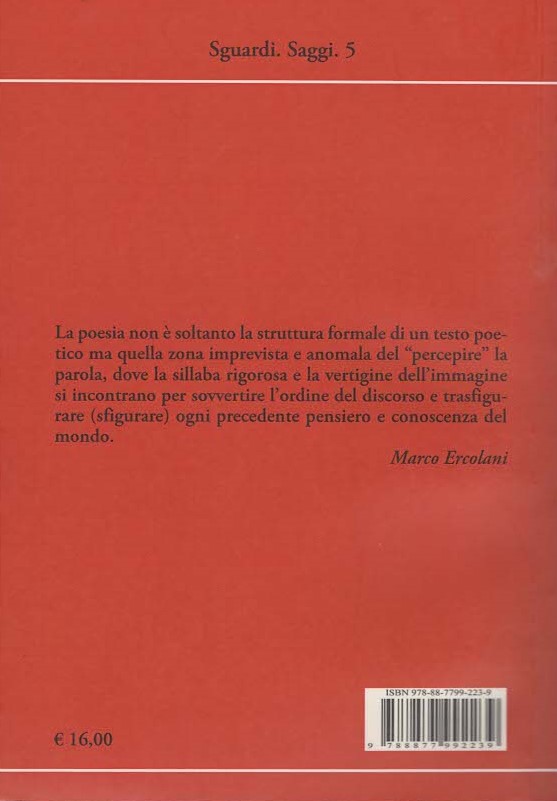Nella collana Sguardi. Saggi usciva, nel giugno del 2008, il mio Vertigine e misura. Appunti sulla poesia contemporanea, con una nota critica di Gabriela Fantato. Questo post, il numero 300 di Scritture, è dedicato a Gabriela.
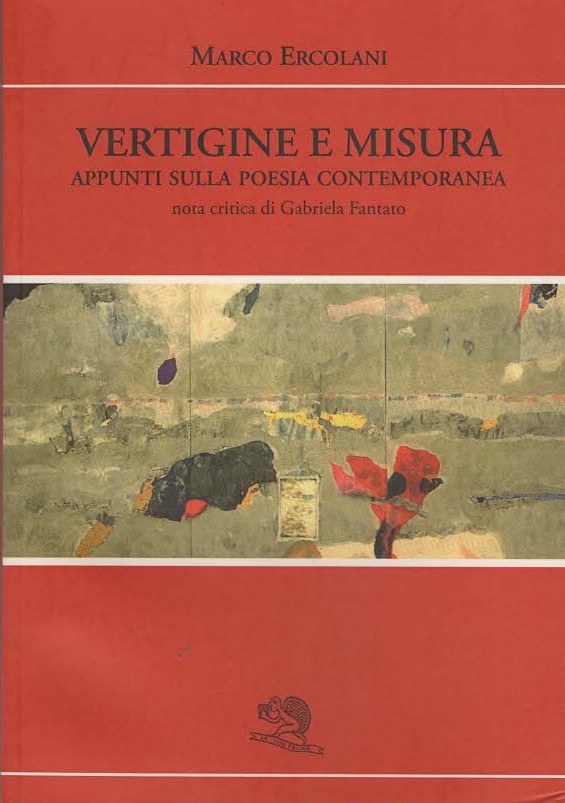
Zamanstvo
Se Vladimir Nabokov chiamava zamanstvo la capacità della lingua di persuadere e incantare grazie alle sue raffinate strategie, è vero che ogni testo autentico, in quanto frammento, cancella ogni zamanstvo, distrugge tutte le strategie e tutti gli inganni, si disinteressa della tecnica e del risultato, oltrepassando gli strumenti; come quella scena, nel cinema, che il regista non voleva e che, per caso, è stata creata da un movimento di gru, da un’intuizione dell’attrezzista, dalla smorfia di un’attrice, da un fondale falso. È perfetta, ma per caso, e nasce nel caos. Ma, se non lavoriamo ostinatamente a qualche soluzione che cerchi di sconfiggere quel caos, se non fingiamo di essere buoni demiurghi strumentando in modo accorto le nostre idee, rinunciamo a priori all’efficacia di un testo. Maestria tecnica, vibrazioni musicali, ingegneria sintattica o lessicale, sono i nostri mezzi di “ri-creazione” e “ri-lettura” del mondo. Da questi sentieri noti, soltanto dopo, possiamo intravedere foreste nuove, abitate dai sussulti di percezioni ulteriori. È un esercizio di ad-versione, di combattimento metaforico, contro l’esistenza antimetaforica e letterale che vorrebbe definirci con lapidi e sigle.
Chi è poeta vive solo con tutte “le sue domande” – fatte di verbi, nomi, pronomi, aggettivi, sintassi, frammenti, visioni, racconti – ma sostanzialmente libero. Vive con il suo stile, che è la perseveranza del suo esserci. Secondo Friedrich Dürrenmatt: «Arte è […] perseveranza che non lascia la presa, slancio primordiale che vede nel mondo qualcosa da riscoprire e riconquistare ogni volta da capo. Perché solo la possibilità di guadagnare o perdere il mondo in ogni momento fa della vita una grazia o una maledizione e non un’esistenza puramente necessaria».
**
Una fragile onniscienza
Nei suoi Decreti sui pianeti Velemir Chlebnikov scrive: «Il sole obbedisce alla mia sintassi». Non esistono limiti, in una certa fase del percorso creativo, alla forza plasmante che immaginiamo nelle parole. Ogni poeta vuole chiedersi, con Novalis: «Cos’è il mondo? A quale scopo lo produciamo con i nostri punti di vista? […] Il vero poeta è onnisciente – è un mondo reale in piccolo». Questa fragile onniscienza è il contrario della presuntuosa attività del poeta faber: è la consapevolezza di un segreto intrinseco alla parola, di una “cripta” psichica (Mario Perniola) che protegge l’atto creativo rendendolo felicemente invisibile.
«Se si osserva con pari attenzione questa assenza di scopi e di leggi della poesia moderna nella sua totalità e la rilevante eccellenza delle singole parti, il suo insieme appare come un mare di forze contrastanti dove si agitano confusamente in una torbida mescolanza, le particelle della bellezza disfatta, i frammenti dell’arte distrutta» scriveva Wilhelm Schlegel alla fine del XVIII secolo, negli anni in cui Hölderlin concepiva i suoi inni e Samuel Taylor Coleridge abbozzava la sua Rime of the ancient mariner. Non sembra siano passati più di due secoli da quelle parole se ancora oggi ci interroghiamo su questa “torbida mescolanza”, su questi “frammenti dell’arte distrutta”. Mentre Maurice Blanchot commenta: «Sembra ridicolo e miserabile che l’angoscia di un uomo abbia bisogno, per mostrarsi, dell’attività di un uomo che, seduto allo scrittoio, traccia lettere su un foglio di carta».
“Ridicolo” e “miserabile” indicano una necessità interiore tanto penosa quanto ineluttabile. L’esperienza oggettiva dell’opera, come testo concluso, corrisponde alla morte dell’io che si confessa a quello scrittoio. Così come l’interminabile monologo dell’io è la morte di ogni opera leggibile. Dallo scacco dell’una e dell’altro nasce l’esperienza fulminea della poesia. L’oggettività dell’opera fallisce, e ritorna l’impulso. L’impulso fallisce, e riappare l’opera. Non c’è scampo. Inconscio e coscienza vivono all’interno di questo campo gravitazionale, di questo scambio incessante in cui l’io è mediatore e medium, sospeso tra il caos della follia e il discorso della ragione.
**
Questa esitazione
«Per occhi due grumi, e due/ cicatrici, anch’esse qui,/ di sbieco attraverso/ il volto,// una luce, invocata dai tuoi/ primi ardori, estraniata/ da lungo tempo,/ s’insinua/ nella visione insorta». Nella poesia di Celan gli occhi sono due grumi che traversano obliqui la faccia, privi della vista. La luce è straniata, irraggiungibile. Rimane una visione interna, insorta. «CAMBIANO LUOGO le sostanze:/ và a te stesso, aggrégati,/ in dileguata/ luce terrestre,// sento dire che fummo/ progenie del cielo,/ questo resta da dimostrare, a partire/ da in cima, lungo/ tutte le nostre radici,// due i Soli esistenti, capisci,/ due, non uno – beh, e allora?»
L’uomo è “progenie del cielo”, sente dire il poeta. Ma sembra solo una sarcastica ipotesi. Però Celan ha una fede: assicura che due soli esistono. Nessuna logica convincerà il poeta del contrario. Anche se “il parlare vero è fatto d’ombra”, anche se la scrittura è porosa, trapassata, inservibile, e assomiglia un tragico relitto, è altrettanto vero che dei buoni relitti esistano ancora, dispersi fra i libri meno visibili, nascosti negli archivi meno sospetti.
La necessità di tacere e la possibilità di dire sono due misteri speculari e analoghi, dove la complicità del silenzio non esclude le complicazioni della parola. Forse il dire appartiene al regno dell’insonnia e il tacere a quello del sonno, ma chi scrive esita sempre fra risveglio e riaddormentamento. La scrittura è la traccia di questa esitazione. È coraggio parziale, complice del silenzio. Scrive Giuseppe Zuccarino: «Lo scrittore sa che, per dover resistere, deve lottare contro il silenzio, ma sa che non potrà mai vincerlo del tutto perché “il silenzio è nella parola come una parola da leggere” (Jabès)».
**
Né maestri né linee
La poesia contemporanea non ha né maestri né linee da seguire. Può però proporre una sfida: non appagarsi della sua autonomia linguistica, facilmente raggiungibile grazie alla comune tekné poetica, e rivelarsi come modo – imperfetto ma rigoroso – di “intelligere” il mondo attraverso il linguaggio. Il poeta dovrebbe indicare i modi in cui la materia delle proprie parole – toni, i ritmi, le phonai del linguaggio – convive con la materia del proprio “sentire” – emozioni, pensieri, significati. La parola poetica, attraverso la discontinua e tormentosa necessità della sua fisiologia linguistica, vive la necessità, altrettanto discontinua e tormentosa, delle passioni che la modellano. Il poeta è chiamato a un gesto, a una visione in cui, fuori dalla parola ma vincolato alle sue leggi, riviva il cortocircuito fra suono e senso come atto di ri-trasformazione e ri-nominazione del mondo.
La bellezza non ha più sede nelle formule estatiche della sua affermazione, nella sua orgogliosa e prevedibile perfezione, ma in uno stato di permanente rifiuto di quella “melodiosità” che, secondo Celan, «ancora andava risuonando, più o meno imperturbata, assieme o accanto agli eventi più orrendi». Il poeta di Czernovicz ci suggerisce che il linguaggio poetico «non trasfigura, non ‘poetizza’, esso nomina e instaura, cerca di delimitare il campo del possibile e del dato. […] All’opera qui non è mai la lingua stessa, la lingua in sé e per sé; bensì sempre e soltanto un io che parla dal particolare angolo d’incidenza della propria vita e che cerca una delimitazione, un orientamento. La realtà non è, la realtà va cercata e conquistata». È nel campo di questa nominazione e delimitazione che l’avventura può ancora continuare: ma il tessuto su cui le parole possono ancora tessere i loro scambi semantici è un’esperienza che nasce dentro la naturale follia delle parole. Quasi che il poeta, oggi, dovesse con pudore disserrare la porta su questo crogiuolo di parole che si cercano, si incrociano, lottano fra di loro, frantumate e disperse, ormai orfane d’autore, e suo compito fosse tener fermo il filo col quale cucirle, come il veggente organizza il materiale delle sue visioni: questo filo è la prospettiva da cui intravede il proprio paesaggio, la propria impronta, la propria irripetibile deformità. Una parola nata casualmente porta con sé un destino infinito, richiede gli strumenti di una frase, e poi quella frase ne chiama un’altra e un’altra ancora, fino al silenzio.
**
Il silenzio dell’arrivo
Il silenzio è l’approdo a cui tende la parola ma non può essere il silenzio dell’inizio: deve essere il silenzio dell’arrivo, costruito dall’esperienza delle proprie parole. Nessun silenzio è innocente, come nessuna armonia è priva di colpe. Bisogna trovare, con il proprio linguaggio, il proprio silenzio. Parafrasando Shakespeare, Auden afferma: «Tutto il resto è silenzio/ dall’altra parte del muro:/ e il silenzio è maturità/ e la maturità è tutto».
Esiste nella poesia, da sempre, la meraviglia per quanto non è dicibile, l’esperienza dell’impensato. La magia del dire si intesse al sortilegio dell’indicibile. Ma hanno ancora diritto di esistenza, nel linguaggio poetico, stregonerie foniche, manierismi linguistici, incantesimi lessicali? Celan scrive: «Dovetti dunque anche dedurre che su quanto lotta da tempo immemorabile per trovare espressione si è deposta la cenere di significati antichi, ormai morti, e altra ancora! In che modo allora il nuovo dovrebbe scaturire con la sua purezza? Ben vengano, dai più remoti distretti dello spirito, parole e immagini e gesti, velati come nel sogno e in sogno svelati». Jabès aggiunge, parlando della sua poesia: «Celan ha quasi inventato una nuova lingua tedesca perché ha messo insieme delle parole, come se le parole potessero in quel momento salvarlo. […] Ha voluto fare l’impossibile con il linguaggio, ma questo impossibile non significava per lui solo desiderio di dire, ma anzi desiderio di tacere». La poesia si scopre porosa, lacunosa, esitante, e raggiunge, attraverso circuiti diversi di parole, la sua intima natura di silenzio – resistenza al linguaggio in imminenza di parola.