Trascrizione di un’autointervista per Marco Ercolani (giugno 2021).
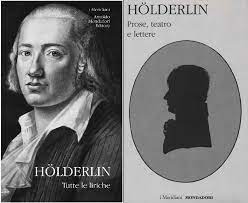
Mi scusi se comincio io. Non so quale fosse la Sua domanda ed è un sacrificio, per me, mi creda, rinunciare a qualcosa che poteva anche sembrare un regalo.
Lei voleva farmi un regalo, vero? Magari Lei stava per chiedermi come la poesia cambia la vita? Ci sono bassezze peggiori, devo dire.
Lei, in ogni caso, dovrebbe farmi la cortesia di non chiedermi risposte che prevedano l’applicazione del verbo essere, per esempio cos’è la poesia, così che io sia indotto a rispondere: la poesia è.
Lei ha presente il dogma dell’eucaristia? Lei ha presente cosa fa il verbo essere quando è applicato tra due termini che nemmeno se lo sognavano? – quando questi termini vengono indotti a una identità che li lascia interdetti – non solo attoniti come vorrebbe il significato popolare, sbalorditi, esterrefatti, rintronati – ma giuridicamente impediti ad essere se stessi, con divieto esplicito, dovendo essere ben altro, per dogma?
Perché – penso che Lei mi dirà, tra poco – tiro in ballo l’eucaristia dovendo, per stare in tema, parlare di poesia? Adesso ci arrivo, con un po’ di pazienza, eccomi. Tiro in ballo l’eucaristia perché la poesia tenta di assomigliarle – per alcune pretese, alcuni colpi di mano, primo fra tutti quel suo tentare vari tipi di estasi, o di eclissi – come sottraendosi al linguaggio, al suo impero, alla sua diplomazia o indolenza, al suo rimediare – quello che l’aveva portata in spalla – come una bambina timida, quello che l’ha trasferita sull’altra riva, come San Cristoforo.
Il linguaggio che diventa essere? L’essere che diventa gioia o soddisfazione, tema in classe, oltre che dovere, compito e così via? – eh diamine! Sulla follia del verbo essere si sono cimentati in molti.
Alla fine, i più ragionevoli, costretti a fare i salti mortali, hanno attribuito, per esempio, a est il valore di significat, come il buon Huldreich Zwingli nel XV secolo, ma anche Sant’Ambrogio, con saggezza, tanti secoli prima, per cui: hoc est corpus meum avrebbe il valore di hoc significat corpus meum – vale a dire: non scalmanatevi, miei fedeli, non fatemi dire una cosa per un’altra – non fatemi fare di queste figure! – per piacere.
Hölderlin l’ha detto chiaro più di chiunque altro – ha detto che “Io sono io” (Ich bin Ich) non è una dichiarazione di identità, bensì una disgiunzione (Trennung, Urtheilung): l’io del soggetto non è più quello del complemento oggetto – quindi occhio! – sono gli stessi, ma non più!
Lei saprà cosa fa Hölderlin nel brevissimo saggio, una paginetta, un gioiello, intitolato Urtheil und Seyn|Giudizio ed essere? Fa innanzitutto una sceneggiatura. Chi tra i due entrerà in scienza per primo? Non sarà Seyn|essere, al quale è riservato il colpo di scena finale, bensì Urtheil|giudizio, che ha il compito di essere linguaggio, parlante, sfoggiando la sua coccarda giacobina, aprendo la ferita.
Il fatto che Hölderlin metta la separazione prima dell’unificazione o della conciliazione o del desiderio di ciò, la dice lunga su come egli intendesse la vita, grandiosamente sempre di là da venire, e tuttavia dolcissima, obbligando senza requie a vivere, senza interruzione o riposo, senza dimenticanza. Che la poesia fosse una proroga oltre il giudizio? – un Seyn che, da specchio a specchio, si lancia davanti a noi, nostra aspirazione, invece di doverci sempre voltare, riconoscere la perdita, l’impoverimento – era quella la poesia adatta ai tempi di adesso, un tempo ulteriore, fuori tempo, riacciuffato a sua volta, ridotto nuovamente a dibattito, a dimostrazione e a giustificazione, come un’ombra che ha assunto vita propria, lontana dal corpo che la reggeva, per quanto lunga, nel tramonto?
Mentre Seyn non concede distrazioni o proroghe, Urtheil può ripassare più volte sul posto, può stare con noi, come una fuga di ombre. Non mi venga a dire che sono in ritardo di due secoli! – che mi sono attardato nella poesia del dolore, dell’entusiasmo – eh l’idealismo, briccone!
Era il lontano 1795, ma è appena ieri, oggi. Se la poesia ha fatto progressi? – se la grammatica ha ancora spiragli sorprendenti, qualche colpo di gioia, di scena? È ancora vero e legittimo che basta esagerare per mettersi in pari? Se così fosse, ciò significa che i viventi stanno mettendo ancora in pegno la loro vita, dopo millenni, da capo e come al solito.
Per dirla tra di noi, per farla corta, Seyn equivalga ai viventi, dal primo all’ultimo – per cui c’è poco da gongolare, ben poco da fregarsi le mani – mica tanto da frohlocken, pietisticamente – a fronte della dittatura dell’esistere, della sua inclemenza.
Urtheil, colui che divide, è la nostra rivendicazione, il nostro risarcimento? La poesia è l’Urtheil che si svuota fino a ritornare Seyn? – rinunciando alla coscienza eretta, chiuse le palpebre, arrischiando? Bah, non saprei, può essere, anzi – sia questa la posta in gioco!
La piena affermazione non è soltanto un’utopia – è una stupidaggine. L’ombra, tenga presente, non è un accessorio dei corpi illuminati, bensì una pulce nell’orecchio, un preavviso, un monito insomma.
Lei mi dirà che sto divagando a bella posta, che mi sto aggrovigliando in concetti senza scampo, frutto di quello shock, remoto, per cui uno cosa fa, cosa gli rimane?
L’ho già scritto da qualche parte, ma io ho visto un cavallo, una volta, davanti a un macello, in un corridoio di transenne, in fila, aspettando il turno – ho visto che ingigantiva, in purezza, che diventava sempre più cavallo, nella più grande tensione, con fremiti leggeri sottopelle, composti, defecando, urinando, come esprimendosi – ho pensato alla poesia, alla rappresentazione dei vivi, un fermo immagine, un sonetto, con il corpo che imita la figura – suprema umiliazione, fasulla, un dolore specifico, letterale.
In ogni caso vorrei sostenere la proprietà disgiuntiva della poesia, illustrando fermamente ciò che essa separa, quindi consapevole che si tratta di esequie, di commemorazione accanita. Allora il linguaggio deve essere cerimoniale, ma ridotto all’osso, o la cerimonia è soltanto noiosa.
Intendo, forse, che la poesia è l’attesa del linguaggio? Quando il linguaggio arriva, potremmo dire che l’attesa è rovinata? – che un sopruso è stato consumato? – che il fedele è diventato un praticante? All’erta, all’erta!
Cosa fa il fedele che riceve l’eucaristia? Oltre ad allungare, pudicamente, la lingua – egli, ella, loro, i fedeli – evitano di pensare, se ne guardano, ma chiudono, generalmente, gli occhi, si abbuiano la mente, in modo da predisporsi, a quel colpo d’essere, al suo assalto, dolcissimo, che lascia uno svenimento interiore, come fosse questa la prova del nove – sofistica o cosa vogliamo pretendere?
Dunque la poesia è mormorare, a bocca chiusa?
Mi accadde, talvolta, di pensare a mia madre, una contadina, che ascolta le mie poesie. Nel più grande imbarazzo, le dico una parola per volta, distanziate, come se fossero le ostie della comunione, mascherando l’insieme. Evito le metafore del genitivo, scelgo solo parole primarie, pulite.
Se Lei può intenderla come una dichiarazione di poetica? – La prego! Come se la poesia fosse la femmina del pensiero – proprio femmina, carnale! Sapesse quanto si impara dal trucco delle vere signore! – quante mosse tremende, magnifiche.
Comunque: chi manda avanti il linguaggio come uno scudo è uno stronzo! Peggio ancora se lo scudo è istoriato, con i fatti dipinti – non ancora cancellati con il perdono. Il vero arcangelo copre sempre il proprio apparire – con le proprie ali.
Se si tratta di togliere lo scudo? Non si tratta di fare gli spacconi in battaglia: in poesia ci sono soltanto scudi finti, figuriamoci.
Tutto lo sforzo per dire niente. Per mantenere il linguaggio in posizione. Affinché, dietro le sue spalle, si possa vivere, quindi parlare. Lo dica pure: affinché ci possiamo distrarre. Dopo l’anestesia, almeno speriamo, se tutto va bene.

