Dalle Carte segrete di Innokentij Annenskij (1842).
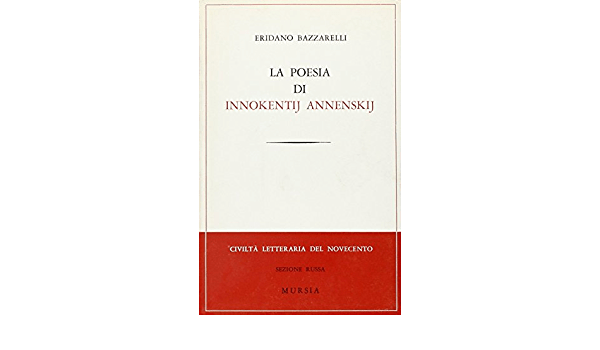
Ripeto quello che dico da sempre: io amo tutto ciò che in questo mondo non trova né armonia né risonanza; odio gli scalpitanti cavalli della trojka gettata a briglie sciolte nel bosco ma adoro l’eco della sua corsa. Non devo né urlare né difendere tesi: altri lo hanno fatto meglio di me, con esiti deplorevoli. Annoto schegge di frasi, pezzi di conversazioni, inizi di racconti, finali di romanzi. Io scrivo riflessi
Nei ginnasi di Pietroburgo non sanno nulla di me, io sono il mite e dolente professore dall’occhio chiaro e dall’andatura assorta. Il titolo del mio primo libro di poesie era Canzoni sommesse e lo pubblicai con lo pseudonimo di Nik-T-O, che significa nessuno.
Lavoro da orafo le mie poesie: sono i miei scrigni e le mie urne. Guardo e riguardo il bassorilievo con quell’Ulisse senza testa, legato all’albero della nave piccola, i remi d’alabastro piantati nel mare immoto, che finge, senza orecchie e senza naso, di udire le volgari Sirene, che suonano una cetra che sembra di cera.
Mi chiamo Innokentij: l’insonnia e il tedio delle stazioni russe sono il mio interminabile inverno e la mia sconsolata innocenza. Lì, sotto cieli senza colore, ho scritto le mie poesie migliori, di cui andrebbe fiero Anton Čechov.
I suoi personaggi sono straordinari come se fossero esistiti. Il mite Belikòv che si ammala e muore e viene chiuso nella bara – ultimo e definitivo ‘astuccio’ – con un’espressione di serenità nel volto rassicurato dalla morte, mi assomiglia. Ma il personaggio che amo di più è Jonyc. Da giovane, Jonyc incontra la famiglia Turkin. Sente un’irresistibile simpatia per l’impetuosa e ardente eloquenza di Ivan Petrovic, il padre: «Non c’è maluccio, vi ringrazio umilmente, oh Micetta, oh pollastrella, addio, per favore!» Prova tenerezza per Pavlusa, il servo quattordicenne, che si inginocchia nella sala da pranzo e declama: «Muori, infelice!» Lo commuove la voce di Vera Josifovna, la madre, che bisbiglia l’inizio di qualche interminabile romanzo dove un’elegante contessa fonda biblioteche, finanzia ospedali, adora pittori squattrinati. Si innamora del volto grazioso della figlia, la mite Ekaterina Ivanovna, che suona il pianoforte in modo brillante, eseguendo polacche e rondò, valzer e capricci, fantasie e ballate. Poi gli anni passano. Jonyc invecchia, ingrassa, diventa ottuso e pigro. Cura controvoglia i malati, gioca a whistle, bestemmia. Ritorna dai Turkin e scopre un ridicolo repertorio di spettri: un attorucolo rugoso col suo nauseante birignao, un servo rozzo che si getta a corpo morto sul pavimento, un’insopportabile megera che blatera romanzi stucchevoli e sentimentali con vocetta rauca, una zitella invecchiata che martella note di ferro su un pianoforte scordato. Quel terribile album di fantasmi mi è entrato nel cervello e io lavoro e scrivo cercando di restituirne l’intollerabile malinconia, a costo di risultare sgradevole ai miei rari lettori. Nel mio Libro dei riflessi ci sono schegge di Jonyc. La mia famiglia è diventata la famiglia Turkin. Addio per favore! Micetta! Muori, infelice!
Piccole cose sommesse e atroci, che dimenticano tutti sotto illusorie architetture. Io abbatto quelle colonne di carta e le vedo come sono realmente, le cose, bisbiglianti e scorate, affannate e ridicole – mio diario di condannato. Ma sono io il prescelto a cantarle, io che amo l’invisibile, da sempre, dall’ultima fila della platea di questo teatro di guitti.
(M.E.)


