(2023)
Non è strano: la poesia è senza parole. Le poche che trova, la catturano interamente, senza lasciarle nemmeno una sillaba per farsi sentire. (Angelo Lumelli)
Restare appena dicibile praticando una scrittura interminabile. (Marco Ercolani)
**
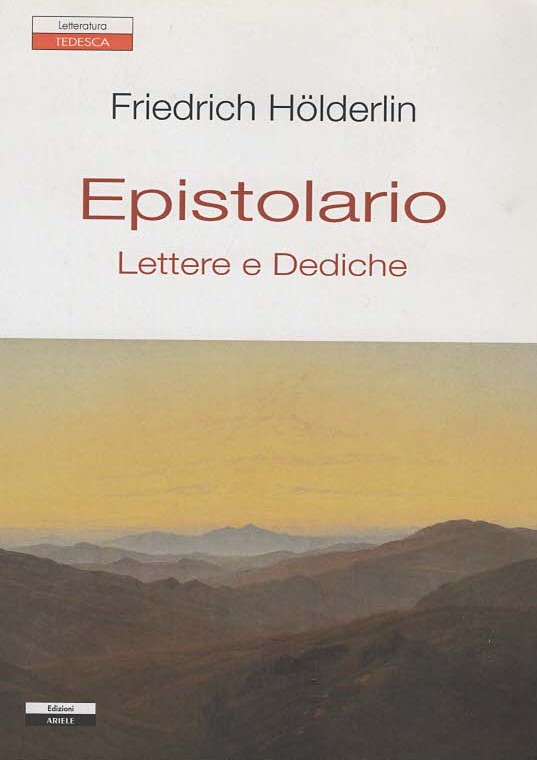
**
CAPITOLO PRIMO. Lettere 1-7
Prima lettera. M.E.
Caro Angelo,
lo sai? Leggendo il tuo Verso Hölderlin e Trakl, quando non ti conoscevo ancora, mi colpì immediatamente questa tua definizione della poesia, inserita mentre dicevi del tacere e del parlare: «La poesia, osiamo sperare, è là, in quel posto, nelle carceri oscure d’ogni anima e – per chi ha ancora un po’ di fiato – è il jolly da giocare quando il linguaggio è sul punto di perdere la partita».
Il libro mi divenne ancora più prezioso, per quella frase, e nel maggio del 2021 volli ricambiare la gioia di quella lettura con il mio Pallaksch. Ho esagerato? Direi di no: eri il solo a poterlo leggere senza travisare nessuna parola. Pubblicai il libro (si chiamava Discorso contro la morte) nel 2008 (era composto di dodici racconti), ma ottenni solo lodi generiche o silenzi sconcertati. Da te seppi che avevo centrato il bersaglio. Pallaksch era reale, come può esserlo un sogno vero. “Dio ha stabilito il sonno, disgustato dall’orrore della veglia”. “Mentire è una nota leggera, un accento acuto nel mio presente, che non sopporta i gravi e tragici accenti del passato, che non tollera i circonflessi e instabili accenti del futuro”. Vedi? Siamo da capo. Un burattino per tutti, il mio Holder. Un bel facitore di paesaggi lirici. La sua natura è schematica. Batte il ritmo tutto il giorno. I suoi inni, le impervie vette da cui è caduto, non esistono più. Non ha retto, l’educatore. Chi poteva educare? Se stesso ad amare di meno, a vedere di meno? Può farlo, un poeta, “nelle carceri oscure dell’anima”? Però, vedi, leggendo il tuo Verso Hölderlin e Trakl, respiravo una gaiezza felice e sibillina, quella gaiezza che sola permette di aprire la finestra sul tragico. Come dicevi? «Con tutto ciò avevo inteso sostenere l’anticipazione novecentesca di Hölderlin, premonitore di una poesia che molto riflette su di sé che si purifica fino a una trasparenza di gemma, poeta che spinge la poesia del proprio tempo verso confini che ci sfiorano e che, potentemente, sono nel territorio del nostro dire». E io cosa scrivevo? «Si deve sentire, fra i mortali, il sublime. Ma come?». Su questo “come” sei entrato tu.
**
Seconda lettera. A.L.
Caro Marco,
Lo sospettavo: Hölderlin ricomincia da capo. Intendo che ci fa ricominciare, come se la conclusione fosse una porta che si apre, non quella che si chiude. Ah il tuo Pallaksch! Tutto sembra confinato, almeno in frasi ragionevoli, profonde ma non sprofondate, invece no!
Te ne dico una (che gli fai dire tu, a Hölderlin): “I limiti della lingua sono l’ombra dell’illimitato”. (pag.19) Cosa vuoi farci! – hai provato e sei arrivato non alla fine, ma alla svolta (die Wende).
A ciò servono gli apocrifi, non alle spalle dell’autentico, ma del canonico, come fai osservare nelle “Note di lettura” al “ Discorso contro la morte”.
Tutte le entrare originali sono entrate sul retro, come nei ristoranti, dove s’impilano le case dell’acqua minerale.
Vuoi una lode aggiuntiva? Ciò che fai dire ad Hölderlin, lo fai dire, con una variante d’ingegno, anche a Caspar David Friedrich, il pittore: ”L’arte è la forma di ciò che la esclude…” (pag. 48)
Scusa se le mie lodi sono magre, ma esse si riconoscono da come si mettono al lavoro, come si rimboccano le maniche. Tu hai sparso lungo le pagine di questi taccuini segreti di Hölderlin alcuni titoli di esercizi, ossessivi, che adesso non posso più evitare.
Testardamente, eccoli:
1: Custodisco il vaso.
2: (Poros) colui che dorme nel sonno.
3: La distrazione è tutto.
4: Come sempre, quando non si vuole soffrire, si diventa kantiani.
5: C’è un mezzo per liberarsi dal proprio stile?
Tutti questi titoli sono coinvolti, a mio modo di vedere, nella comprensione del primo verso della poesia Die Aussicht che tu, bellissima mossa, riporti integralmente. Ah quella non è apocrifa! Soprattutto essa mette a tacere ogni teoria attraverso l’atto del tornare, del tornare sul posto intendo, come il figliol prodigo, un presente che, invece di spiegare, contiene le domande (ah come le conosce la mia nuca!).
“Custodisco il vaso” avrà anche questo senso?
Noi ci siamo visti a Genova nel mese di Maggio del 2021. Era la seconda volta che c’incontravamo – la prima era lontana decenni. Non avevamo mai parlato di Hölderlin. Io cercavo un complice. Non so spiegarmi perchè io abbia questo ritorni tardive di adolescenza. Quando ti ho sottoposto la mia traduzione di quella poesia (Die Aussicht), ricordo che non volevo dichiarare – come faccio di solito, per quieto vivere, pur a quei pochi – che non si trattava di una traduzione, quanto di una confidenza, di una presunzione d’intimità, timorosa, seppur festiva.
Sono talmente convinto che Hölderlin sia un poeta del Novecento, d’avere, consapevolmente, corso i pericoli d’incappare nell’inquisizione germanistica – timore rivelatosi vano, perchè nessuno ci ha fatto caso. Hai presente taluni corpi celesti, invisibili a causa della distanza o di altri motivi, che manifestano la loro esistenza attraverso gli effetti, gravitazionali o altri ancora, molto specialistici, sui corpi visibili del firmamento?
Noi medesimi siamo parte di questi casi – ma ancor più il fenomeno è riscontrabile in poesia, allorché il linguaggio ha un sussulto, un brivido strano, senza nessuno che dica io. Non ti è mai capitato di partecipare a una veglia funebre? – quelle fatte in casa, nei paesi? – ebbene c’era un parlottare continuo, un brusio, un raccontare d’altro, per cui, silenziosamente, la salma diventava, piano piano, nel corso della sera, della notte – in quelmodo taciuta – un inno alla mancanza, un monumento.
Ora, ciò che fai dire ad Hölderlin nel tuo Pallaksch – perdona l’azzardo – mi sembra risponda a quanto è “incorporato” (oh corporis mysterium) nel primo verso di quella poesia così regolare, misurata e sconvolgente.
I cinque temi che ho messo in evidenza – siano essi il nostro compito in classe – appartengono a quella categoria di enigmi che scatenano qualsiasi altra soluzione, ma non la loro. Succede anche a te che un’incognita si risolva senza soluzioni, sospendendosi, arretrata nel remoto firmamento, mentre in primo piano fanno festa uguaglianze e somiglianze? Succede, ma fai ballare l’occhio – dicono da queste parti.
Basta con le divagazioni – vorrei tornare a Pallaksch e a Die Aussicht.
Due sono, in quel verso, le parole chiave: in die Ferne e wohnend Leben. Di queste due parole chiave, una (wohnend) è, per così dire, la chiave del caveau, dove è nascosto ciò che è decisivo.
Cosa è decisivo in wohnend? Io direi: essere qui |da-sein – stare, il quale comporta: restare/rimanere, parole di portata immensa.
Una questione si pone: o wohnend non lo traduci (per es. Luigi Reitani) o lo traduci, forse legittimamente, con (vita)usata nel senso di abituale, solita ecc… (come Enzo Mandruzzato, che tu utilizzi).
Mi sembra di poter dire che wohnen, in Hölderlin, si contrapponga non soltanto al divenire (che strappa dai luoghi), ma all’onnipresenza (senza luogo, al di sopra del luogo) dei Celesti.
Il luogo è tentato sia dall’eresia che dall’amore. Il vivente è luogo – non un millimetro più in là.
Il “tuo” Hölderlin mi sembra perfettamente in linea con l’immensa “malizia” di quel primo verso, che sottolinea, in modo fulmineo, la “localizzazione” del vivere e la sua “lontananza intrinseca”.
Ancora un’osservazione: wohnen è una parola che Hölderlin usa per indicare la vita nel limite, una vita all’oscuro, un rifugio dalla luce, un interno. In questo senso wohnen (abitare) chiama bleiben (rimanere).
Der Vater aber decket mit heiliger Nacht, | Damit wir bleiben mögen, die Augen zu. (Dichterberuf)
Ma il Padre con la sacra notte | copra i nostri occhi, affinché ci sia dato rimanere. (Vocazione del poeta)
Rimanere è anche “disdire” il compito impossibile, la dismisura e il disumano.
Hoch auf strebte mein Geist, aber Liebe zog |Schön ihn nieder, das Leid beugt ihn gewaltiger; | So durchlauf ich des Lebens | Bogen und kehre, woher ich kam (Lebenslauf, 1798)
Spiccò il salto il mio spirito, ma il bell’amore | Lo chiamò, poi lo piegò l’onnipotente dolore;| Così salgo e scendo sull’arco della vita | per tornare da dove son partito. (Corso della vita)
Ecco finalmente il verso che tanto mi attira e mi angustia:
Wenn in die Ferne geht der Menschen wohnend Leben, | Wo in die Ferne sich erglänzt die Zeit der Reben, …
Abita degli uomini la vita ed è lontana | lontano splende tempo di vendemmia, …
Non è una traduzione, è una malattia.
Ma non è anche il vaso custodito, del quale parli tu? – un vaso che non esplica, ma conserva? – parole che non vengono risolte perché il loro compito era di chiamare, insistentemente? Questa poesia ha imparato ad abitare (wohnen)? Ha imparato il proprio sonno? Ha imparato a dire una cosa per volta come la più grande distrazione? Ha dunque imparato a liberarsi dal proprio stile usandolo spudoratamente? Non ha nemmeno più bisogno di essere kantiana?
Perdona se, puntigliosamente, sembro farti rispondere da Lui, Hölderlin, attraverso una poesia disarmata, diligente, umile e caritatevole – ma a ciò può arrivare la poesia, alla più astuta infanzia, all’innocenza che esige, già da pargoli, quell’incomprensibile batticuore, il di più di noi, che sta sempre per arrivare.
Angelo
**
Terza lettera. M.E.
Caro Angelo,
esiste un’esperienza spirituale di cui la schizofrenia si impadronisce: il crollo estatico della mente. Quando, ormai, tutto è detto, prorompe il non dicibile, e tutto tace. Che dire ancora? Hölderlin si ferma qui. Crolla sotto il peso dei suoi inni e la lingua torna classica quartina, idillio non beffardo. Ci si rassegna. Ad avere valore era l’imminenza precedente, ma portarne il peso è terribile. Tessono e disfano, i poeti, rapsodi inebriati dal pensiero laterale. L’esistenza demonica e irrefrenabile, il varcare se stessi, sopraffatti dal terrore e o inebriati nell’estasi, non è psicosi. Ma ci corre vicino, come sull’orlo della fiamma. Accade come se il demonico, represso o sedato, nelle malattie riuscisse a scaturire, a trovarsi un luogo d’elezione, un varco. Ma qui torno al mio pensiero dominante. Non di malattia parlo, di quella che impoverisce l’io nei sintomi, ma di una giungla informe e disordinata, dove l’anima, abbandonata a un brivido metafisico, mostra la propria profondità disordinata, la tenta il crollo, il cadere svuotata, l’informe del caos. Ma resiste. Come se, in un’altra storia, Hölderlin non fosse impazzito ma avesse continuato a scrivere inni, sull’orlo del precipizio, sempre più folli, loro, non lui, che magari si barcamenava fra un discepolo da istruire e una lezione di metafisica ma sano. La scrittura è specchio e luce, sempre, anche se tutto ruota, mai notte informe. Il silenzio, nel disordine della mente, è l’atroce pericolo. Ma, perdona se mi azzardo, la poesia cambia… cosa cambia?
Marco
**
Quarta lettera. A.L.
Caro Marco, magari non intendevi farmi un regalo, invece eccolo – a confortare la mia diffidenza verso la poesia, a raffinare ancor più il mio amore distillato, goccia a goccia – dunque tu dici che negli inni si vede la follia evitata per un pelo? la fronte che sanguina? – e che questo è il grande messaggio – uomini, fratelli! – ecco che il giro di boa (die Wende) è vicino, che la frase si volta verso di noi, ci investe – e noi accoglieremo questa morte fittizia, rilanceremo strofa su strofa, ghirlande di fiori, nella nostra sacra, perversa congiura?
Invece bastava lasciare che il linguaggio rotolasse come biglie di vetro dei bambini, che la poesia fosse la grande dormiente, voce del mormorare, a bocca chiusa – finalmente poesia accettata senza fiatare, eseguita, con trucchi da vecchio mago.
Dunque del vestito si possono amare le fodere? la loro setosa lucentezza, il loro scivolare impalpabile? – cosa avviene nel retro delle palpebre? Ciò per dire che la poesia, con la promessa di farci diventare pura voce, separa noi dalla nostra voce carnale, impigliata nelle corde vocali, renitente, voce da vecchi fumatori, nel caso – lasciati a terra, a vivere? Di ciò si tratta – dell’indifferenza del vivere che solca, impudente, il gran mare dei pensieri, che forse non li tollera, non li ha mai tollerati.
Da qui nasce forse il mio amore per il verbo essere, la paura che m’incute, lo sgomento – da cui il fascino stregato di quell Seyn, del quale Hölderlin ha parlato, del quale io ho voglia di parlarti.
Hai presente il dogma dell’eucaristia? É un caso sconcertante dei poteri del verbo essere, manutengolo di un potere occulto, Hai presente cosa fa il verbo essere quando è applicato tra due termini che nemmeno se lo sognavano? – quando questi termini vengono indotti a una identità che li lascia interdetti – non solo attoniti come vorrebbe il significato popolare, sbalorditi, esterrefatti, rintronati – ma giuridicamente impediti ad essere se stessi, interdetti per divieto esplicito, dovendo essere ben altro, per dogma? Perché – penso mi dirai tra poco – tiro in ballo l’eucaristia mentre stiamo parlando di poesia?
Adesso ci arrivo. Tiro in ballo l’eucaristia perché la poesia tenta di assomigliarle – per alcune pretese, alcuni colpi di mano, primo fra tutti quel suo tentare vari tipi di estasi, o di eclissi – come sottraendosi al linguaggio, al suo impero, alla sua diplomazia o indolenza, al suo rimediare – quello che l’aveva portata in spalla – come una bambina timida, quello che l’ha trasferita sull’altra riva, come San Cristoforo.
Il linguaggio che diventa essere? L’essere che diventa gioia o soddisfazione, tema in classe, oltre che dovere, compito e così via? – eh diamine! Sulla follia del verbo essere si sono cimentati in molti.
Alla fine, i più ragionevoli, costretti a fare i salti mortali, hanno attribuito, per esempio, a est il valore di significat, come il buon Huldreich Zwingli nel XV secolo, ma anche Sant’Ambrogio, con saggezza, tanti secoli prima, per cui: hoc est corpus meum avrebbe il valore di hoc significat corpus meum – vale a dire: non scalmanatevi, miei fedeli, non fatemi dire una cosa per un’altra – non fatemi fare di queste figure!
Non oserei parlare del verbo essere e delle sue tremende meraviglie se non fosse che Hölderlin l’ha messo in una sceneggiatura, invece di farne un trattato. Mi riferisco a quella paginetta intitolata Urtheil und Seyn|Giudizio ed essere, nella quale entra in scena il giudizio (Urtheil) che trasforma, dividendolo, il soggetto ICH in oggetto – tu perdona se mi viene in mente JHS, segno dell’ostia, della vittima (Hostia) – perdonami se uso i concetti come un lecca lecca.
Adesso, però, entra in scena Seyn|essere. il quale non sopporta nessuna divisione (Trennung), nè poca nè tanta – fungendo, da una parte, e all’apparenza, come conciliatore, mentre dall’altra non intende immischiarsi con il pensiero, i suoi sotterfugi, esercitando una funzione dittatoriale ed indifferente.
Seyn, in realtà, è colui che porta alla morte, la quale è interamente. La poesia, in combutta con Urtheil|giudizio, creatore di nascondigli, guarda a Seyn come al più temibile amore, quello che, se si voltasse, la ridurrebbe in cenere. La poesia è dunque una proroga, oltre il giudizio, dell’incontro con Seyn? Si nasconde, essa, dallo sguardo che distrugge le ombre? Si refugia nell’ombra per nascosto amore di quello sguardo, cercando il coraggio di farsi incenerire?
Per dirla tra di noi, per farla corta, Seyn è il vivente, l’irrimediabile – per cui c’è poco da gongolare, ben poco da fregarsi le mani – mica tanto da frohlocken, pietisticamente – a fronte della dittatura dell’esistere, della sua inclemenza.
Era il lontano 1795, ma è appena ieri, oggi.
Se la poesia ha fatto progressi? – si nasconde ancora da Seyn, il suo amore? La piena affermazione avviene una volta sola ed è l’ultima – guai essere presi in parola. É ancora così? La poesia, infine, può essere soltanto mediocre? Intendo, forse, che la poesia è l’attesa del linguaggio?
Quando il linguaggio arriva, potremmo dire che l’attesa è rovinata? – che un sopruso è stato consumato? – che il fedele è diventato un praticante? – all ’erta, all’erta!
Cosa fa il fedele che riceve l’eucaristia? Oltre ad allungare, pudicamente, la lingua – egli, ella, loro, i fedeli – evitano di pensare, se ne guardano, ma chiudono, generalmente, gli occhi, si abbuiano la mente, in modo da predisporsi, a quel colpo d’essere, al suo assalto, dolcissimo, che lascia uno svenimento interiore, come fosse questa la prova del nove – sofistica o cosa vogliamo pretendere?
Dunque la poesia è mormorare, a bocca chiusa?
Mi accadde, talvolta, di pensare a mia madre, una contadina, che mi dice: perchè non mi vuoi leggere le poesie? Nel più grande imbarazzo, le leggo una parola per volta, distanziate, come se fossero le ostie della comunione, mascherando l’insieme. Evito le metafore del genitivo, scelgo solo parole primarie, pulite.
Tu puoi intenderla come una dichiarazione di poetica? – ti prego! Come se la poesia fosse la femmina del pensiero – proprio femmina, carnale! – come se Seyn fosse disponibile a parlarle, tenendole una mano sulla testa.
C’è sempre da imparare dal trucco delle vere signore! – quante mosse tremende, magnifiche.
Comunque: chi manda avanti il linguaggio come uno scudo è uno stronzo! Se si tratta di togliere lo scudo? Non si tratta di fare gli spacconi in battaglia: in poesia ci sono soltanto scudi finti, figuriamoci.
Tutto lo sforzo per dire niente.
Per mantenere il linguaggio in posizione.
**
Quinta lettera. M.E.
Il linguaggio in posizione? Dentro la luce violenta? Sotto quale ombra? Ricordi le parole di Nanni? «Quale sarà, allora, la condizione di un poeta che non onori il criterio della verosimiglianza, ma agisca in una grave penombra della mente? C’è un fenomeno adatto a descriverla: l’esperienza chiaroscurale di quelle figure che si vedono nel dormiveglia, nel caleidoscopio notturno proiettato sullo schermo interno delle palpebre…Questo sono, quelle figure: sogni incompleti. Sogni di chi sa di sognare. Sogni della presenza, dell’intensità della presenza. Somigliano alla poesia: anche il poeta in qualche modo giace, e la sua condizione è la stessa dello spettatore – una condizione concava. E un giovane poeta dovrà innanzitutto imparare a divenire accogliente, capace di lasciarsi prendere da figure e di prenderle poi dentro di sé, udirne la possibile voce. Capace di aspettare che il suono possibile si faccia fatale…Il poeta confida d’incontrare parole che possano riprendere in sé il segreto, l’impronunciabile mistero di quello che appare».
No, Angelo, non ho domande precise. Siamo arrivati qui a tastoni, e a tastoni parliamo. Riflettevo su come un amico definisce la poesia: “Enigma con ritmo”. (Anche tu dipani l’enigma ritmico ma lo usi come divagazione del pensiero, che oscilla esistendo, timore e tremore…). È finzione, certo, ma gli scudi finti non diminuiscono l’intensità della battaglia. Lo so bene da quando indago la psiche, cioè da sempre: nessuno muore, così sembra, ma la battaglia non è meno aspra. E le finzioni sono ventagli da cui volteggiare. Scrive Paul Valery: «Succedeva che Mallarmé, il meno primitivo dei poeti, tramite l’accostamento quasi ipnotico delle parole, lo splendore musicale dei versi e la loro singolare pienezza, richiamasse alla mente quello che doveva essere l’elemento più potente della poesia delle origini: la formula magica». Ci sono formule magiche per la poesia? Verrebbe da rispondere di no, ma forse, invece, la risposta è sì. Chi scrive poesia si mette fuori dal mondo riconosciuto: abita un altro regno, quello del proprio (magico?) stupore. La magia di cercare la parola poetica come lingua altra, nido contro il current langage, scudo magico per proteggersi da minacce estranee ma anche casa calda in cui accogliere chi è diverso da te. Nel suo essere nido e scudo abita la possibilità di un “altrove della parola” che sospende i codici esistenti fino ad ora. Il fatto di costruire insieme un dialogo non ha nulla di architettonico, in sé: è il piacere di scoprire rifrazioni e differenze, non solo nell’oggetto poetico ma nel terreno accadere delle cose….
**
Sesta lettera. A.L.
Caro Marco, c’è un disappunto nella tua lettera? – non ti va l’idea di mantenere la poesia in posizione? Effettivamente, se dovessi spiegare ciò che intendo, potrei trovarmi in difficoltà – ma ci sono bassezze peggiori, devo dire. Forse, principalmente, intendevo che mantenersi in posizione significa fare l’indiano, come nei film, quando uno appoggia l’orecchio e ascolta la terra, per sentire se arrivano i bisonti, il treno.
A questo proposito ho scoperto, pur non essendo professionalmente un mistico nè un entusiasta, che abbracciando un albero si sente il vento, anche leggero, che amplifica il proprio suono, che da aria fluente diventa risonanza, nello stretto delle fibre – ma bisogna stare abbracciati per sentire queste corde sonore – se sciogli l’abbraccio, se allontani l’orecchio, ogni incantesimo è finito. Ma noi non possiamo stare abbracciati al nostro albero. La poesia, forse, si misura sulla quantità di dolore o di entusiasmo che ci vuole per sciogliersi da quell’abbraccio – a molte complicazioni andiamo incontro sia a causa di quell’abbandono sia per il ritardo con cui è avvenuto.
Alla fine la poesia torna sul posto – come si dice, nei romanza gialli, dell’assassino.
L’esaltazione del linguaggio è riconoscibile, in poesia, non tanto nell’andamento trionfante, quanto nel perenne ridursi a zero, per cui i viventi appaiono come continui esseri di ritorno. Infine, per posizione di poesia intendevo questa attitudine ad abitare il luogo, seppur parola, a stare nel suo incavo, per diventare un contenuto, la nostra offerta, l’unica.
La poesia come luogo, abitabile, a lungo – patria, rifugio, capanna del grande gioco, non tanto nel senso di Heidegger quanto nel senso del bambino, a meno che non intendano la stessa cosa, mi ha sempre reso felice e colpevole.
Ecco, abitare|wohnen è la grande parola della quale abbiamo già parlato, con Hölderlin – soltanto che è proibito, che non ci concesso quell rifugio se non come disubbidienza o illegalità.
Dopo i ritrovati della negazione, dopo l’incredulità di fronte al male, non c’è luogo se non di corsa, spazio invece di casa.
A questo punto, stare in posizione significa stare vuoti ad aspettare, significa aprire il cuore. La poesia è dunque la posizione che occupa, la direzione verso la quale guarda – preservando un’aspirazione, perché essa è sempre futura. La posizione vuota (come “la mente che per scaldarsi saltella” – giuro che non citerò mai più un mio verso) significa anche l’attesa del sacro accadere, disturbato o distrutto dalla banda di ottoni dei valori. Essere dentro al linguaggio, tanto da non vederlo più – non era questo il compito della modernità? – entrare nel suo buio, dimenticando l’uscita – esercizio quasi santo, suprema indifferenza, fino a vederne la gioia, solida, senza eccitazione, come l’amore immobile nella sua perfezione stregata.
Deve esserci un patto tra poesia e linguaggio: si sono accordati per una morte d’amore, per la grande eutanasia?
Tu, Marco, hai citato Nanni Cagnone – Nanni dice sempre ciò che io penso e ciò genera il mio stupore, la mia ammirazione – lo dice anche con l’immagine dello “schermo interno delle palpebre…” Pensare che l’interno della palpebra era il telo da cinema su cui il bambino Matteo (personaggio dell’omonimo romanzo senza fine – e lì dai!) proiettava, ogni sera, prima di dormire, il mondo conosciuto.
Ma la poesia, sonno impuro, deve aprire le palpebre, deve sbiancare, nella piena luce, il proprio schermo – le sue figure saranno, allora, “sogni incompleti”, il cui valore è dato, vorrei aggiungere, proprio dalla parte che manca, quella sbiancata dal risveglio – l’allarme che ci fa riconoscere come esseri ancora da compiere, quindi con qualche speranza – ah il wabi-sabi giapponese, che tanto vorrei praticare nel giardino e in poesia.
La poesia è difesa dalla cintura del “non dire”? – attraversare quella cintura significa perdere il linguaggio, fare finta d’averlo perso, per poter passare? Là tace, coperto da parole, il lamento del non detto, ma sappiamo che quella copertura consente la sopravvivenza del nostro agente segreto, l’angelica spia, il suggeritore. Il suggeritore è sempre alle nostre spalle, ci passa il compito in classe, ma non ci lascia voltare indietro – come se il passato fosse ancora da fare, davanti a noi, senza voltarci, compito impossibile.
Ricordi che ho parlato degli scudi? “Chi manda avanti il linguaggio come uno scudo, è uno stronzo” – l’ ho scritto io, vero? Era meglio se stavo zitto. “Dello scudo si fa bello uno dei Sai” – buona occasione per parlare della poesia come di una ritirata! E chi si fa scudo di se stesso? – irridendo l’artigianato della salvezza?
Scusa, mi sto affannando, si sente dal respiro, dalla frase – gatta ci cova!
Angelo
**
Settima lettera. M.E.
Nessun disappunto. Forse un nuovo appunto, ai margini. L’angelica spia? Chissà. Io odoro le cose normali e vedo cosa c’è, fiuto in giro. “E, con questa combinazione Velabus, lei passerà sette giorni magnifici a Rovigno, Zagabria, Dubrovnik, Laghi di Pltvice, le perle dei Balcani, dal 15 al 22 settembre. Imperdibile, cosa dice? Soltanto 890 euro a testa”. Seguo le parole del tour operator. Garantisco l’anticipo. Ora posso non partire, conoscendo a memoria tutto l’itinerario. Se penso alla fatica degli spostamenti, al sudore dei futuri compagni di bus, agli odori esagerati delle ascelle, alle chiacchiere insignificanti delle bocche, mi eviterei volentieri tutto con un magnifico sorriso di sollievo. Ma per ora firmo il modulo, prometto, sorrido. Sarebbe stupefacente se, all’ultimo momento, aderissi al viaggio e tutto accadesse come è previsto che accada. La meraviglia della prevedibilità è in agguato. Come se improvvisamente leggessi Finnegan’s Wake e ogni pagina fosse leggibile come una partitura di Bach. Tutto è straordinario e può accadere. Anche Beckett potrebbe diventare uno strepitoso fumetto, con Stanlio e Ollio a fare Clov e Hamm in Finale di partita. E Keaton restare solo nella parte del tragico guitto in Film. So che non ci capiva nulla di quel testoed era confuso, spaventato. Ma un grande professionista non si tira indietro. Obbedisce. Mostra il suo assurdo coraggio nel seguire vie assurde.
La mia voce? Un rovo nell’orecchio, una spina. Se dovessi rappresentarla musicalmente, mi sarebbe impossibile trascriverla sul pentagramma. Ieri sono tornato a casa. Sul mio tavolo, dove punto i gomiti, guardo il foglio del quaderno. Sopra vidi scritti dei versi:
«Quando tutti i terrestri vagano sotto il cielo, lo
guardano. Leggendo però, quasi come
in una scrittura.
Felice chi trovò in vita
un ben assegnato destino.
Ma se la luce giunge molteplice,
allora è la più innocente»
Vedo la mia stessa calligrafia. Non ricordavo di aver trascritto i versi di Hölderlin sul foglio al centro del tavolo. C’è un grande ordine musicale, nella sua poesia, proprio negli inni dell’ultima fase, prima che svanisse la ragione: una ferma solennità, una veggenza sonnambula, preludio dell’imminente apocalisse. «Chi avrebbe previsto che sarebbe impazzito?» penso fra me e me. Non tento neppure di commentare quei versi: sarebbe superfluo. L’inspiegabile non si spiega: lo si accoglie. Il mondo è informe, interminabile. Se almeno ricordassi bene se io sono io, se il mio nome abbia un senso. Rifletto alla tua nuova versione di una poesia di Friedrich: «Ciò che resta (che avanza) lo fondano (lo offrono) i poeti». In sintesi «Ciò che avanza lo offrono i poeti». Un dono umile, inafferrabile.
Psichiatra, scrittore, critico, amico. Ma, da ogni casella dove sosto, scatto via rapido, con una mossa silenziosa. Chissà perché! E poi, chi insegna a chi? Nessuno si accorge che non sono più dov’ero: è il momento in cui posso scegliere una taverna nel centro storico, mangiarmi un piatto di ravioli di pesce e, dopo, fumarmi un cigarillo in santa pace davanti al grande globo di vetro del Porto antico. Genova come uno specchio opaco, dove molte vite mi aspettano, e non la mia. Odio le biografie da quando ho capito che ricordare se stessi è come decorare un cadavere. Si vive per vedersi rifratti dalle parole. Come scrivi tu: «Quale sarà la vera forma di Pane e vino? La bella copia prima delle varianti? Il fatto che Hölderlin non abbia ricopiato Pane e vino un’altra, ultima o penultima volta, depone a favore d’una poesia atomistica, una poesia delle componenti, delle schegge, dell’inconcluso?».
**

Angelo Lumelli

Marco Ercolani
