(2023)
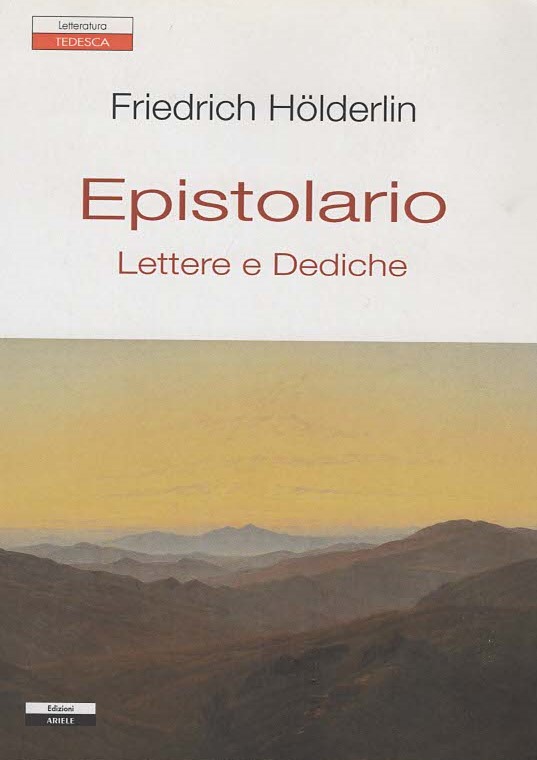
Non è strano: la poesia è senza parole. Le poche che trova, la catturano interamente, senza lasciarle nemmeno una sillaba per farsi sentire. Angelo Lumelli
Restare appena dicibile praticando una scrittura interminabile. Marco Ercolani
**
Terzo capitolo. Lettere 17-22
Diciassettesime lettera. ERCOLANI
La ferita del linguaggio. Ma non sentire il lamento dei feriti, come se l’intera orchestra fosse coperta da strati di neve e ogni musicista suonasse il suo strumento con bella ostinazione, nonostante il silenzio. Ricordo un poeta russo, si chiamava Muni: lo evoca Chodasevic in Necropoli. Muni invidiava il fumo perché sentiva di essere solo “l’ombra del fumo”. Nessuno ricorda un suo verso, dicono che morì suicida. I suicidi hanno molti diritti: il primo è evitare che il mondo, per loro, continui in forme inaccettabili. Si guarda il buio dentro una stanza, con ansia. L’ansia è rendere la stanza il luogo reale in cui compiere una fine che ci si ostina a rimandare, per ottime ragioni. Una volta morti, si resterebbe orfani del pensiero di morire. Orfani? A raccontarci, di noi? E in che modo? Oscuro o chiaro? È facile scrivere oscuro ed essere illeggibile, più difficile scrivere semplice e restare illeggibile.
Ricordo un artista che si chiamava Felicien Marboeuf, un raffinato intellettuale amico di Proust. Marcel gli aveva fatto leggere alcune pagine di All’ombra delle fanciulle in fiore e lui aveva commentato, con lettere struggenti, quanto fosse un delicato segno di bellezza coltivare per le giovani adolescenti un amore segreto. La passione per corpi diafani e innocenti non deve realizzarsi in rapporti carnali. Qualcuno riferisce che Felicien Marboeuf, diversi mesi dopo, fu condannato a dieci anni di prigione per aver molestato due bambine, di otto e nove anni. Proust, chiuso nella sua stanza a scrivere, non seppe mai nulla né di lui né dell’atto imperdonabile che aveva tradito quelle lettere ricche di grazia. L’innocenza è necessaria, più di quanto crediamo.Come quando si torna allaprima pagina e la voce inizia a narrare. All’inizio. Ma di quale inizio? Io, a causa della mia professione, ho sempre poggiato l’orecchio a terra per sentire i suoni imminenti delle voci altrui. Non volevo udire soltanto la mia: restare prigionieri di se stessi inaridisce. Mi è necessario dissodare altri campi, le cui coltivazioni sono simili alle mie ma non uguali. Lo sai? Il libro che rileggo di più, a tratti, è l’Opera filosoficadi Novalis. Tra quel libro e lo Zibaldone di Leopardi scelgo senza un attimo di esitazione Novalis, e qui lo cito per te: «La forma casuale, ovvero singolare, del nostro Io, resta soltanto per la forma singola – la morte fa cessare soltanto l’egoismo. La forma singola resta soltanto per l’intero, nella misura in cui era divenuta universale. Noi parliamo dell’Io – come di uno, e sono però due, assolutamente diversi – ma assolutamente correlati. La casualità deve scomparire, il bene deve rimanere. Il casuale era casuale, l’essenziale resta essenziale. Ciò che ami ti resta».
**
Diciottesima lettera. LUMELLI
Grazie mille, caro Marco. Ah come l’hai detta giusta! – “scrivere semplice e restare illeggibile”. Così si fa nel covo della poesia. Non perché la poesia sia difficile, ma perché conduce un’esistenza illegale – e allora diventa come la casa di Merleau-Ponty (In senso e non senso) – non guardata da un punto di vista, ma da nessuno in particolare, quindi una casa troppo desiderosa di tutta se stessa, a rotta di collo, da tutto l’orizzonte.
Ciò non è diverso da chi ha un punto di vista fisso, testardo, quello e nessun altro. Quel punto di vista è condannato all’esilio, proprio perché ha osato esserci, da vivo. Lo stesso vale per il passato. Il passato, in quel suo momento, fu vicino al proprio futuro, del quale serba la traccia.
“Cosa fatta” a volta si compiace di avere sventato tutto il resto, a volte ha motivo di struggente nostalgia. Tutto ciò è normale in poesia – come chi, ammutolito, rappresenta ciò che sia parlare. Stranamente, in modo oscuro, sento che tutto ciò è incamminarsi verso Novalis, che tu citi per me.
Alla fine i poeti sono innocenti, anche giocando ai dadi. C’è un’affermazione, nella tua lettera, che cade dove la mia pelle è più sottile. Lì urto sempre – con qualsiasi cosa. “L’innocenza è necessaria, più di quanto crediamo. Come quando si torna allaprima pagina e la voce inizia a narrare. All’inizio. Ma di quale inizio?”
Io ho una mezza pagina che ha cambiato posto mille volte, ora volendo essere romanzo, ora un saggio sul romanzo, altre volte una richiesta di perdono, altre volte ancora una pubblicità immobiliare. Contro ogni ragionevole principio, te la mando – sperando che tu mi possa aiutare, costringere…
“Amo pensare a un romanzo nel quale, arrivato davanti a una vecchia casa con l’intonaco consumato dagli anni, il personaggio dirà: “Difficilissimo fare un intonaco nuovo scrostato”. Questo personaggio intende dire che soltanto l’accaduto esiste e che questo non è ammissibile? L’umidità l’ha fatto sollevare l’intonaco, qua e là ci sono tracce di verderame – prima ancora c’era una vite, un pergolato di uva fragola? Il romanziere non ci mette niente a fare un muro scrostato, nel caso ombreggiato da un possente glicine, prova ulteriore che il tempo c’è stato davvero, lunghissimo, tale da consentire al tronco di attorcigliarsi in grandi volute, strette come corde. Questa riparazione è bastevole? Ha preso due piccioni con una fava? Il problema è che questo romanziere ci crede davvero, alla lunga – ha bisogno di crederci, come il lettore – allora, incoraggiato da quella concordia, dagli stessi intenti, comincia a narrare, velocemente, e l’altro a leggere, incontrandosi su quelle pagine. Guai se il grave problema, come l’orco nascosto nelle fiabe, non viene evitato: in quel caso il linguaggio si mangia i più bei racconti in un boccone, avanzando verso il lettore, interdetto – come chi si è portato in casa uno sconosciuto, che improvvisamente non dice più una parola, lo guarda, fisso, con gli occhi azzurrini, tipici, che sembrano vuoti, trasparenti, al punto che l’imbarazzo è insostenibile – allora, con buone maniere, questo lettore – è di lui che si tratta – lo accompagna alla porta, avendo, come unico compenso, una strana storia da narrare!
Il primo passo diventa tale perché è avvenuto il secondo, quindi con cosa cominci, legittimamente? Io, quando si tratta di incominciare, comincerei sempre da dopo. Alla fine per fare un romanzo bisogna scrivere la prima frase, sempre indegna, alla quale devono seguire migliaia di frasi, al fine di renderla legittima, o ancora meglio, dimenticata, sepolta dagli eventi, tanto è grave la sua pretesa, tanto è grave l’avere iniziato. Sventare l’inizio! – ecco che ci risiamo, sommergerlo con il seguito immane.”
Marco, io non ho la pretesa di fare il tuo mestiere, ma a me sembra un bel caso.
Angelo.
**
Diciannovesima lettera. ERCOLANI
In un mio antico sogno ricordo che ero un oratore greco; balbettavo, preda di una bizzarra afasia; ma poi, di colpo, sollevavo il braccio e intonavo il discorso con la voce che mi usciva fluente dalle labbra. In quello stesso momento, a pochi metri da me, rannicchiato sull’orlo di un precipizio, un vecchissimo saggio sussurrava che non è più necessario: “L’uomo ha smesso di esistere e quanto rimane di lui sono questi sassi. dipinti dalla sua mano come bocche spalancate. Non ti affannare più”. Interruppi il mio discorso, lasciai la città: che cosa ci facevo ancora in quel tempio? Avrei fatto l’oratore, come mi auguravo da sempre, e le mie parole avrebbero percorso il mondo, ma come dimenticare le parole del vecchio? Non potevo. Ma da allora seppi che ogni discorso era illegale, perché veniva da un’afasia, e pronunciarlo era sempre un inizio che non avrebbe avuto fine.
Incominciare da dopo, dici tu. Nascondere la prima frase fra le altre. Mi è capitato di farlo, in certi racconti, come a dare spazio ai piccoli enigmi del narrare, necessari per creare nel lettore la sospensione dell’incredulità. Ho sempre desiderato che la parole viva, anche se destinata al nulla, fosse pulsante, anche se pronunciata nel deserto, un pezzo nel mio “discorso contro la morte”. Tutti i progetti umani vanno in polvere, ma la polvere è “pulvo inamorado“. Ci siamo noi, viventi, dietro ogni cosa. Un intonaco nuovo scrostato possiamo inventarlo: ogni cosa è inventabile, niente è imbarazzante. L’imbarazzo inizia quando vogliamo essere semplici trattando il mistero della poesia. Ma, come diceva Maurizio, “la parola è il pianeta che rende possibile ogni cosa. No, non aveva letto quell’aforisma in un libro, leggeva in modo disordinato, aveva lavorato per trentacinque anni all’Italsider, ma da vero matto voleva inventarsi un suo giardino, ripido, inaccessibile, soltanto suo, nel quale avrebbe vissuto scomodamente, in modo selvaggio, ma con la libertà di essere se stesso.
Ah, sì, viaggiare nelle teste altrui! Il mio viaggio non è mai casuale. Il mio nomadismo ha tende fisse. Sono vicino soltanto a persone che tengono la porta socchiusa, se non spalancata, che cercano il mondo non per abitarlo da conquistatori ma per viverlo da straccioni, per ospitarlo in sé e mettersi a soqquadro. “Arrivano i barbari”, e sorridiamo con gioia. Cosa avremmo fatto senza di loro? Noi non siamo Ulisse se non quando il navigatore si smarrisce nel viaggio. Però lo ammiriamo per come ha voluto affrontare le Sirene: pensare di udire le loro voci letali, salite dalle rocce, restando a bordo della nave, stretto dalle corde, urlando ai compagni che non lo sciogliessero, evitare di inabissarsi verso chissà cosa, morendo incantato (in spagnolo si dice encantado di un uomo pietrificato, desencantado di un uomo libero). Pensare di udire ma non udire. Solo dopo quell’episodio Ulisse, le orecchie offerte al canto possibile, sarà, per se stesso ma non per i suoi compagni, chi non ha udito. Uno che, per convenzione, chiamiamo poeta. Ma anche il matto ha il potere, come i poeti, di udire (fantasticare?) da solo…
**
Ventesima lettera. LUMELLI
Ordunque, mi viene da dire, caro Marco, donc – ergo quindi perciò…con queste particelle ah Cartesio! vorrei cominciare un poema, onde sfatare tutte le fate che trasformano ogni essere in ciò che vorrebbe – ma noi non vogliamo rinunciare alla nostra scarsità, quella che ci consente di essere ospitali, di accogliere il forestiero che conosciamo dall’andatura, da lontano – il passo di colui che cammina, non di colui che soltanto arriva, perché la meta d’arrivo trasforma la partenza, l’afferra da lontano, suggerisce la misura del passo, anzitempo l’interpreta…le fa dire più di quello che sa…
Anni fa, tu mi hai mandato un poema, un poemetto, dal titolo Non tornare è la grazia. Tratta del ritorno – di Ulisse, per non essere da meno – di un eroe che ha capito come il senso non sia mai un arrivo, ma un transito, per cui quando il transito è finito è finito anche il senso nascente. Allora ti scrissi una lettera – sono passati un po’ d’anni – la quale, con minima esegesi del tuo testo, pur non avendo niente contro Penelope, stava decisamente dalla parte di Ulisse: Itaca, mentre s’avvicinava, copriva con la presenza la lunga fuga dalla morte, il dribbling con il destino, la nascita perenne: era la fine del poema. Per ragioni che mi rimangono oscure – la cosa non mi allarma – avevo citato, in quella lettera, una parola in dialetto delle mie parti: feitò – nella suggestiva pronuncia dei vecchi, gli unici autorevoli ed autorizzati. Spiegavo che feitò era ben più che fatato (come, ad orecchio, sembra significare) – significava, piuttosto, conciato, trattato con arte e destrezza, in modo da non sentire dolore, una funzione anestetica, riferita per esempio ai calli sulle mani dei contadini, usi a maneggiare zappe, vanghe, roncole…
In pratica: la meraviglia di non sentire dolore, lo strano silenzio tra grida immaginarie… E qui siamo ad un punto cruciale del tuo poema. In breve, sulla base delle parole che riporterò tra poco, avevo inteso che le Sirene non avrebbero cantato, che invano Ulisse stava aspettando, legato all’albero della nave, come da tradizione… I suoi compagni invece, in quel silenzio, con le orecchio tappate, si figurano quel canto terribile, l’urlo di loro stessi, fino ad impazzire.
Mentre la nave oscilla e il sonno si avvicina resto sveglio. Le sirene potrebbero, invisibili, cantare…
…
Se dormissi anch’io, sentirei.
…
Dovrò essere sentinella | del canto futuro, | sentinella | del presente silenzio.
…
Le sirene non cantano ma i miei uomini | sì e folli | per sempre | le strida degli idoli neri emersi dall’acqua | udranno | ignorando che quelle | e solo quelle rispecchiano le loro voci, | sono le loro voci vibrate contro | l’assalto temuto.
…
Le corde mi legano all’albero, | libero di udire dondolo, folle fingo di udire, | ma le sirene sprofondano | e loro, senza sapere, trasformati, scorticati,| non continueranno il viaggio, | impazziranno in mezzo alle grida…
Caro Marco, questo episodio, novecentesco, mi aveva molto colpito, mi sembrava, tra l’altro, un trattato di poetica, adatto ai nuovi dolori umani, ai fantasmi del dolore contro i quali soltanto uomini feitò |incalliti potevano essere all’altezza. Rimanere svegli per poter sognare, senza diventare grido di sirena.
I trucchi sono tanti per vivere, sopravvivere. Il tuo poema, tuttavia, pone anche altre questioni, in quanto, rifiutando il ritorno, rifiuta il poema stesso, il quale tende alla fine – è attraverso questa tensione che il poema passa da vicenda a vicenda, in un disordine ordinatissimo, mai diventando ostaggio di un evento, ponendosi come il poema dell’attraversata. Sono vittime delle sirene coloro che non possono udirle: è allora che esse cantano.
Angelo, desencantado?
**
Ventunesima lettera. ERCOLANI
Angelo,
“lo strano silenzio, tra grida immaginarie”. Qui tu descrivi con esattezza la follia. Nel 1994 scrivevo un racconto su Artaud, ti cito le pagine finali:
«Conosco i colpi del linguaggio che cozza dentro di me e che gli impresari della letteratura vorrebbero disporre in croste di saggi, in gusci di romanzi che si conservino, schegge che non puzzano, non appestano, non sputano, non feriscono, non mandano a puttane la cosmografia del cielo e l’ordine degli equinozi, come le nuvole di El Greco e le visioni di Lautréamont: croste e gusci che mi chiudano nell’ineluttabile servitù della parola, nella sciocca ripetizione del suo rito, quando lei è solo insurrezione dal nulla che vomita i suoi intestini contro ogni legge, oggi e per sempre, fiume in piena che non potrà più essere arginato perché non ci saranno romanzucci e paginette a frenarlo, e tutto sarà bagnato di utopia fino al collo, e il vortice gorgoglierà, indocile, fino a prorompere in un’orda di lemuri e di vampiri, gli stessi che mi assediano goccia dopo goccia, notte dopo notte. Mi è diventato impossibile vivere avendo sul ventre questi incubi che passano il loro tempo ad arrotolarsi nei miei organi, fino a togliermi, per intrusione magica, il possesso del mio stesso corpo. Siete tutti colpevoli, miei piccoli, miserabili Barrault: tutti proteggete l’assenza di quel blocco scuro che afferra la gola e permette alle parole di uscire dalla bocca non evirate, non immiserite dal fuoco che le ustiona, non ridotte a stato di demenza – ricordi, angelo ribelle, sconvolto Baudelaire, la tua afasia? Ma io mi difenderò, io il cuore lo salverò dal nodo della congiura di chi mi impone di fare arte che sia solo arte, assassina della mia vita vivente. Forse lo salverò apparendo a tutti voi stupido e vuoto, facendo il trickster davanti a un microfono e imitando le tue sublimi pagliacciate, se mi sarà concesso non irritarmi più di quanto io possa spaventosamente irritarmi!»
Perché te le cito? Il mio racconto ha quasi trent’anni, ma non è invecchiato. Di parole non evirate abbiamo sempre bisogno, di un cuore che pulsi libero. Il tuo ha sempre pulsato così nel “folle volo” di un Ulisse inclassificabile e traditore, sempre lanciato verso la mèta ulteriore. Inconsapevole, anticipava il mito di colui che camminò nella neve e nel sole, Robert Walser, cercando di sparire? Anche noi siamo sulle orme di Robert? O su quali altre orme? Ti lascio con le parole di un amico: «Marco Ercolani è un poeta? Ed è un poeta significativo? Si può dire senz’altro di sì. Ma a patto di condizionare questo sì a un’idea molto ampia del mandato poetico, estendendola anche a chi, come Ercolani, appunto, è un ossessionato osservatore d’ombre per il quale non è necessario esprimersi in versi. Tenterò, pur brevemente, di spiegarmi. Dal mio punto di vista, Ercolani è più poeta dei poeti – tranne ovviamente i Sublimi – pur non avendo quasi niente a che fare, lui, scrittore di prose così radicalmente eccentriche e sui generis, con il mestiere-genere di poeta».
**
Ventiduesima lettera. LUMELLI
Caro Marco, tu che hai curato il linguaggio, che l’hai visto stravolto dai dolori, penso tu abbia tentato ogni modo per tranquillizzarlo, per non farlo spaventare – anche con pastiglie, sedarlo – quando la parola è un gesto, urgente, senza differirsi attraverso la rappresentazione – allora, quando essa diventa rossa di collera, verde di bile, nera (Caligaverunt oculi mei, quando perfino la liturgia s’impietosisce e diventa terapia) – ecco, ancora una volta mi rivolgo ad Hölderlin, alla sua traduzione dell’Antigone che tanti hanno deriso: Cosa c’è? Perché pronunci di rosso una parola? – (calcaìnais’ èpos/rossoporpora parola).
Il tuo saggio amico, che non conosco, parla del “mandato poetico” che tu estendi oltre il rito del verso, direi fino alla guarigione dalla poesia, allo sguardo dalla riva – quello che può sapere perché può ricordare. C’è una spregevole voluttà, una voglia di sangue, nel circo – come chi invidiasse il dolore, la morte che non lo degna di uno sguardo. a mente deve sanguinare di salvezza: ecco cosa significa l’estensione del mandato.
Videte, omnes populi, | si est dolor similis | sicut dolor meus. Fa parte della liturgia delle tenebre, nella settimana santa – l’autore è Tomàs Luis de Victoria (XVI secolo).
La poesia ricostruisce il proprio rito ogni volta – quindi a che servono le antologie? Mi ha sempre affascinato l’idea di un arco trionfale in mezzo alla campagna. L’ho immaginato da bambino, nei campi di grano, di mais. Passarci sotto aveva qualche oscuro significato, un po’ felice e un po’ no – non garantisco d’averlo capito, tanto più adesso. Immaginavo che le donne anziane, un po’ streghe, dicessero: guai a passarci sotto, guai all’imbrunire!
Rimango dell’idea che le sirene cantano per chi ha paura di sentirle. Altrimenti stanno zitte, ma noi rimaniamo da soli. Ecco i guai della salvezza. La porta stretta del linguaggio è piantata in mezzo alla pianura delle parole? Passa nove volte fuori dall’arco trionfale, la decima passa sotto – è questa l’arte del verso? la sua cura?
Ti ricordi la magica parola: feitò? Un uomo incallito vorrei essere. Immagino anche te, che esci nelle tempeste del linguaggio degli altri. Insieme ad Artaud. Oggi, dopo tutto, vorrei scrivere una poesia in lode delle cose che non posso essere, una grande pietra erratica, l’apparizione dell’albero. Mi accontenterei di essere un loro detrito, la parte friabile che si commuove.
Con tutto il cuore. Angelo


