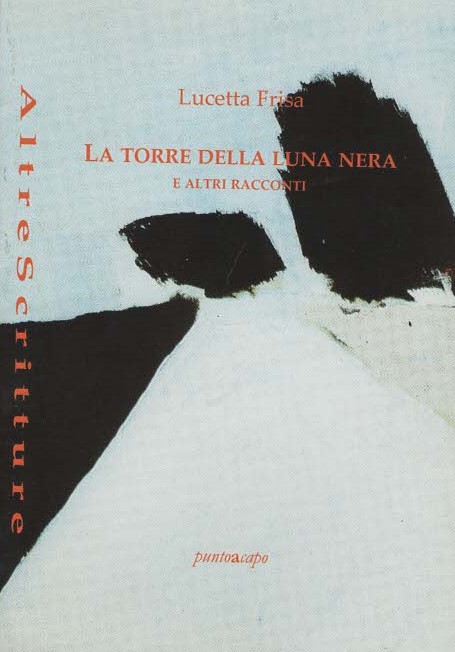Francisco Goya, Perro enterrado en arena, 1820-1821
**
Lettera a Francisco Goya. Madrid, 25 novembre 1823
Illustre Maestro,
mi permetto di indirizzarVi questa lettera, affidandomi alla Vostra compiacenza. Vi prego quindi di perdonare la mia ingenua curiosità. Ho avuto il privilegio, un giorno, di penetrare, insieme a certi amici, nella Vostra Quinta del sordo. Gli amici – che Voi conoscete ma dei quali preferisco tacere il nome – mi avevano sconsigliato di accompagnarli. Sostenevano che quanto avrei visto non era “cosa da donna”, e per di più giovane come sono io. Ma, alla fine, il mio carattere ostinato prevalse sulle loro obiezioni.
Davanti a quelle pareti, la commozione e l’orrore mi sconvolsero. Non vedevo solo un capolavoro di arte nuova, ma anche una lezione di realtà la cui potenza tragica mi era sconosciuta. Nessuna opera pittorica, finora a me nota, le assomiglia. Ed è cosa ancora più sorprendente per chi è abituato ad ammirare lo splendore dei vostri ritratti e dei Cartoni per gli Arazzi. È il lato oscuro e bestiale di questa società e dell’uomo in quanto tale, oppure ciò che rappresenta è frutto di un incubo, di uno strazio, di un’insonnia protratta oltre le umane possibilità?
La domanda che più mi preme è quindi questa: fino a che punto, illustre Maestro, le Vostre Pitture Nere rispecchiano il reale e quanto l’immaginato? Perdonate questa domanda ingenua, che da troppo tempo mi assilla e a cui gli amici hanno risposto in modo evasivo: solo per tranquillizzarmi, io penso. Di questo genere di tranquillità faccio volentieri a meno. La seconda domanda riguarda in particolare un affresco: è quello del cane, tutto solo, separato dalle altre pitture notturne e diaboliche che lo circondano. È in bilico tra la vita e la morte? C’è chi dice sia sul punto di sprofondare dentro una voragine, forse trascinato da un’onda marina, da un’alluvione o da una frana che a una creatura fragile come lui può essere fatale.
È così? Non so perché, ma mi ricorda Tito, il figlio di Rembrandt, che il pittore ritrasse tra i suoi libri, appoggiato al banco di studio come da un balcone. Un’apparizione che emerge dal buio, dolcissima, e che sappiamo fu molto breve sulla scena della vita. Vi parlo di Rembrandt, illustre Maestro, perché solo alla Sua grandezza posso accostare la Vostra. Ricordo i Vostri animali: quelli che circondano Don Manuel Osorio de Zuniga nella sua stanza: i gatti affamati e maligni, la gazza ammaestrata, i cardellini in gabbia, come pure il bel cavallo di legno nerissimo di Pepito Costa y Bonelis. Ma soprattutto il meraviglioso quadro di Maria Teresa Cayetana de Silva, duchessa d’Alba: al suo fianco destro c’è un cagnolino bianco che sembra un giocattolo anche perché porta un nastrino rosso nella zampa posteriore destra, fiocco uguale agli altri fiocchi rossi della sua padrona.
Quel gesto però, quel misterioso indice puntato della duchessa, a chi è diretto? Al cane che dovrebbe obbedirgli o a qualcun altro, fuori dal quadro? Così come ricordo un cucciolo-giocattolo dal musetto nero, della Marchesa de Pontejos. Immagino siano le signore a trattarli così e Voi mostrate questo comportamento femminile, raffigurando cani e padrone, nella stessa posa vezzosa. Gli altri cani dei Cartoni, sono ben diversi, molto più naturali. Dormono, abbaiano,partecipano. Cani da strada che nessuno coccola e protegge e forse instupidisce.
Penso anche ai vostri ritratti di bambini, figli di ricchi e di nobili, col peso dell’eredità familiare e del futuro sulle loro spalle esili. Non ridono mai, sembrano consapevoli di ereditare qualcosa che li allontanerà per sempre dalla gioia. Quella dolce libertà che li accomunava ai cuccioli viene imprigionata dal ritratto stesso. Quei ritratti segnano dunque anche la fine dell’infanzia e Voi, Maestro,sapete dipingere la malinconia infantile, molto più struggente di quella adulta.
Nei dipinti mi piacciono in particolare certi segnali allusivi – il loro linguaggio segreto che appartiene alla poesia. Il silenzio di quei gesti è un alfabeto che solo un poeta sa decifrare. La poesia dei segni ci comunica un senso di sospensione, come quegli occhi che non smettono di seguirci facendo abbassare i nostri: vorremmo fuggire via da loro, per non sentirci nudi. Rendere gli occhi così vivi e persecutori è creare l’illusione di un altro mondo, di una traiettoria che unisce sguardo a sguardo, in un’intesa enigmatica al di là del tempo.
Così il piccolo Tito e quel piccolo cane sono guardiani di una soglia tra un mondo e l’altro. Appaiono qui e già sono sommersi. Vorrebbero restare aggrappati a questo limite sabbioso, ma si oppongono con tutte le loro forze – o si abbandonano? – a qualcosa che li spinge al di là. Al contrario, certe creature angeliche, certi fanciulli divini che ignorano il dolore e la terra, stanno nei quadri solo per ricordarci di conservare la nostra anima in un’infanzia eterna.
I miei amici hanno discusso tra loro se l’affresco del cane fosse o no compiuto. Io penso che – comunque sia – quel cane de La Quinta del Sordo ha un potere di suggestione straordinario, forse proprio per quel senso di incompiutezza che suggerisce. Che cosa c’è, nella vita umana, di compiuto? Si illude chi crede di concludere un’opera nel corso della vita. Non illudersi è restare più vicini alla realtà. Vedere n’opera nell’attimo che ci è concesso di vederla è come ascoltare il racconto di Shéherazade che si interrompe all’arrivo della notte per ricominciare la notte successiva: tutto è racconto senza inizio né fine.
E poi, non siamo noi, gli umani, ad avere molte caratteristiche canine? Anche noi soffriamo, ci emozioniamo, amiamo, siamo schiavi di padroni, ci rallegriamo e rattristiamo per un nonnulla, non sopportiamo la solitudine, patiamo la fame e la paura, amiamo tanto la nostra dimora quanto l’aria aperta, e una carezza ci solleva mentre la sua assenza ci sprofonda.
Forse noi stessi abbiamo cuore, sangue e nervi ancestrali, in parte analoghi a quelli della razza canina.
Solo Voi, Maestro, avete saputo turbarmi così tanto con quella figurina solitaria e disperata. Più disperata di quelle nere e orribili figure che lo circondano. Quelle creature nere credono al diavolo e gli dedicano sacrifici. E forse il diavolo – ammesso che esista – andrà in loro aiuto. Ma il cane? Il cane non si affida né al diavolo né a Dio. Quel cane non ha il conforto o l’illusione di un aldilà. Chi è più degno di commozione e d’amore di lui?
E ora, Maestro, Vi confiderò una mia personale debolezza; sento di poterlo fare con chi, nella magia di una piccola figura, ha scatenato nel mio animo emozioni e inquietudini tanto forti. Sicura che non riderete di quanto sto per dirvi, se è vero che la sensibilità di un artista è simile, in qualche modo, a quella di una donna o di una ragazza come me.
Ogni volta che vedo un cane, una fitta come una lama finissima di coltello mi attraversa il polso e raggiunge il palmo della mano. Anche osservando il Vostro cane dipinto, questo bizzarro fenomeno si è ripetuto. Dante Alighieri diceva che la visione della sua amata gli faceva tremar le vene e i polsi. Forse – mi dico – nelle vene e nei polsi passa una debolezza particolare che accomuna il senso dell’amore a quello della natura creaturale.
Mi sento così vicina a tutti quelli che vivono, godono e soffrono e non sanno perché, e neppure se lo chiedono e neppure lo potrebbero. Chi, se non i bambini e gli animali? Chi, se non i poveri, gli offesi, gli ignoranti, i diseredati? Loro sono ancora dentro di noi, come lo è la nostra infanzia, l’inizio indifeso e inconsapevole della vita. Ma loro, al contrario dei bambini, un futuro non l’avranno mai. E Voi, Maestro, in pochi tratti di pennello avete espresso quello che nasconde la nostra cellula più antica e che nessun altro artista ha saputo far risuonare nel profondo.
Vi ringrazio umilmente di questo dono che non ha prezzo.
Vostra devotissima
Maria Dolores Cardillo de Cordoba
*Il testo è tratto da: Lucetta Frisa, La Torre della luna nera e altri racconti, Puntocapo, Novi Ligure 2012.