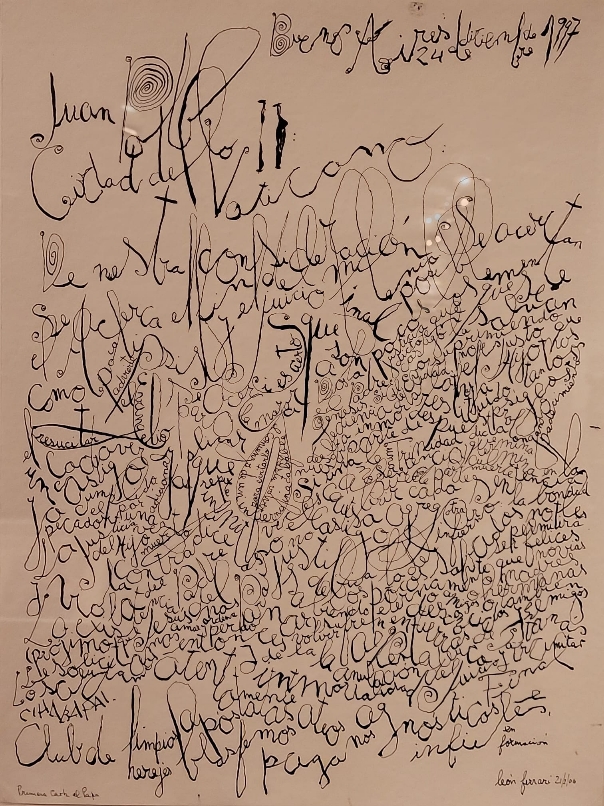
Léon Ferrari
**
Chi era quell’uomo che, in una prima mattina di luglio, scese a Ponte Ronca dalla corriera proveniente da Bologna proprio il giorno dell’inaugurazione della Festa Grossa del ‘38? A prima vista poteva sembrare un attore, un prestigiatore, un alto dignitario reale se non un bizzarro impostore. Elegante e azzimato com’era, con in testa una bombetta così fuori dal tempo, indossava un panciotto damascato multicolore, il cravattino nero, i pantaloni del tight da cui uscivano due scarpe bicolore di vernice, pareva un agente delle pompe funebri improvvisamente impazzito.
Gli avventori del bar Centrale lo guardarono passare e, sogghignando, pensarono si trattasse di un nuovo imbonitore pronto a vendere ai più ingenui un elisir di lunga vita. Era sceso dalla corriera senza un vero bagaglio da forestiero, portando con sé soltanto un tavolino pieghevole di legno e uno sgabello, anch’esso pieghevole, con la seduta di tela. Non doveva avere più di quarant’anni, il viso fresco e la barba curatissima sembravano contraddire il colore dei capelli precocemente brizzolati. Gli occhialetti rotondi da miope gli conferivano un’aria intellettuale. Sotto il braccio stringeva un pesante libro con il dorso di cuoio e la rilegatura in cartone marmorizzato.
Senza dire una parola, senza chiedere informazioni a chicchessia, s’incamminò per la stradina che costeggiava il torrente Ghironda che, in realtà, di torrente aveva ben poco, era niente più che un fosso di pianura dove, qui e là, starnazzavano alcune anatre. Oltrepassò la chiesetta della Madonnina, il portico dei Desideri, prese la strada che portava alla Festa Grossa come chi sa esattamente dove andare.
Giunto nella piazzetta dove alcuni zingari stavano finendo di montare la giostra, si fermò a guardare. Il tiro al bersaglio era già stato montato e un omino coi baffi dalla pelle scura stava posizionando i cerchi concentrici rossi e bianchi dove, di lì a poco, avrebbero sparato con carabine caricate ad aria compressa. Dopo aver salutato il donnone che ordinava in file perfette le seggioline del teatro dei burattini, si guardò attorno e aprì il suo tavolinetto tra il tiro al bersaglio e il teatrino. I pochi astanti non potevano immaginare l’ilarità che avrebbe suscitato, nel pubblico che stava per arrivare, il grande cartello che appose con due puntine da disegno sotto il suo tavolo. Scritto con caratteri vagamente gotici, in buona calligrafia, riportava quanto lo sconosciuto aveva da offrire agli uomini e alle donne della Festa Grossa: SI VENDONO PAROLE, PAROLE UTILI E RISOLUTIVE PER TUTTI, PREZZI MODICI E PER TUTTE LE TASCHE.
Alle dieci del mattino la festa era già animata da forestieri, paesani e gente dei dintorni, ragazzi, bambini e famiglie vestite a festa. Molti erano venuti da Crespellano, da Bazzano, alcuni perfino da Savigno e da Ponte Samoggia. Lo strano uomo con la bombetta era diventato l’argomento principale di conversazione e oggetto di dileggio, scherzi e sfottò. L’unico che sembrava disinteressarsi di questo trambusto era proprio lui, lo sconosciuto, che continuava imperterrito e imperturbabile a leggere il suo libro come se il mondo attorno a lui non esistesse, come se stesse leggendo in un luogo desolato e deserto. Nessuno aveva osato chiedergli qualche spiegazione. Domandargli magari perché qualcuno avrebbe dovuto pagare per qualcosa che è alla portata di tutti, liberamente e gratuitamente, come le parole. Nessuno gli aveva chiesto cosa potevano avere di così speciale le parole che lui creava, tanto da dover essere pagate.
A dire il vero, qualcuno c’era, tra il pubblico della festa, che avrebbe pagato volentieri per alcune parole. Spartaco Landuzzi, un giovane tornitore figlio di una socialista e di un anarchico, quando vide il cartello affisso sotto il tavolino pensò, senza punto stupirsi, che avrebbe pagato bene, in lire sonanti, la parola Libertà e ancor di più la parola Socialismo. Avrebbe dato volentieri tutti i soldi che aveva in tasca per ascoltarle risuonare leggere e passare di bocca in bocca. Quelle due parole ormai era possibile sentirle solo in galera, nelle aule dei tribunali o sulla bocca di qualche fascista come un insulto o una bestemmia. Un’altra persona che avrebbe comprato con tutto il cuore qualche parola dolce era Isolina.
Isolina era scesa due anni prima dai monti di Monghidoro per andare a servizio dai Marabini. Vent’anni, seconda elementare non finita, sapeva bene di non essere particolarmente avvenente. In realtà non era né bella, né brutta. Isolina avrebbe pagato chissà quanto per le parole “Come sei bella!” oppure “Ti amo”. Avrebbe lavorato gratis di buon grado per un anno intero per quelle poche parole, purché, ovviamente, fossero uscite dalla bocca giusta e, soprattutto, con l’indispensabile sincerità.
Verso mezzogiorno, quando lo sconosciuto aveva ormai letto molte pagine del suo librone, gli si avvicinò un bambino di circa nove anni. Era solo, malamente vestito e cominciò a guardare con una certa insistenza l’uomo che vendeva parole. Questi se ne accorse e, posto un segnalibro, chiuse il volume e osservò il bimbo in modo interrogativo.
-Senti un po’ tu…- prese a dire il piccolo – Io te la comprerei una parola, ma non ho il becco di un quattrino. E poi, se non è la parola giusta… che cosa me ne faccio?
-Le parole le vendo, io, mica le regalo. Se non hai soldi che cosa puoi offrirmi in cambio? Io non lavoro gratis!
Il bambino, per tutta risposta, gettò sul tavolinetto la sua fionda. L’uomo la prese in mano e la osservò con cura. Era una bella fionda, in legno di bosso, il manico era istoriato con ghirigori fatti ad arte col coltellino.
-E’ un oggetto troppo bello, non ho parole così preziose da poterti dare in cambio. Tutt’al più ti posso dare una, anche due parole, per averla in prestito fino a domani. Domattina, torna qui e io ti restituirò la fionda. Anzi ti regalerò anche una parola in più. Va mo là!
Il bambino sorrise e disse che era d’accordo. Intorno a loro si era formato un capannello di gente curiosa che aveva assistito al loro colloquio, sottolineandolo con risatine e sberleffi che, tuttavia, non avevano minimamente turbato i due soggetti intenti al loro strano negozio. L’uomo guardò ancora la fionda, poi fece cenno al bambino di avvicinarsi e di tendere l’orecchio. Coprendosi la bocca con la mano, il venditore di parole gli sussurrò qualcosa all’orecchio e lui, non appena la udì, lanciò un piccolo grido come quando si incontra una meraviglia davvero inaspettata. Il bimbo, che era di Ponte Ronca, lo conoscevano tutti come un cinno un po’ sventato ma piuttosto sveglio e per nulla ingenuo, così il suo stupore generò vero stupore, anche se non proprio sconcerto, tra la gente che si era radunata attorno a loro. Il maestro Bonazzi, che lo aveva avuto in classe per i primi due anni delle elementari, lo prese per un braccio e gli disse in modo che tutti sentissero: – Insomma, che cosa ti ha detto quell’uomo?
Si fece un gran silenzio. Il bambino scosse la testa come spaventato da una simile richiesta.
-No, no, no, non posso dirlo. Davvero! È un segreto. Non posso dirvelo, credetemi, per niente al mondo!-
Si divincolò dalla presa del maestro Bonazzi e, nello sbigottimento generale, corse via e lasciò in tutta fretta la piazzetta.
Poco dopo, alla Festa Grossa non si parlava d’altro. Tutto quello che era successo, quel trambusto e quel vocio sommesso dei curiosi non aveva minimamente turbato lo sconosciuto il quale, congedato il bambino con le due parole, riaperto il libro e, senza dire né “a” né “ba”, aveva tranquillamente ripreso la sua lettura come se nulla fosse accaduto. La voce era arrivata anche a Duilio Marabini detto Musgatt, il figlio primogenito di Leandro Marabini, il podestà di Bazzano. Quella mattina, Musgatt, aveva lasciato la sua grande e bella casa di Ponte Ronca, salutato in tutta fretta la moglie Olga, alle prese col figlioletto di tre anni che frignava, e ora stava giungendo alla festa accompagnato da Isora, sua cugina, anche se tutti in paese sapevano che da tempo era la sua amante ufficiale.
Duilio aveva trent’anni, un bel viso, due baffi spioventi e un cappello floscio di feltro che portava con civetteria quasi fosse un pittore o un artista da teatro, anche se nessuno aveva capito veramente che cosa facesse nella vita. Sono un uomo d’affari, diceva di sé. Vicino a lui Isora sembrava mal assortita, bella, procace, truccata e ingioiellata al pari della madonna di Lourdes.
Gli amici al Caffè Centrale gli avevano detto che alla festa c’era un matto che vendeva parole, ma che forse non era proprio matto. Insomma, uno strano soggetto che faceva parlare di sé e nessuno aveva capito da dove diavolo fosse sbucato. Incuriosito da un personaggio così misterioso, si fece largo tra la gente e giunse proprio di fronte al venditore di parole, il quale non si scompose proprio e non alzò nemmeno lo sguardo dal suo libro.
-Sembra che qui si vendano parole.- Esordì Musgatt picchiettando il bastone da passeggio sull’assito ligneo del tavolino.
Lo sconosciuto alzò lo sguardo e, senza fretta, richiuse il libro guardando negli occhi il giovane.
-Sì, e allora?- Gli rispose senza cambiare di una virgola l’espressione immobile del suo viso.
-Allora… allora ne voglio una. La voglio buona e utile e te la pago in contanti, ma guai a te se è qualcosa che non serve. At fag passer la Ghiranda a chelz in tal cul. Ti faccio passare la Ghironda a calci nel culo come è vero che mi chiamo Duilio Marabini. Et capè!-
Mentre stava parlando, Musgatt pensò che quel viso dall’aria così assente e risoluta forse gli ricordava qualcosa o qualcuno perso nel suo passato più remoto. Alla fine si convinse che quel volto era talmente anonimo che poteva essere di tutti e di nessuno.
-Sentite, signor Marabini, la parola che ho per voi vi costerà cento lire tonde, non un centesimo di meno. E se la parola non vi serve, non vi garba e non la trovate di vostro gradimento sono pronto a restituirvi immediatamente le cento lire raddoppiate del loro valore.
Una piccola folla si era assiepata intorno al banchetto del venditore di parole, c’era chi spingeva, chi sgomitava e non si sentiva volare una mosca. Sembrava quasi che tutti stessero trattenendo il fiato per paura di perdere una parola o un semplice accenno e per vedere come sarebbe andata a finire.
-Cento lire sono tante.- Riprese a dire Musgatt accarezzandosi i baffi e mettendo mano al portafoglio.- D’accordo, ma non facciamo scherzi. Ma senti un po’, il tuo viso non mi sembra nuovo. Sei di Ponte Ronca? Sei forse di Bazzano?
-Mai stato a Ponte Ronca prima d’ora. È la prima volta che ci vengo e mi sa, a dire il vero, che non mi ero perso proprio niente.- Gli rispose lo sconosciuto mentre scriveva su un foglietto una parola con la matita. Piegò il foglio in quattro e lo porse al giovane che lo prese tra il pollice e l’indice, lo guardò richiuso e lo tenne per un momento immobile tra le due dita come se volesse mostrarlo alla gente con un gesto teatrale. Con studiata lentezza e con apparente indifferenza aprì il foglietto e lesse la parola mentre lo sconosciuto forestiero riponeva le cento lire in un elegante portacarte rosso di cuoio marocchino.
Musgatt, quando lesse la parola, sbiancò in volto, richiuse il foglietto e se lo mise in tasca. Tutti capirono in un attimo che lo sconosciuto aveva colto nel segno. Il giovane tacque, si fece largo tra la piccola folla attorno e, senza dire nulla, affrettandosi lentamente, si allontanò lasciando Isora nel piazzale della festa senza un gesto né un cenno. Prese la via di casa e tutti si accorsero, vedendolo allontanarsi correndo inseguito dal suo tabarro nero, che era accaduto a Musgatt qualcosa di veramente serio.
Duilio Marabini se ne era andato da appena mezz’ora quando di fronte al banchetto del venditore di parole si era già creata una piccola fila. L’uomo misterioso aveva una parola per tutti, talvolta anche due o tre. Guardava il viso della persona davanti a sé, gli stringeva la mano, riceveva il suo compenso che poteva essere di tre o quattro soldi e, nei casi più complessi, di una o due lire, dopo di che scriveva la parola su un foglietto o la sussurrava all’orecchio del cliente. Poteva trattarsi di una massaia o di un contadino. Vecchi e bambini, giovani e adulti aspettavano in fila pazienti, ansiosi di ricevere la propria parola e non c’era nessuno che non ringraziasse con un sorriso. Ogni parola che l’uomo vendeva veniva accolta con gioia e stupore, alcuni ringraziavano con gridolini carnevaleschi, altri addirittura con risate sfrenate e insolenti.
Don Attilio, il parroco, leggermente discosto dal tavolo dell’uomo misterioso, rimirava con sospetto quella lunga fila e quelle esplosioni di gioia che gli parevano così poco “cristiane”. Ma perché tutta quella gente, pensò il prete, non va a divertirsi al tiro al bersaglio, a giocare alle bocce o ad ascoltare l’orchestrina che già da oltre mezz’ora suonava poco discosta e poco ascoltata? C’era qualcosa di losco, di irriverente, di vagamente dionisiaco in quegli sprazzi di felicità che non sembravano provenire da gente timorata di Dio. Improvvisamente don Attilio prese la sua decisione. Alzò con entrambe le mani il suo abito talare fin quasi alle ginocchia per poter correre meglio e molti si accorsero in quel momento, trattenendo a stento le risa, che il parroco quella mattina aveva indossato due calzini di colore diverso, uno rosso e uno blu. Corse di gran carriera fino alla chiesetta della Visitazione, caricò in tutta fretta l’aspersorio di acqua santa, con una sorta di cieca rabbia come se stesse armando una pistola a ripetizione, indossò la stola viola che pendeva inerte dal confessionale e riprese la strada della Festa Grossa. Giunto che fu di fronte al venditore di parole, mentre questi stava servendo il calzolaio Luigi Pizzoli detto Gigéin, cominciò ad aspergere il forestiero come una furia, recitando oscure formule in latino che avevano per gli attoniti presenti la cadenza dell’invettiva e della maledizione. Ben presto l’uomo con la bombetta si trovo col viso zuppo di acqua benedetta che scendeva a rivoli dai piccoli occhiali tondi. L’uomo se li tolse, senza rivolgere al prete nemmeno un’occhiata di traverso, li pulì con un fazzoletto di seta che teneva nel taschino del panciotto e, per la prima volta da quando era sceso dalla corriera, sorrise.
Erano quasi le otto di sera quando lo sconosciuto venditore di parole estrasse dal suo panciotto un pesante orologio d’oro da tasca e disse al barbiere Aristide Marzari detto Tirafrad che gli stava di fronte: -Mi dispiace, gentile signore, ma è ora che io vada.- Tirafrad ci rimase un po’ male visto che aveva fatto oltre venti minuti di coda. Il forestiero salutò coloro che erano in fila togliendosi cerimoniosamente la bombetta e dando a tutti appuntamento per il giorno seguente alle ore nove precise.
Lasciò tavolo e sedia al padrone della giostra che li tenne gentilmente in custodia fino all’indomani e, accarezzando la fionda che sporgeva dal taschino del gilet damascato, si allontanò avviandosi per la via della collina, stando ben attento che nessuno lo seguisse. Prese la strada bianca che in maniera irregolare costeggiava la Ghironda, dopo due curve giunse davanti a una grande casa color senape, di aspetto padronale, delimitata da un grande cancello e contornata da un giardino signorile. Rimase qualche minuto aggrappato alle aste verticali della cancellata guardando fissamente la vetrata dell’ampia veranda che dava sul giardino. Quindi si chinò verso terrà, scelse con cura un sasso tondeggiante grosso quasi quanto una piccola noce e caricò la toppa della fionda, tese gli elastici per tutta la loro estensione, prese la mira e centrò la vetrata della veranda mandandola in frantumi. Non ci fu nessun clamore, nessuno si sporse dalle finestre, evidentemente non c’era nessuno in casa.
Riprese quietamente la via verso valle sapendo che lo attendeva una buona cena alla locanda Venturi di Pragatto dove era alloggiato. Quando arrivò alla locanda erano le nove appena trascorse. La sua fama lo aveva ampiamente preceduto, molti tra gli uomini che giocavano a carte, o bevevano il proprio quartino, quando lo sconosciuto varcò la porta dell’osteria si fermarono, si tolsero il cappello o si toccarono la fronte in segno di riguardo.
Il mattino seguente, quando poco dopo le nove si presentarono i primi clienti, il venditore di parole era già al proprio posto. Evidentemente a nulla erano valse le reprimende in latino di don Attilio e lo sguardo torvo del maresciallo Mancuso che osservava con un certo sospetto il quieto armeggiare con le parole dello sconosciuto. Sia gli uomini che lavoravano alle giostre che l’omino del tiro al bersaglio coadiuvato dalla figlia, una bella ragazza mora che porgeva carabine e sorrisi ai ragazzi della Festa, vedevano di buon occhio il venditore di parole. La Festa Grossa non era mai stata così movimentata e affollata di gente contenta da molti anni a quella parte.
Il sole era già alto nel cielo e il caldo cominciava a farsi sentire. Il venditore di parole aveva la sua postazione sotto un alto tiglio della piazza che donava un po’ di ombra in quella giornata afosa. Il venticello che solitamente spirava dalla collina quel giorno tardò a farsi sentire. Verso le undici si presentò in piazza Duilio Marabini. Non guardò in faccia a nessuno e puntò dritto verso lo sconosciuto con la bombetta. Se ne infischiò della gente in fila e andò dritto al punto che gli stava a cuore.
-Mi serve una parola, subito. E che sia buona, per la miseria! Costi quel che costi!
Lo sconosciuto finì di sussurrare una parolina a un giovane di Pragatto che ringraziò contento, poi si rivolse a Musgatt in questi termini: – Ho la parola che ti serve, ma questa volta ti costerà mille lire.
Duilio era furente. – Cat vegn un chencher! Non ho questa somma con me. Ti farò un assegno.
-Nessun assegno. Solo contanti- replicò calmo l’uomo con la bombetta mentre, silenziosamente, scrisse una parola su un foglio, lo piegò e lo mise nel taschino del panciotto.
-Per aprire questa tasca servono mille lire, non una lira di più, non una lira di meno.
Musgatt corse via furibondo e si ripresentò sotto il tiglio mezz’ora dopo mentre lo sconosciuto forestiero era in un momento di pausa e stava bevendo in tutta tranquillità una gazzosa ben fredda. Il giovane contò sul tavolinetto mille lire in tagli da cento, una banconota sopra l’altra. La gente attorno era esterrefatta. Musgatt era un uomo conosciuto e di grande influenza in paese, per non parlare di suo padre il podestà, un importante gerarca, fascista della prima ora, da tutti rispettato e temuto. Quando il venditore di parole ebbe inserito le mille lire nel suo portacarte rosso e reinfilato questo nella tasca posteriore dei pantaloni, trasse dal taschino il foglio e lo diede al giovane. Musgatt aprì il foglio e tutti si accorsero che la mano gli tremava visibilmente.
-Dio mio! Non è possibile?!?- Esclamò in tono alterato e si allontanò barcollando leggermente mentre la gente faceva largo al suo passare.
L’accaduto pareva aver creato una sorta di timore diffuso tra coloro che erano presenti e che avevano visto Musgatt, sempre così spavaldo, andarsene a capo chino con una sorta di terrore stampato sul volto. Il forestiero sconosciuto era rimasto imperturbato, col suo viso serio ma in fondo sereno. Al suo banchetto non c’era più la fila. Qualche avventore reclamava la sua parola, pagandola il giusto, ma nessuna fila o ressa come un’ora prima. Giunta che fu l’una, il venditore di parole lasciò il suo banchetto e andò a pranzo al Caffè Centrale che, per la Festa Grossa, fungeva anche da trattoria. Annaffiò le sue tagliatelle al ragù col miglior pignoletto della zona, quello della tenuta Ravasi.
Ritornato, poi, nella piazzetta si fermò a chiacchierare amabilmente con il padrone della giostra per poi riprendere il suo posto dietro il tavolinetto. Quel primissimo pomeriggio domenicale della Festa Grossa era particolarmente tranquillo. La gente arrivava alla spicciolata e, sapendo quanto era successo quella mattina al figlio di Marabini, si guardava attorno con una sorta di vigile preoccupazione. L’allegria carnevalesca del giorno prima sembrava essere svanita per lasciare il posto a quell’atmosfera elettrica che precede una tempesta, quando sembra quasi di sentire l’odore dei fulmini che stanno per arrivare. Il venditore di parole era tranquillo, aveva ripreso la lettura del suo libro. Pochi clienti, qualche forestiero a cui era arrivata voce delle parole in vendita e non voleva perdere un’occasione così singolare.
La tempesta arrivò verso le sette di sera, mentre la Festa Grossa era più trafficata che mai. Arrivò annunciata da tre brutti ceffi in camicia nera e fez guidati da Mario Lepore detto Mariein. La giostra traboccava di bambini, il tiro a segno era un continuo crepitio di colpi e due giocolieri si scambiavano palline e clavette in equilibrio sui loro monocicli.
Mariein si avvicinò al tavolinetto del forestiero mentre questi stava leggendo il suo libro, trasse dalla cintura il manganello e lo picchiettò più volte sull’assito del tavolino con un suono da xilofono stonato.
–Dissò umarell. Cosa ci fa qui un milordino elegantino come te tra tanta gente per bene come questa? I furbetti come te, a noi proprio non ci piacciono. Et capè, al mi milurdein dal caz!
Il venditore di parole interruppe la lettura e alzò lo sguardo con molta lentezza. Guardò l’uomo in fez dritto negli occhi senza dire nulla finché Mariein, non resistendo a quello sguardo, diede mano al manganello colpendo il libro che volò lontano.
-Che cosa volete?- chiese l’uomo con la bombetta.
-Quelle mille lire che hai estorto al camerata Marabini te le facciamo cagare, lira su lira, a bastonate. Ma non qui, che c’è gente, e poi non vogliamo rovinare la festa.-
Il tono di Mariein era sempre più ostile e minaccioso e come se non bastasse, gli altri due giovani in camicia nera, pantaloni alla zuava e fez, si erano posti ai due lati di Mariein con le mani sui fianchi.
-Lo sai dove vanno a finire i pezzi di merda come te?- Mariein fece una smorfia e sputò scaracchiando sul cartello sotto il tavolino. -La cosa non finisce qui. I tuoi giochetti di parole non ci impressionano!-
E come per dare forza alle sue parole diede uno schiaffetto alla bombetta sul capo dell’uomo che cadde a terra poco distante. Il forestiero non si scompose, raccolse il suo capello e non cambiò di un sol tratto la fissità del suo viso. La gente tutt’attorno tratteneva il fiato e, sinceramente, quasi tutti erano in apprensione per la sorte dello strano forestiero, minacciato così severamente da quei tre soggetti ben conosciuti in paese per la violenza e l’arroganza.
Un aiuto insperato, per il venditore di parole, giunse da quanto stava accadendo in quel momento al centro della piazza. Un uomo di oltre sessant’anni, a torso nudo, con gli occhiali dalle lenti grosse come fondi di bicchiere e una zazzera rasata all’umbertina, si era presentato un’ora prima al pubblico come Uber, il fachiro di Tavagnacco. Ora stava vomitando, emettendo versi e conati, una trentina di minuscole raganelle verde chiaro che aveva poco prima divorato insieme a enormi quantità d’acqua. Queste saltellavano per la piazza vive e vegete. Uber le rigurgitava e nel contempo le rincorreva per rimetterle nel sacco di iuta dove le aveva tratte mezz’ora prima. L’attenzione di tutti era catturata dal fachiro friulano a petto nudo. Anche i tre fascisti in fez si erano spostati di diversi passi ed ora ridevano sganasciandosi, segnando a dito Uber e le raganelle che se ne andavano in giro per la piazza tra l’ilarità generale.
Il venditore di parole appoggiò la bombetta sul tavolo, proprio sopra il libro aperto e piegato sul dorso: sembrava un quadretto fatto apposta, una sorta di cartello con su scritto “Torno subito”. Fece alcuni passi indietro e, quietamente, si allontanò inosservato dalla piazza affollata.
**
Era una splendida serata di luglio, il sole stava per scendere dietro la collina di San Martino in Casola. Spirava una brezza leggera che piegava lieve l’erba alta lungo la riva della Ghironda. Lo sconosciuto venditore di parole stava ripercorrendo con passo quieto il percorso fatto la sera prima e, dopo alcune svolte della strada bianca, si trovò davanti all’ingresso della casa color senape con la veranda dal vetro infranto.
Il cancello era solo accostato. Attraversò con passo fermo la soglia del giardino e si diresse verso la grande porta d’ingresso. Si fermò a meno di un metro dal portale in noce e rimase a lungo a guardarne le increspature, le venature del legno e i segni lasciati dal tempo. Poi, lentamente, avvicinò la fronte all’uscio fino a sentirne la rugosità come se dovesse, da un momento all’altro, uscirne un suono. Fu solo un attimo e subito rialzò la testa e si trovò ritto, in piedi, di fronte all’ingresso. Si voltò lentamente rimirando dietro di lui il giardino che stava per essere avvolto dalle ombre della sera. Si frugò in tasca ed estrasse una pesante chiave che infilò nella serratura del portone, la rigirò più volte e quello si aprì come d’incanto.
Nell’ampio ingresso tutto appariva sottosopra, i cassetti del trumeau erano aperti e con oggetti fuoriusciti sul pavimento. Il tavolo era ingombro delle cose più strane, altri oggetti erano stati gettati alla rinfusa sopra un elegante tappeto, due sedie erano ribaltate a terra e la grande tenda di un’ampia finestra era strappata. Pareva una casa appena svaligiata, oppure abbandonata in tutta fretta da qualcuno alla ricerca di qualcosa che non riusciva a trovare.
Fermo, nel centro del salone, osservò con cura i quadri, il raffinato mobilio, il disegno elegante della tappezzeria muraria floreale in stile inglese. Attraversò la sala scavalcando gli oggetti che ingombravano il pavimento di maiolica, aprì la porta di un’anticamera male illuminata, aprì un’altra porta e si trovò nella grande cucina che dava sul retro. Questa prendeva luce da una grande porta finestra che si affacciava su un piccolo orto e lasciava entrare un ampio panorama di campi che si perdevano all’orizzonte.
Lo sconosciuto sollevò una stuoia di giunco che ricopriva il pavimento di cotto fiorentino davanti al secchiaio. Cominciò a picchiettare con le nocche ogni singolo mattone fino a ché due di questi non fecero un suono diverso rivelando qualcosa di cavo. Aiutandosi con un sottile coltello per dolci scalzò i due mattoni i quali nascondevano una piccola scatola di latta tutta ricoperta di ruggine. La maneggiò con cura, prese uno strofinaccio che pendeva dal lavandino per rimuovere almeno una parte dello strato rugginoso. Esitò prima di aprirla, come se temesse le sorprese che il tempo era in grado di riservargli. Non mancava nulla, nulla era stato alterato o sottratto in oltre trent’anni: una trottola in legno di pregevole fattura, con la corda ancora intatta e scanalature rosse e blu. Era stata costruita per lui dal falegname Anzlat, Angelo Galliani, un caro amico di suo padre. Una fionda in legno di ciliegio con la toppa in tela ancora intatta, anche se la stessa cosa non poteva dirsi per gli elastici ormai lisi dal tempo. Venti figurine Liebig e un numero imprecisato di biglie in vetro di vari colori. Richiuse la scatola, cercò e trovò in un cassetto uno spago e lo passò intono ad essa più volte annodando poi con cura.
Stringendo nelle mani il suo piccolo tesoro, usci dalla casa, si fermò qualche istante ad osservare per un’ultima volta il salone, poi chiuse la porta e rimise la pesante chiave in tasca. Con il cancello alle sue spalle guardò la bella facciata di quella casa e si accorse di avere sulle labbra alcune parole di commiato, le declamò con una solennità aulica, come se fosse un endecasillabo. Parole che gli erano rimaste in gola da oltre sedici anni. Fece un ampio respiro e le pronunciò lentamente a voce alta come se le leggesse: -Porci, fascisti, figli di troia.
Chiuse il cancello dietro di sé e prese la strada verso San Lorenzo in Collina, allontanandosi sempre più da Ponte Ronca e dalla Festa Grossa che ormai volgeva al termine. Giunto in località Molinetti, costeggiò il podere dei Buganè e dopo pochi passi si trovò vicino a un grande macero per la canapa. La luce dell’imbrunire lasciava intravvedere sulle sue rive il giallo vivo dell’iperico e il giallo tenue dei canneti. Estrasse con fare solenne la grande chiave che aveva usato poco prima e la lanciò al centro del macero che la accolse con un pluff quasi inavvertito. Immaginava di essere atteso alla stazione di Ponte Ronca per la Littorina delle 21:15. Forse lo attendevano anche alla non lontana stazione di Zola Predosa dove il treno Littorina sarebbe partito per Casalecchio dieci minuti dopo. Non aveva alcuna intenzione di onorare in alcun modo quegli sgradevoli appuntamenti. Prese la via dei campi che conosceva bene, prima di San Lorenzo avrebbe deviato per san Pancrazio aggirando il paese di Zola e tagliando per campi e cavedagne verso Casalecchio, dove sarebbe arrivato di buon passo in meno di due ore. Un unico compito gli rimaneva da adempiere, andare per la prima volta nella sua vita in località San Pancrazio. Non era certo lontana da Ponte Ronca, qualche chilometro, non di più. Ma lui, il venditore di parole, a San Pancrazio non c’era mai stato. San Pancrazio l’aveva sentito raccontare, quando era bambino, da suo nonno Alfredo e la storia era sempre la stessa, breve e incantevole:
–Un dè andarain a San Pancrazi a magner i ciud! Un giorno andremo a San Pancrazio a mangiare i chiodi.
E non era l’incipit della storia, era proprio quella la storia tutta intera: l’evocazione di un luogo mitico dove un giorno saremo andati tutti a mangiare i chiodi. Allungando il passo sarebbe arrivato a San Pancrazio prima che il buio fosse completo. Avrebbe visto i profili delle case di quel luogo magico che doveva la sua fama, forse, al fatto di aver ospitato in passato un buon calzolaio, oppure un bravo falegname che poteva portare in bocca più chiodi di quanto questa ne potesse contenere. Mentre le luci di San Pancrazio si profilavano all’orizzonte si sentì giovane, forte e con il cuore di un bambino. Lo straniero venditore di parole non sarebbe mai più ritornato a Ponte Ronca.
**
Gabriele Veggetti dal 2006 collabora con la Cineteca di Bologna nelle attività del dipartimento educativo. Ha insegnato dal 1997 al 2017 ‘Storia e critica del cinema’ presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell’Università degli Studi di Bologna. Al momento tiene laboratori di cinema nelle scuole di Bologna e provincia, coordina You-Factory, una piccola factory cinematografica formata da adolescenti, finanziata con un progetto regionale con sede a Valsamoggia (BO). Nel 2021 il suo racconto “La Tromba di Art” è entrato nella triade dei vincitori del Premio Scerbanenco.

Gabriele Veggetti
