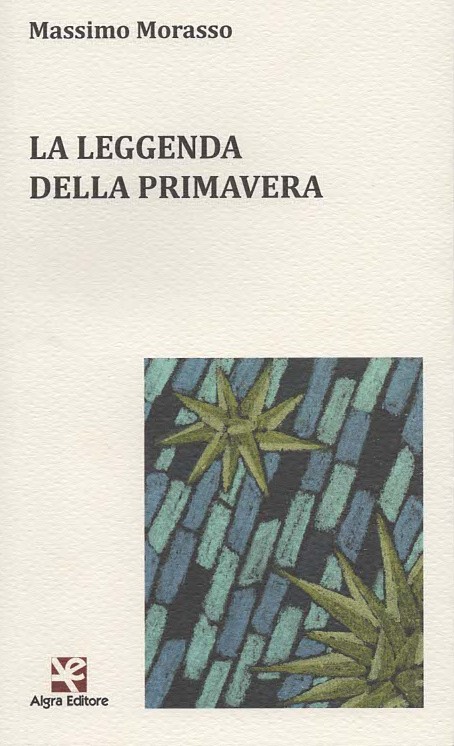
*Massimo Morasso, La leggenda della primavera, Algra editore, Catania 2023, con prefazione di Antonio Di Mauro. In copertina: Giorgio Bertelli, Senza titolo, 2003.
**
La leggenda della primavera è un libro nuovo e, al tempo stesso, non lo è. Non è una novità perché le tre sezioni di cui è costituito, Nel ritmo del ritorno, Distacco e Le storie dell’aria, erano già state pubblicate in tre distinte plaquettes dall’Obliquo tra il 1997 e il 2000; è una novità, perchéè la prima volta che queste tre sillogi poetiche vengono raccolte in un libro unitario. Si tratta, a pensarci bene, di una piccola anomalia, che crea un po’ di scompiglio nel lettore sensibile e scrupoloso, il quale è portato a leggere il libro – nuovo ma, al contempo, privo dell’incanto primiziale sprigionato dall’inedito – in maniera… strabica. Che poi tale anomalia fosse inscritta ab origine nel destino di questo libro sembra provarlo già il titolo, La leggenda della primavera, che fa convergere sotto un’unica costellazione i due termini di un’antitesi: la tradizione (leggenda non è da intendersi solo nell’accezione più comune, evocativa di un mondo favoloso contiguo alla fiaba, ma in quella di sapere tramandato) e il nuovo (la primavera), come cambiamento, da ricondursi però rigorosamente entro i solchi segnati della tradizione, di cui Botho Strauss rivendicava l’importanza ontologica, come condizione indelebile dell’esistente: «O si è prosecutori – o non si esiste».
(Il poeta è Fortführen: è colui che persevera «sulla strada dei poeti che lo hanno preceduto», e al tempo stesso conduce (führen) altrove, lontano (fort) – dai nostri interessi, dai luoghi comuni, da tutto ciò che ci circonda). Inevitabilmente, perciò, la poesia non può che snodarsi nel ritmo di un ritorno, anche perché quest’ultima, a differenza della prosa, è già, per natura, orientata verso il passato, l’origine (e lo chiarisce bene Zambrano quando precisa che il poeta si strugge – desvive – allontanandosi dal suo possibile se stesso per amore di quell’origine, da cui invece il filosofo che vive proiettato in avanti, si allontana), dietro la spinta di una nostalgia (dell’altrove, dell’eterno) che rappresenta la vera forza motrice della poesia, almeno nella prospettiva anagogica delineata da Morasso nel suo ancora inedito Trattato sull’anagogia, dove si legge: «poesia è nostalgia dell’altro mondo».
Naturalmente, il ritorno c’è, perché c’è stato un viaggio, anche se si tratta di un viaggio compiuto nella luce del reditus, quasi sulla falsariga di quell’uomo nobile di cui si dice nel passo del Vangelo di Luca (19, 12) citato da Meister Eckhart nelle battute iniziali del trattato Dell’uomo nobile: «Un uomo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno, e poi tornò». Qui nella prima sezione di Nel ritmo del ritorno, Quaderno irlandese, il “paese lontano” in cui ci conduce il viaggiatore-io poetante è la terra d’origine dell’amato Yeats, un luogo che, se non altro per questo motivo, presenta tutte le carte in regola per accreditarsi a buon diritto come il “paese dell’anima”. E questo altro-dove si staglia dinanzi ai nostri occhi come un paesaggio scarno, essenziale, in cui (ma queste osservazioni vanno estese anche ai testi delle altre sezioni Falsi movimenti, Intermezzo genovese e La torre abolita) la presenza umana è ridotta al minimo, se non del tutto assente. Come se il paesaggio, con le sue nebbie, la sua vegetazione limbica, i suoi pantani, in cui non si vede, ma tutt’al più si può supporre il fiorire di qualche pianta (l’erica, i rari tenuissimi fili d’erba votati al disfacimento, pronti a rientrare definitivamente nel grembo invisibile da cui sono sbocciati), disseminato di croci scolpite, torri semidiroccate, monasteri in rovina, «tutte vestigia di antichi o antichissimi insediamenti» (Non ci sono più le grandi case patrizie di una volta, p. 23) fosse in procinto di ritirarsi nell’invisibile o avesse subito lo stesso processo di spoliazione subito dall’io poetante (e dal linguaggio, come osservava Giorgio Luzzi nel saggio introduttivo alla prima edizione della raccolta, dove parlava di oggettività dai modi scarni, di ineloquenza), che non è neanche un “io”, ma una terza persona, un “egli”.
È questo ripudio della prima persona, in rigorosa ottemperanza all’insegnamento eckhartiano, che permette al poeta, non solo di presentare se stesso come un altro – un egli (quel pronome a cui, dice Benveniste, non spetta neppure lo statuto di persona)- ma anche di vedere quest’altro – l’”appartato”, lo “straniero”, l’”osservatore”, il “viaggiatore”, l’”interprete”, tutte perifrasi di quella terza persona pronominale che, ci ricorda ancora Benveniste, gli arabi chiamavano, al’ya-jbu, “colui che è assente”, – alla stregua di una “cosa fra le cose”: non semplice osservatore e/o esegeta di segni, ma egli stesso segno, come i piccoli tagli incisi dal salmone nell’incavo della mano, nella quarta poesia di questa prima sezione. O come uno degli elementi del paesaggio crepuscolare di cui osserva il lento disfacimento (mi riferisco in particolare al testo Dei ventinove cigni selvatici, di cui è chiara l’ascendenza yeatsiana), che coincide con il proprio. Nella Torre delle taccole, l’ultimo testo della prima sezione, l’impraticabilità e l’inaccessibilità della torre, spazio ermetico, chiuso in se stesso, quasi trincerato nella sua altezza, refrattario all’uomo e alla sua lingua, che solo gli uccelli sono rimasti a presidiare, spiegherebbe la graduale eclissi del locutore umano in grado di udire e nominare. Anche se il vuoto lasciato dalla mancanza o dall’eclissi dei nomi non significa che questi spazi, ai margini dell’esistente, non racchiudano nei loro recessi quei semeia che noi traduciamo un po’ sbrigativamente “segni”, ma la cui accezione semantica, per dirla con Florenskij il quale, a sua volta, attinge al senso divino, evangelico del termine, è “miracoli”. Sono forse questi i semeia mirabili – tracce solo in apparenza perdute, ma dal cui centro continuano a sprigionarsi scintille – che l’interprete cerca di individuare e decrittare, al modo di un paleontologo.
Nei due testi inclusi nella sezione Intermezzo genovese dedicati al piccolo principe sepolto nella tomba preistorica scoperta in Liguria, lo sguardo dell’osservatore-visitatore si concentra sui resti del regale adolescente, sullo squarcio «ricomposto/ pietosamente in giallo-ocra della mandibola» causa probabile della sua morte prematura, sul corredo funebre, e sulla corona di conchigliette di nassa: segni, minuscole icone che racchiudono le tracce di un’altra verità, di cui gli uccelli, gli insetti, le rare, esili piante, sono i piccoli, appena visibili araldi. Come l’ape di Duplice è la natura dell’ape, nella sezione La torre abolita, che può correre «lungo fili invisibili», «scartare tra un istante e l’altro», «da una rosa a un’altra rosa», dove è l’istante la rosa, il fiore magico, il mitico kairós, che il poeta, secondo Pindaro, dovrebbe toccare nel suo volo, al pari dell’ape, appunto.
Prima ho detto “sguardo”, ma forse avrei dovuto dire “attenzione”, nel senso di quell’attenzione plenaria, che presuppone eckhartianamente l’abbandono (della volontà), il distacco o Gelassenheit dall’io psicologico (di cui l’adozione della terza persona era una chiara filiazione) che S. Weil consigliava di esercitare sulle immagini e sugli oggetti, fino a farne sgorgare la luce, e di cui Morasso parla nella quarta parte della sua seconda raccolta, dove il riferimento a Meister Eckhart è dichiarato già nel titolo: Distacco. Con questo poemetto ci troviamo già quasi alle altezze delle ultime raccolte poetiche morassiane. E non mi riferisco solo al superamento di quell’oscillazione fra prosa e lirica, che presuppone una scelta di campo netta in favore di quest’ultima, ma anche all’ambiziosità del progetto poetico che in seguito verrà illustrato nelle pagine dell’ancora inedito Trattato sull’anagogia, e di cui i Frammenti di nobili cose (un altro titolo eckhartiano) rappresentano l’esito più maturo.
Non intendo soffermarmi sul concetto di distacco che Morasso attinge direttamente dalla sua fonte eckhartiana, e che tra l’altro viene illustrato con sufficiente chiarezza da A. di Mauro nelle pagine introduttive, pur nell’imperdonabile omissione di ogni riferimento, magari anche lieve, en passant, al teologo renano. Una cosa l’abbiamo già appurata, e cioè che il distacco passa innanzitutto per il ripudio della soggettività, per la nullificazione dell’io psicologico, per la svalutazione di tutto quanto appartiene al mondo dell’apparenza, insomma. È un’azione che rompe l’io psicologico e ci porta direttamente “nel fondo dell’anima” che per Eckhart è il luogo nascente di Dio nell’uomo. Lo dice bene Morasso nella quarta parte del poemetto: distacco «è una disposizione del pensiero che s’indentra/ nella fortezza della sua umiltà», un «esercizio di attenzione», «è una resa/ della volontà», una pratica che culmina nel distaccarsi dall’apparenza, definitivo nel caso del persuaso Michelstaedter, «l’Antico», citato nella quinta sezione. Ma il distacco dall’apparenza presuppone com’è ovvio una radicale sfiducia nel visibile e per converso quella devozione all’invisibile, di cui si accenna nella seconda sezione, Il distacco non è cosa che si cerchi.
Distacco è anche, anzi soprattutto questo: «è la ragione/ e la ragione è la fede/ nelle ragioni dell’invisibile». Una fede che verrà ribadita con altrettanta fermezza, quasi con veemenza nelle pagine del Trattato sull’anagogia: e questo tanto per dire come la scelta anagogica non rappresenti il frutto di una conversione improvvisa, di una svolta imprevista del pensiero, ma l’esito finale (e fatale) di un percorso coerente, già tutto incluso, in nuce, nella fase iniziale della poetica morassiana, di un progetto in cui rientrano anche gli scritti in prosa o narrativi, da Fantasmata a Il sogno di Zhuangzi, passando per un libro sui generis come L’obbedienza. Così, leggendo il testo di apertura, dove la poesia sul distacco, se la si pensa «come mossa e percorsa/ da un impulso teologico» (questa è l’ipotesi formulata da Morasso), finirebbe per condurci in ogni suo verso «lungo un percorso mentale/ pieno di digressioni e vie traverse/ nei pressi del piazzale/ dove (come vuole qualcuno)/ l’origine fa segno», è quasi impossibile non ritrovarsi letteralmente fiondati nel bel mezzo di quel dedalo intricatissimo tracciato dalle avventure mentali e fisiche narrate da Morasso nei suoi scritti in prosa.
Le storie dell’aria è l’ultima soglia di questo libro, in cui, dopo la parentesi teologico-sapienziale del Distacco, si torna a parlare di viaggi, che, in qualche caso, sono pellegrinaggi in luoghi ricchi di memorie poetiche, dove aleggia la presenza di autori fraterni amati dall’autore: l’Irlanda di Yeats, la Pienza di Mario Luzi. Viaggi in cui l’io poetante non è più solo, ma in compagnia di una partner, che non è una semplice compagna di avventure, ma la sua controparte femminile: è una vestale del mondo umbratile in cui ha sede la verità («Dice la verità chi parla d’ombra», è un verso di Gli immemori palazzi di cemento, p. 90), che ha l’occhio aperto sull’invisibile, come le figure femminili rilkiane del Malte, e che perciò può vedere i viventi dissolversi («sono spariti tutti, e tutti/ li ho visti dissolversi, eclissarsi»). Qui dove il linguaggio, da lirico, si è fatto più narrativo, con una predilezione per i versi lunghi, spesso ipermetri, sembra di trovarsi in una dimensione diversa da quella, tutta interiore, con rare aperture sul mondo fenomenico, della raccolta precedente.
In realtà, non è così e basta dare un’occhiata a qualche testo per capire come l’ago d’oro dell’attenzione, nonostante queste escursioni sull’esterno, sia sempre puntato sull’invisibile, su quel mondo di là che è anche la mandorla felice in cui sono racchiusi tutti coloro che non ci sono più, a cui siamo stati (e siamo tuttora) legati da vincoli amorosi, irrescindibili. Il mondo esterno è presente, sì, ma visto sotto l’angolo di incidenza di quello invisibile, cioè nella luce del distacco. Del resto, la raccolta inizia subito con piglio eckhartiano, perché ad attenderci in limine troviamo il poeta con indosso le vesti cerimoniali del grande sacerdote della poesia, l’amato Rilke, con quel sonetto tratto dai Sonetti a Orfeo, rigorosamente nella versione morassiana, in cui si parla, fra l’altro, di gioia e desiderio. Gioia e desiderio che sono – penso di poterlo affermare senza timore di smentite – le due armoniche fondamentali della poesia morassiana, da intendersi (ovviamente) non nella loro accezione più comune. Il desiderio di cui si accenna non è un moto dell’anima che si diriga su quella cosa, su quella creatura: l’obiettivo non è né questo né quello, ma è molto meno (non ha a che fare con il mondo delle apparenze, e soprattutto non è qualcosa di cui ci si possa appropriare hic et nunc) e, insieme, molto di più. È l’origine, l’altrove, l’eterno (Desiderio eterno è il titolo di una poesia di Renzo Barsacchi, scelto non casualmente da Morasso come titolo di un’antologia che raccoglie una scelta di testi di questo autore), cioè a dire: qualcosa su cui non è possibile fare esercizio di appropriazione (Eigenshaft).
La gioia, il senso di realtà, è quello stato dell’anima a cui può attingere il distaccato, colui che si è spogliato di tutto («Se insisti a sottrarre si aprirà un’altra ricchezza», in Alla fine non è stato che un dono), liberandosi dalla prigionia dei contenuti, delle opinioni, dell’apparenza, tutti valori a cui non si riconosce alcuna realtà, non essendo reale il mondo visibile a cui appartengono, giacché lo statuto di realtà spetta solo a quell’altro. «Invisibile era il mondo dei fatti che contavano per lui», scriveva Max Brod riguardo a Kafka: una frase che Morasso potrebbe serenamente sottoscrivere, e ancor prima di lui, avrebbe sottoscritto con altrettanta convinzione Cristina Campo («Due mondi, io vengo dall’altro»). E la poesia è, fra tutte, l’ attività in grado di procurare questa gioia proprio perciò: perché il verso non si muove nella direzione indicata dalla prosa, ma liricamente, nel ritmo del ritorno verso un’origine che, in questo caso, non può che coincidere con la meta.
**
Postilla dell’autore
Questo libro raccoglie nella sua interezza il primo dei tre nodi strutturali de Il portavoce, il ciclo poetico al quale mi sono dedicato per dodici anni, dal 1995 al 2006, e che a tutt’oggi non è stato ancora raccolto in volume. Fra il 1997 e il 2000 le tre sezioni che compongono La leggenda della primavera furono pubblicate separatamente in tre plaquettes dalle Edizioni L’Obliquo di Giorgio Bertelli, impreziosite dalle prefazioni di Giorgio Luzzi, Ludovico Pratesi e Giuseppe Conte.
**
Massimo Morasso (Genova, 1964). Germanista, saggista, traduttore, critico letterario, poeta. Ha scritto il vasto ciclo poetico de Il portavoce (in più raccolte, con l’Obliquo 1997 e 2000, con Raffaelli 2010, con Jaca Book 2012), e altri tre libri di versi: Le poesie di Vivien Leigh (Marietti, 2005), L’opera in rosso (Passigli, 2017), American Dreams (Interno Poesia, 2019). Ha pubblicato libri su Cristina Campo, William Congdon, Walter Benjamin e Rainer Maria Rilke. Ha tradotto, dal tedesco, Meister, Rilke, Goll; dall’inglese Yeats, Jones.

Massimo Morasso
