Nella fine, l’inizio. Tentativi di lettura di Cento lettere, di Angelo Lumelli e Marco Ercolani
«La fine è l’inizio: di questa identità la psicosi è maestra» ( Marco Ercolani, Nottario)
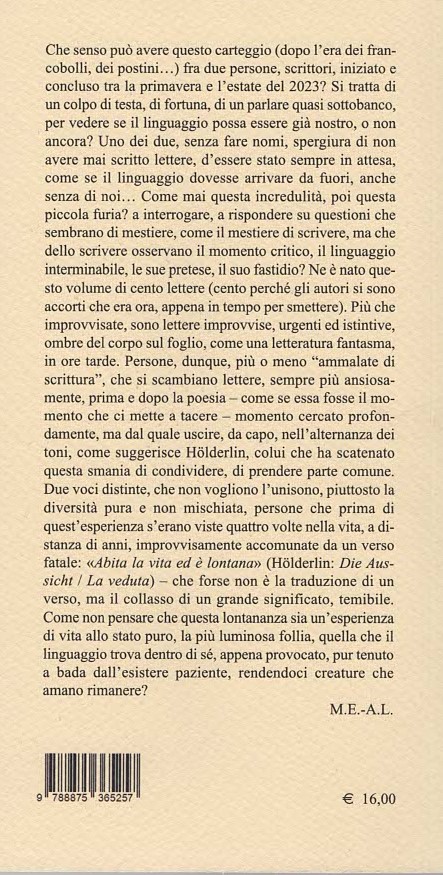
**
Nel breve scritto introduttivo, intitolato quasi con un bisticcio di parole, Letterina al lettore, gli autori si interrogano sul “senso” di quell’operazione così profondamente letteraria – sorta di banco di prova, se non di prova iniziatica vera e propria in cui non c’è scrittore, più o meno referenziato, il quale non abbia sentito il bisogno di cimentarsi – e insieme così anacronistica, «dopo l’era dei francobolli, dei postini… », per non dire inattuale, che corrisponde all’epistolario. La risposta alla domanda non è formulata nello stile assertivo di una replica, ma declinata nella forma evasiva (ed elusiva) di una domanda ulteriore: «Si tratta di un colpo di testa, di fortuna, di un parlare quasi sottobanco, per vedere se il linguaggio possa essere già nostro, o non ancora?». Un nuovo dubbio appena insorto, che insuffla il vuoto (pneumatico) proprio laddove ci aspetteremmo di trovare un “pieno”, secondo un modus operandi proprio dei due autori, del loro stile epistolare (e non solo), come meglio si vedrà in seguito, che coinvolge subito il lettore nella fitta trama di svelamenti e mascheramenti, sorta di gioco a nascondino, dove l’obiettivo non è la conquista di una certezza finale, per quanto problematica, un trovare e un trovarsi, sia pure a prezzo di tanti smarrimenti, sibbene l’iniziazione del lettore coinvolto rischiosamente nel gioco e (si suppone) complice di esso, all’arte difficile di perdere (e di perdersi). Il carteggio, che esordisce con una lettera di Marco Ercolani, e si conclude con una missiva di Lumelli, è congegnato come un dialogo a distanza in cui ogni testo si riallaccia a quello precedente, ne riprende i temi principali per ampliarli e approfondirli in direzioni inedite aprendo nuovi scenari di senso. Una struttura che ricorda quella della doppia spirale, risultato dell’azione di due forze opposte e complementari al tempo stesso, cooperanti nel comune obiettivo di integrarsi ed equilibrarsi, senza tuttavia confondersi l’una nell’altra, ovvero di «due voci distinte, che non vogliono l’unisono, piuttosto la diversità pura e non mischiata», come i due autori dichiarano espressamente, di concerto, nella Letterina al lettore.
Sin dalle prime righe di questo libro singolare, i coautori provvedono, senza indugi, a introdurre uno scompiglio, lieve, quasi uno sbuffo di vento, e tuttavia bastevole a confondere le carte in tavola, nonché le regole del gioco, lasciando al lettore solo una minima, ancorché preziosa, certezza, ovvero che il senso di questa operazione “letteraria” altro non riguarda che il linguaggio, il lógos. Anzi, più esattamente, la lettera, il gramma, come è indicato con sufficiente chiarezza dal titolo, che con un colpo di retorica, insedia metonimicamente (e spiazzando le attese del lettore), in luogo del più astratto, “carteggio”, il concretissimo, “lettera”, che racchiude, appunto, oltre al significato di missiva, anche il senso di lettera alfabetica. Cento sono le lettere riunite in questo epistolario, perché – è la spiegazione addotta per giustificare la scelta di limitarsi a questo numero di testi – «gli autori si sono accorti che era ora, appena in tempo per smettere». Una spiegazione dal tono ironico, (forse volutamente) debole, sì da autorizzare il sospetto che tale scelta sia stata determinata, nel profondo, anche da altre motivazioni, fra cui, non ultima,la valenza suggestiva, stregante tradizionalmente attribuita a questo numero (cento sono i capitoli dedicati alla quattordici epistole di san Paolo; cento il numero dei canti delle tre cantiche della Commedia dantesca, tanto per citare alcuni esempi; per non parlare dei sensi e sovrasensi simbolici di cui si carica nell’ambito della letteratura religiosa ed esoterica ebraico-cristiana).
Che si tratti di un artificio strategico o di una libera decisione, del tutto esente da calcoli e da secondi fini, la scelta di questo titolo contribuisce comunque a condurre il lettore in una zona limitare, lontano dai traffici diurni con la quotidianità, se non, addirittura, fuori dal tempo. Una sensazione rafforzata anche dalla totale assenza di riferimenti cronologici, giacché a parte l’informazione, peraltro abbastanza vaga, fornita nella Letterina al lettore, in cui la stesura del carteggio viene collocata «tra la primavera e l’estate del 2023», per il resto, ci troviamo di fronte ad una totale rimozione dell’elemento temporale (e spaziale), non essendo nessuna delle missive raccolte in questo carteggio preceduta dall’indicazione della data (e del luogo) in cui è stata composta. E ciò non per una sorta di aristocratica idiosincrasia nei confronti di tutto quanto ricada al di fuori della costellazione del “letterario” stricto sensu. Al contrario, nelle lettere, il dialogo a distanza intorno ai grandi snodi poetico-filosofici, conosce momenti di pausa, intermittenze gioiose in cui l’accenno alle garbate liturgie domestiche si alterna a confidenze sugli acciacchi di salute, a brevi incursioni nella sfera degli affetti familiari, al resoconto dei rari incontri suggellati da festose (e gustose) riunioni conviviali: piccole aperture su una quotidianità pronta a dispensare gioie furtive, attimiche, solo a patto di non ridurla a rifugio, porto sicuro in cui approdare finalmente, in quiete, dopo i lunghi viaggi compiuti lontano, spogliandola del suo carattere segreto di “epifania”, di “sorpresa”.
Non per nulla, il dialogo epistolare fra i due sodali «più o meno» ammalati di scrittura, si innesca su un verso di una poesia di Friedrich Hölderlin, Die Aussicht (La veduta o La speranza, come traduce Vito Ponzi), anzi sulla traduzione che Angelo Lumelli ne propone in Verso Hölderlin e Trakl, il libro galeotto, la lettura del quale ebbe il merito di destare l’interesse di Ercolani nei confronti del suo autore, come Ercolani stesso dichiara nella prima lettera del carteggio. Una traduzione che, a differenza di tante altre, inclusa quella, recentissima proposta da Giorgio Agamben, disloca l’asse dell’attenzione, dal concetto di ’”abitare” (della vita), al suo contrario – l’”essere lontano” – stabilendo un legame ossimorico fra due significati opposti, tale da provocare un cortocircuito o «il collasso di un grande significato, temibile», come si dichiara nella Letterina al lettore a proposito della traduzione lumelliana di questo verso di Hölderlin. Ecco, allora, che il verbo abitare, una volta deposta l’accezione originaria sostenuta dal sensus communis, che ne fa un sinonimo di protezione, esser protetti, finisce per slittare nel campo semantico opposto, e acquisire l’altro senso: abitare nella non-protezione.
Ma se abita (la vita) nella non-protezione, allora «abitare significa essere fedeli e sperduti, in un luogo senza mappa, lontano come un punto» (Ottantacinquesima lettera, p. 127), in uno spazio non molto dissimile da quel guazzabuglio, da quei disegni e scarabocchi – “schizzi dell’immaginario” – a cui Ercolani, sulla falsariga di Nietzsche, ricorre in questa missiva per suscitare, quasi a colpi di piccoli shock, l’idea della sua città, Genova, dalla bellezza magica così intimamente legata alla sua conformazione labirintica, «mai uguale a se stessa», dove quel poco che trapela, ogni tanto, dal nocciolo riposto del segreto, è un’epifania in grado di sconvolgere, perché sempre inattesa – uno shock. «Città per nomadi e ossessionati. Nicchia per poeti, dove stare dentro pareti circondate dall’aria che non formano una stanza chiusa ma un luogo forato dai venti» (Marco Ercolani, Nottario, I Quaderni del Bardo, 2023, p. 12), la cui “identità più segreta” «è proprio quella di restare luogo che favorisce l’eccitazione, l’astrazione, la fantasticheria, iscrivendosi nella mappa di un “fantastico” reale», Genova, «vicoli, scogli, odori», è il confine magico (l’Aperto?) in cui «il “sogno di una scrittura” smette di essere sogno irreale, paradiso remoto, e si fa pagina vera, traversata da incubi, verità inattuale che l’artista ha il dovere di mettere in luce dopo esserne stato assalito. Abita la vita ed è lontana …» (Ottantacinquesima lettera, p. 127). Il discorso sul luogo (su questo luogo) si sposta immancabilmente sul territorio limitrofo del lógos, il linguaggio (la scrittura), non come strumento di affermazione (e di una conseguente appropriazione), ma come luogo di una negatività che, per Hegel, inerisce all’uomo in quanto è il parlante e il mortale. È la Nichtigkeit – l’indicibile – che, per lo Hegel della Fenomenologia dello spirito, il linguaggio custodisce in sé, ben più gelosamente di quanto non fosse in grado di fare il silenzio dell’iniziato nei versi di Eleusis, la poesia dedicata dal giovane Hegel all’amico Hölderlin e probabilmente composta sotto il suo influsso.
La lettera ottantaquattresima di Lumelli, che precede quella di Ercolani, scritta ancora nel fresco ricordo del recentissimo incontro a Genova, è interamente dominata dall’incanto del negativo, pervasa dalla musica notturna, lunare di quel verso hölderliniano – Abita la vita ed è lontana – che apre e suggella, come si è visto, la replica di Ercolani, il quale lo riceve, quasi devotamente, dalle mani del suo amico e donatore, per poi restituirglielo arricchito da un sovrappiù d’ombra e di luce. Mantra e pernio incantato intorno al quale ruota l’intero carteggio fra i due sodali, o tema musicale ripreso e sviluppato in infinite variazioni, questo verso è la formula magica in grado di sprigionare quel fascino della Nichtigkeit di cui Hegel, sempre chiamato in causa, sempre convocato, a fianco dell’ex sodale Hölderlin, nel cerchio incantato di questo epistolario, è stato insieme l’interprete e il custode, ma anche l’elemento mercuriale – il solve – in grado di sciogliere l’intero, di fluidificare e dunque di ristabilire il principio del movimento (e della follia) in ciò che è immobile. C’è una beatitudine in questo negativo, di cui Lumelli, nella lettera ottantaquattresima, che trae spunto dalla visita recente a Genova, invita a delibare le dolcezze grembali, seguendo, anzi, assecondando le forze della dissoluzione liberamente (e festosamente) scatenate.
«Genova, Genova!… la folla di ogni cosa, folla di muri, di intonaci, di tinte sbiadite, di lastricati, di pietre scure, di cieli, di fessure, folla di folla… era tanto che non vedevo una città… che non mi sentivo un alveolo, beatitudine del negativo, subito ricompensato… cose che mi sollevano come in altalena… non in concorrenza, senza urti… Mentre andavamo verso Via dei Giustiniani, guardavo le persone con una strana approvazione e gratitudine, la stessa, ma senza irrisione, che descrive il narratore ne La vecchiaia del bambino Matteo – quando s’accorge di ringraziare tutti i viventi che vede passare – era a Milano in Piazza XIV Maggio a bere Martini, a guardare – situazione non priva di comicità, come chi attribuisse, soprattutto agli sconosciuti, la prova della propria esistenza, in negativo, lastra impressionata da qualunque cosa. Ecco, c’è una dolcezza nel negativo, nella voragine della vita da dove risale l’aspirazione al contatto, al parlare, la strana emozione di salutare la persona sconosciuta in un vicolo troppo stretto, cosa che, fortunatamente, può succedere a Genova… con riserbo, sfiorando l’antica piaga, la malinconia di chi, simile, è passante… Sentimenti del genere mi hanno invaso, di nascosto – o non troppo – mentre ero così contento di stare con voi – ma voi non eravate il positivo dell’altro, eravate contaminati da una somiglianza, da una fiducia, pur con discrezione, come negativi che s’alleano, che possono festeggiare… » (pp. 122-123; il corsivo è nostro).
La folla – di muri, di intonaci, di tinte sbiadite, di lastricati e pietre scure –, la “folla di folla” (non l’uno, ma i molti, o l’uno che si scinde nei molti come «una goccia d’acqua che batte contro una superficie – il testo – e da lì si espande in migliaia di gocce, ognuna delle quali, nella sua differenza, conserva la stessa identità della goccia madre», aveva scritto Ercolani nella lettera ottantatreesima, p. 121) da cui Cechov amava lasciarsi trasportare, quasi rapire, durante i suoi soggiorni genovesi; e ancora «gli intonaci, i rigonfiamenti dell’umidità (…), i grovigli di fili elettrici», la malva «fiorita a filo dell’asfalto» (lettera ottantottesima di Lumelli, p. 130): lo sguardo ipertrofico dell’osservatore flâneur, mentre passeggia per i vicoli angusti della città, vede ogni cosa. Nulla gli sfugge. Di più: egli non può fare a meno di vedere («a volte mi trovo senza forze, per il troppo vedere, il troppo continuo abbandonare, il troppo altro che mi chiama», ibidem), ma di vedere quasi con il bianco degli occhi, «in purezza, come un perpetuo apparire di qualcosa» (ibidem). Anche perché l’oggetto su cui si esercita questo sguardo visionario non è costituito dalle cose nella loro trionfante integrità (e inerzia), ma nel loro felice stato di carenza, cioè a dire, nell’istante della perdita, del trapasso (lettera novantaduesima), quel “transito” nel quale, come vuole Ercolani, consiste la poesia (l’esatto opposto dell’orto concluso, lettera venticinquesima, p. 50), e in cui è dato scorgere all’opera più scopertamente quel germe di morte e di trasformazione che, se da un lato ci mostra le cose come spoglia, rifiuto, in quanto prive di quella integrità in cui illusoriamente confidiamo, dall’altro ce le restituisce come rovescio meraviglioso (del visibile): l’incavo della ciotola che non attende di essere colmato, ma si ostina poeticamente nel sogno di un non ancora, nel vuoto pneumatico di un’attesa di cui nessun latte (celeste) può placare lo struggimento. Vedere “in purezza”, dunque, non come un’apparizione – phainómenon –, ma un perpetuo apparire – phainein – (e uno svanire) – «una foce, uno sciogliersi» (lettera sessantottesima di Lumelli) – ovvero l’affiorare festoso, attimico di qualcosa, mentre si sta inoltrando verso abbagliate Lontananze – oltre la siepe del visibile. Ma non è forse questo rifiuto, questa reliquia l’oggetto dell’offerta poetica, almeno nella visione di Lumelli, così devotamente impregnata del sogno hölderliniano dell’abitare lontano (della vita), e così propensa a delibare la joi che mai non fina “del negativo”, di cui Hegel è stato il magistrale iniziatore; del “suo” negativo che «è mancanza e, con ciò, un’offerta» (lettera ottantaquattresima)? «Ciò che resta (che avanza) lo fondano (lo offrono) i poeti (…). Un dono umile, inafferrabile», scrive Ercolani (lettera settima), interpretando, cioè portando altrove, il senso della traduzione del verso di Hölderlin proposta da Lumelli.
Hegel e Hölderlin, dicevamo: un sodalizio giovanile, successivamente rinnegato dal filosofo, che Ercolani sembra intenzionato a recuperare, mosso dal desiderio genuino di restaurare l’infranto, di ripristinare cioè, ricorrendo all’inganno felice dell’apocrifo, un dialogo che di fatto c’è stato, in un passato giovanile, poi ripudiato («Sono certo che scriverò un breve carteggio apocrifo Hegel-Hölderlin. Troppi, e gustosi, sono i temi. Quindi, ci lavorerò», lettera ottantaciquesima, p. 126). Per Ercolani – il quale può contare sull’appoggio dell’amico, sulla sua complicità nell’impresa – si tratta di portare a compimento un progetto ai limiti del possibile, sconfinante nel sogno, cioè di negare, con un colpo di mano, la negazione; di disconoscere quel ripudio che aveva fatalmente posto fine a una corrispondenza intellettuale e spirituale fra due tra le più prestigiose anime del Romanticismo europeo. Senza contare, che, prima ancora, si tratta di tentare un’impresa ancora più impossibile: negare la negazione per eccellenza – la morte –, superando, con un balzo all’indietro, le barriere temporali che si frappongono all’esaudimento del desiderio. Su questo punto, la posizione di Ercolani è sempre stata di una fermezza disarmante, avendo la sua scrittura come ragion d’essere e obiettivo primario il progetto, sentito come un “mandato”, sin dal principio ostinatamente perseguito, di negare la negazione, riconducendo la fine – ogni fine, anche (anzi, soprattutto) quella della vita umana – all’inizio, di individuare, nell’una, i segni germinali, mirabili, dell’altro.
(Come in questa lettera, in cui accennando alla sua personale esperienza di medico psichiatra, Ercolani scrive: «Curo malati remoti, non più guaribili, che per un attimo, nell’eternità dello scritto, non si sottraggono alla cura. Rispondono, ancora. A me piace molto che rispondano. Solo in quel momento mi accorgo che la morte non esiste e non è mai esistita (…), “Come vorrei finire le mie cose! Sarà magnifico come iniziare?”», lettera quarantanovesima, p. 83).
Ben più di una mera strategia finalizzata a garantire allo scrittore, mercé i buoni servigi della fama, una forma di precaria sopravvivenza oltre la morte, scrivere è l’unica l’opportunità di cui disponiamo per «trasformare l’impossibilità di vivere in possibilità di dire», come testimoniano le parole di Jean Starobinski opportunamente citate da Ercolani a mò di esergo nel suo Nottario, un libro germinato sullo stesso ceppo di questo carteggio, tante sono le consonanze fra i due testi, come se la linfa che nutriva l’uno avesse alimentato simultaneamente anche l’altro. Ma soprattutto, la scrittura è l’anello magico che salda i due estremi della fine e dell’inizio, o, più precisamente, come leggiamo sempre in Nottario: «è la “nostra” forma di congedo, niente di più. Un modo per essere sospesi fra morte e vita, in modo che né l’una né l’altra esistano» (p. 77). La scrittura si muove e opera in una direzione diametralmente opposta rispetto a quella della morte, soprattutto la scrittura apocrifa che, nella poetica di Ercolani, è l’unica via praticabile per ridare parola all’altro (il non più esistente), ma anche per parlare attraverso l’altro intrecciando un dialogo in cui l’io (dello scrittore) finalmente si sfalda, per accogliere e lasciar vibrare, una volta infrante le acque amniotiche, «tutte le voci dentro la sua, e la sua dentro le altre» (lettera ottantasettesima, p. 129).
«La scrittura apocrifa è l’atto di lucidità del raccogliere il testimone in una gara di staffetta in cui scorgiamo appena l’atleta precedente e ancora non vediamo quello successivo. Ma la corsa è in atto, e non si fa mai da soli. Siamo in tanti. Una squadra di vivi e di morti. La scrittura è un enigma, un fruscio di parole e basta. Quando riesco, riflettendo gli autori che amo, a trovare il fruscio giusto, convivendo con loro e creando io stesso le loro/ mie parole, vivo un senso di raggiunta familiarità, come se davvero nessuno fosse mai morto, e tutti scrivessimo ancora, senza un nome preciso, senza un’identità assoluta. Chissà: è forse questa la magia che desidero. Una comunità di artisti feriti, immuni dal tempo. Ogni opera reale è flusso interminabile, infinito bisbigliare di voci. Il libro è la fortuita emersione di una di queste voci alla coscienza della scrittura, un approdo momentaneo, un’isola instabile che ci permette di vedere, da una particolare inquadratura, il “libro impossibile” che continuiamo e continueremo a scrivere» (lettera settantacinquesima, pp. 112-113; il corsivo è nostro).
E ancora:
«”Non mettersi la maschera di un altro ma togliersi la propria”: dici con esattezza, Angelo, e il gesto svela il luogo dell’apocrifo, un luogo interno a noi, dove facciamo dialogare l’io e l’altro inventando cortocircuiti. Un luogo iniziatico dove non è necessario essere doppi ma è necessario accettare che ogni persona è polifonia da cogliere, da stringere. Questo accade se chi scrive non è appagato dalla sua scrittura ma sempre cerca nuove sfide, nuovi abbagli. La poesia è essere abbagliati, ingannati, ma illuminati. Ho speso la vita intera per non essere solo un io davanti alle sue ore che scorrono. Ma ti assicuro: la maggior parte dei poeti ha un ego così vasto che il mio “preferisco sparire” è visto con sospetto, addirittura come un atto di incertezza ontologica invece che per quello che realmente è: una hybris potente. Una hybris che vorrebbe far vibrare tutte le voci dentro la sua, e la sua dentro le altre. Calvino lo aveva capito bene, che tutti i libri sono apocrifi. Nel momento in cui l’io inventa una scrittura che trasfigura il banale resoconto di una anche nobile esistenza, inizia la sua Commedia, il suo Zibaldone, le sue operette morali, il suo don Chisciotte. Ecco: questa è la mia vita, la possibilità di contenere mille vite nell’eresia di resuscitarle ancora. L’apocrifo è la minaccia sferrata dalla scrittura all’io, il sonno che mette in pericolo le certezze della veglia» (lettera ottantasettesima, pp. 128-129; il corsivo è nostro).
Ciò che si realizza, favente somnio, è dunque un colloquio incessante, un’osmosi incessante in un luogo intimo e segreto, in un tempo segreto, di cui non è un caso il genere apocrifo sia scelto come garante e custode, se consideriamo che l’aggettivo apocrifo, oltre all’accezione semantica più nota, di falso, non autentico, racchiude nel suo calamo, la ricchezza seminale di un’ altra accezione. Un significato che coincide con il senso letterale, primitivo e dunque, a ben vedere, più vero, sebbene quasi nascosto anch’esso, quasi clandestino, che questo termine riceve, per grazia, dalle mani materne del lemma greco da cui discende: apókryphos, “occulto”, “segreto”. E forse è da qui, dalle vaste clausure del sonno, che affiorano, repentini, inaspettati, quegli allarmi gioiosi – “il suono del corno” a segnare l’inizio della caccia – che interrompono «la continuità dell’apparire» e che per Lumelli (lettera ventiquattresima) è il segno d’interpunzione, l’intervallo ovvero la Lichtung, “radura”, nell’accezione heideggeriana, a insinuare nel “continuo”, insufflandovi un vuoto pneumatico in cui può sorgere in-fine, come un’alba crepuscolare, il pensiero. Per Ercolani, il mandato non è, dunque, scrivere sic et simpliciter, ma «scrivere nel sonno» (Nottario, p. 109) – o piuttosto, in-somniis, in questo intervallo o transito, «luogo instabile, fluttuante», «luogo in metamorfosi», «che non rassicura nessuno» (lettera cinquantasettesima), ma che costituisce anche l’unica soglia o Lichtung, in cui possono insediarsi il pensiero… e la poesia.
**

