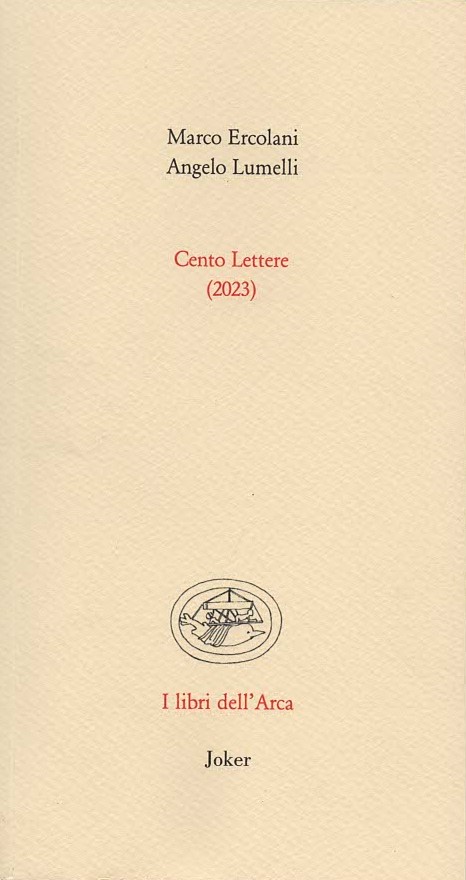
**
Qual il ruolo del poeta? Quello di servire a qualcosa, per esempio a rifinire una pagina bella? Nessun poeta serve a niente, neppure a questo, neppure se questo accade. E, se due di essi si incontrano e scrivono a quattro mani un libro, l’inutilità si duplica. Leggere Cento lettere di Marco Ercolani e Angelo Lumelli (I Libri dell’Arca, Joker, 20239 è come confrontarsi non con una sola vita sfuggente ma con due, irrevocabilmente disallineate, dove le parole non risolvono domande inequivocabili, come la necessità della poesia.
La sindrome di Stendhal è quello smarrimento che un’opera d’arte di grande intensità genera, in certe condizioni emotive, in un soggetto particolarmente ricettivo. Questo libro causa, nel lettore, una sindrome simile, perché ad ogni lettera cresce di intensità l’indagare dentro di sé e dentro l’altro, alla ricerca di qualcosa di incerto, benché gli autori non abbiano nulla da dire. Questo carteggio sembra disperdersi in una detection senza delitto, come in un film di Altman più audace degli altri, dove il concertato delle voci non sviluppa né una cantata profana né una commedia risolta. Questo carteggio si smarrisce nella sua libertà di esistere. Continua a rappresentare l’atto del denudarsi, del capire, indugiando sui dettagli (linguaggio, poesia, autobiografia), rallentando o accelerando i tempi. Ma alla fine non accade nulla perché davvero non c’è niente che debba accadere. L’abisso corteggiato dalle parole è senza alcuna forma e nessun occhio può afferrare ciò che rappresenta. Ma una via c’è, per il lettore: non essere soltanto dentro il libro, ma camminare dentro e fuori di esso. Chiunque cammini non vede sempre lo stesso foglio, non rischia di diventarne vittima; semmai è un nomade che abita le tende del suo deserto, una creatura – in questo caso, doppia creatura – che vive pronta a lasciare la vita.
