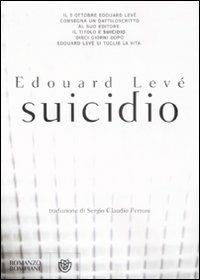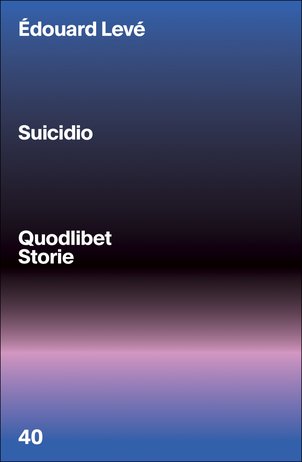Marco Sbrana, Leggere Suicidio di Edouard Levé tramite Jacques Derrida.
**
Un sabato d’agosto esci di casa in tenuta da tennis insieme a tua moglie. Mentre attraversate il giardino le fai notare che hai dimenticato la racchetta. Torni a prenderla, ma, anziché dirigerti verso l’armadio dell’ingresso dove la tieni di solito, scendi in cantina. Tua moglie non se ne accorge, è rimasta in giardino, c’è bel tempo, si gode il sole. Dopo qualche istante sente un colpo d’arma da fuoco.
In Suicidio di Edouard Levé, l’Io narrante sarà in eclissi quasi costante; soggetto sarà il Tu. Accettando questo patto narrativo, la seconda persona singolare diventerà, quasi preriflessivamente, una prima persona singolare.
Non è un Tu universalizzato come quello di Perec, il lettore avrà un narratore in prima a cui appigliarsi, quantunque a intermittenza; ma il Tu guiderà. Svolgerà funzione di protagonista, di personaggio principale, di “colui cui accadono la maggior parte delle cose”; a un tempo sarà specchio del narratore, che intavolerà la conversazione evocando l’amico con la parola, col solo atto di nominazione, col solo riferimento, con il solo Tu.
E così, in un certo senso, lo riporterà alla vita.
È la parola, per l’appunto, il primo dei tre assi tematici individuabili. La nominazione – o meglio, la possibilità di essere nominati, di essere detti – garantisce esistenza.
La linguistica ci dice che la parola è (sempre) nominazione di un’assenza. Anche quando dico tavolo e ho un tavolo vicino, non c’è totale sovrapposizione tra significante e referente. La parola eternalizza, dicevamo. Siamo immortali fintantoché significanti in un discorso.
Per capire l’opera di Levé, è utile riassumere il pensiero di Jacques Derrida. La verità – secondo il filosofo – per essere tale deve poter essere iterata; l’iterazione della verità, pure, implica il tradimento della verità stessa. Non ci sono significati presenti a sé stessi, dice Derrida, com’è il mondo un insieme di segni (“tracce”, le chiama Derrida) che seguono come sola regola quella del differimento, inteso come scarto e inteso come rinvio, e quindi différance. Il gioco delle tracce “riduce” l’uomo a parola, possiamo dire. Il soggetto non è presente a sé stesso ma si costituisce come effetto retroattivo del linguaggio, è prodotto dal linguaggio (non lo produce): dal linguaggio scaturisce l’Io. Che esiste come effetto di significazione, come luogo instabile in cui il senso si produce e si differisce, e non come centro originario o padrone del significato.
Paragrafo nocivo al ritmo ma – ad avviso di chi legge – necessario. Perché la filosofia sottesa a Suicidio è quella di un linguaggio che precede l’essere parlante.
L’Io di Suicidio si rivolge a un’assenza che esiste come traccia. Verrà detto anche all’interno del testo: sopravviviamo fintantoché siamo detti, fintantoché il significante circola nella rete semantica. È un concetto di esistenza naturalmente “lato”, ma non per questo meno vero, se decidiamo – e forse è il caso – per un agnosticismo nei confronti del “vero” significato di esistenza. Soprattutto, un testo narrativo pone le sue regole; le regole di Levé sono quelle di un linguaggio capace di eternalizzare con la sola forza della nominazione. La morte, insomma, non implica la fine della comunicazione.
Siamo circondati da angeli con cui parliamo; loro – tremendi, come dice Rilke – non condannano e non assolvono – tacciono.
Il gesto di Levé nel nominare, nel conversare, nel tracciare l’amico morto è già uno scagionarlo, riabilitarlo. È già letteratura come mezzo di resistenza alla morte. Non monumentum che sopravvive; partecipazione al summenzionato gioco delle tracce, invece. L’Io narrante parla a. Questo basta e avanza: l’interlocutore, benché muto, in qualche modo, è.
Ci siamo allontanati dal testo per fornire una cornice concettuale in cui discutere degli altri due assi tematici rinvenibili.
Il primo si collega alla visione derridiana del mondo. È la vita che, alla luce di un evento, si risemantizza e diventa archivio di indizi sull’evento stesso. Suicidio è in larga parte archivio di elementi biografici che, per l’Io narrante, sono diventati segnali – a posteriori. Vedremo nel dettaglio come piccolezze ricordate illuminino, agli occhi del narratore, il gesto dell’amico.
Il terzo asse ci fa tornare alla filosofia: il suicidio apre infatti al narratore un ventaglio semantico immenso.
Archivio, dunque.
Nei tuoi occhi non c’era lo sguardo assente e triste che avevi di solito durante le riunioni mondane,
nota il narratore. Perché bisogna notare. La morte, che tanto è radicata nell’uomo, non può essere insondabile; vogliamo la causalità, l’imponderabilità non può confarsi a qualcosa di cui, come nel suicidio, siamo agenti. E dobbiamo notare notare notare – tale l’ossessione luttuosa per il defunto. Il non accettare porta a redigere schede che possano accogliere parametri, funzioni, x. Affinché un suicidio – che è atto – non ci sfugga.
Non eri un esibizionista, ma la morte che hai scelto esigeva che ne stabilissi luogo, tempo e modo. Per ottenerla sei stato costretto a metterla in scena.
E poi, amico, ti conoscevo,
Eri più onesto che cortese,
e ricordo che
D’estate, al mare, prendevi il catamarano e navigavi in solitaria. Drizzavi le vele e puntavi dritto davanti a te. Perché bordeggiare, se l’acqua era sempre la stessa? Ti si addiceva di più la linea retta.
Mi dispiace, ma certuni la vita ce l’ammazzano,
Eri convinto ti avessero desiderato meno per ciò che eri che per ciò che immaginavano saresti stato,
e con te è morto il ventaglio di futuri possibili.
In Levé non c’è pietismo. Scrive in paratassi: brevi le frasi, ed essenziali, insomma Carver. Ma più asciutto ancora, se possibile, certo più crudele. La prosa può ricordare quella di Agota Kristof. Sa bene, Levé, che il grido di disperazione risuona più forte quando è posato. Quando la forma dell’orrore tocca l’asettico senza perdere in temperatura, quasi sempre abbiamo di fronte un lavoro artistico alto. Kristof, sì, ma anche Beckett. E Bernhard, ovviamente. Si può parlare anche di atto comunitario e, nel senso più puro, di “servizio” al lettore: non è infatti, quella di Suicidio, una disperazione che grida da sola in una stanza – l’autoreferenzialità – ma è una disperazione che ha trovato forma, e che può infettare. E infetta con la sua compostezza, con la sua eleganza.
E dunque l’amico è morto. L’amico è stato, l’amico non è più.
Il suicidio induce i rimasti a interpretare la vita del defunto alla luce del gesto estremo. Ovvio. Sicché il suicidio è scaturigine di significati inediti, come dice il narratore qui
Il tuo suicidio è stato la parola più importante della tua vita, ma non potrai coglierne i frutti.
Sei morto, dato che ti parlo?
e qui:
Il tuo ultimo istante ha cambiato la tua vita agli occhi degli altri. Sei come l’attore che, alla fine della rappresentazione, con un’ultima parola rivela di essere un personaggio diverso da quello che ha interpretato.
Ma il suicidio è anche atto di conoscenza. Estremo atto di conoscenza, perché, in onore del percepito, il percipiente si esautora:
Non hai negato la vita, hai affermato il tuo amore per l’ignoto scommettendo che […], ammesso che esistesse qualcosa, sarebbe stato meglio di qui.
Pensiero del e sul lascito. Il Tu di Suicidio si è colmato la vita di emozioni, quelle emozioni che mai ha sottovalutato
[…] avevi riempito quegli istanti con sensazioni tanto più forti in quanto niente e nessuno te ne aveva distratto.
Ti sei destinato una violenza che non hai mai avuto per gli altri, cui riservavi tutta la tua pazienza e la tua tolleranza.
E poi la poesia finale, che chiude il libro. Forse, di quello che non si può dire, si deve cantare. Parlare non può Tiresia, ma cantare parole senza senso: è la lirica.
Il tempo mi manca
Lo spazio mi basta
Il vuoto mi attira
[…]
Nascere mi succede
Vivere mi occupa
Morire mi completa
Levé aveva quarantadue anni quando consegnò il manoscritto; tornò a casa per impiccarsi. Come accadde da noi per Morselli, Suicidio produce una risemantizzazione a posteriori in virtù della biografia dell’autore, che in questo caso sarebbe stupido ignorare. Suicidio è un gioco di specchi che Levé conduce con qualcuno che ammira, che ha avuto il coraggio di fare ciò che Levé non aveva (non ancora) fatto. Suicidio è la possibilità di parlare di un altro per descrivere i propri ultimi attimi. Suicidio delega la vita alla letteratura ma come comunicazione, come rete di significanti (e torniamo all’excursus, credo appropriato, su Derrida) di cui non importa il referente (del resto, cosa designa “Amleto”?), perché il significante ha egualmente senso fintantoché detto.
Degli angeli, dice Rilke nella prima “Elegia Duinese” ciascuno è tremendo. Ci turba il loro silenzio. Ma una conversazione non prevede, per avvenire, che l’interlocutore risponda. E cosa saremmo senza le lunghe chiacchierate con i nostri angeli privati? Non saremmo niente e Suicidio ci ricorda – performando – che altro non è il mondo che una sterminata necropoli dove, qua e là, spuntano corpi il cui cuore è destinato a fermarsi.
**
Édouard Levé (1965-2007), fotografo, artista, scrittore, ha pubblicato Œuvres (2002), Journal (2004), Autoportrait (2005), Suicide (2008).